Santarcangelo Festival 2050-2021 è stato caratterizzato da una sezione, Interzone, in cui sono stati inseriti, tra gli altri, i dispositivi degli artisti Muta Imago, Romeo Castellucci e Sophie Guisset. Una riflessione
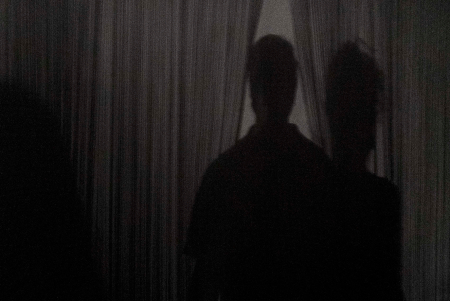
Da anni la mia ostinazione a non leggere anticipatamente le sinossi degli spettacoli è sempre stata foriera di imprevedibili eventi, laterali e amplificatori dell’evento stesso. La totale impreparazione può da un lato favorire una permeabilità maggiore, una disposizione non preparata e sprovvista di impalcature informative; dall’altro, può determinare una resistenza istintuale, anche questa imprevista, alla quale si può reagire con accoglimento o, in alcuni casi, addirittura rifiuto. «Lo spettacolo è sconsigliato a persone che soffrono di epilessia e cardiopatia, a causa dell’utilizzo di luci stroboscopiche e suoni molto forti». Anche questo, non avevo letto. Ed è un’indicazione utile che appare nel programma di Santarcangelo 2050-2021 Futuro Fantastico II movimento per ben due progetti da me esperiti, Sonora Desert di Muta Imago e Il Terzo Reich di Romeo Castellucci. Nota informativa che io non leggo né per il primo, né per il secondo. Alla mia strenua volontà di impreparazione segue poi un’accurata documentazione, lo studio attento a comprendere l’opera fruita all’interno di una sua necessità contestuale, e programmatica anche. Mi accorgo infatti che entrambi i lavori, ai quali si aggiunge anche Plus One di Sophie Guisset di cui parleremo successivamente, sono inseriti in una sezione del festival chiamata Interzone, facente riferimento a «progetti che ibridano forme e codici differenti generando opere eclettiche, in relazione simbiotica con il cinema». E questa conoscenza post esperienziale mi piace, continua a convincermi del mio vizio e sopratutto solletica la mia curiosità, anche in maniera retroattiva.

«Vorremmo che il Festival fosse fatto e visto con gli occhi di un gatto o quelli specchiati di un pesce o di un cefalopode… vorremmo imparare a essere presenti e silenziosamente accoglienti, in osservazione, in apprendimento, con quella estraneità che la selvatichezza animale porta intrinseca e sacralizza». Così leggiamo nella dedica che apre il programma del festival, un racconto in prima persona dei direttori artistici Enrico Casagrande e Daniela Nicolò in cui salutano questi due anni di «cura», e non curatela come sottolineano, passati «nell’ambra del momento» del 2020 al «mutaforma» di quest’anno, «shapeshifter», a ribadire proprio quella tensione interspecista, quella possibilità di diventare, naturalmente e organicamente, altro. La cura per gli «atti artistici», intesi come gesti e prese di posizione nel mondo, si riscontra nelle tre opere analizzate in questa sede, e che sensibilmente coinvolgono la temperatura percettiva del singolo individuo, colto proprio nella sua specificità animale.

E come animali, con selvatichezza, reagiamo. Dopo essere stati chiusi per mesi in cattività, esclusi dal contatto con i nostri simili, dovendo badare a noi stessi nell’isolamento. «Sparire dal mondo, per provare a sparire dentro se stessi. Nel cuore di questa valle, la NOTTE. Non c’è più il tempo e lo spazio. C’è solo un presente assoluto e ne faccio parte in pieno, con tutto il corpo e la mente». Non possiamo rimanere indifferenti a questa confessione, ci colpisce la scrittura diaristica di questo «sabato 11» di cui non sappiamo né mese, né anno. Ci ferisce e inquieta questo foglio appeso in una camera di passaggio del dispositivo installativo Sonora Desert di Muta Imago, costruito nella distante, isolata e immersa nella campagna, Villa Torlonia, fuori Santarcangelo di Romagna. Il progetto pensato negli ultimi tre anni da Claudia Sorace e Riccardo Fazi, coadiuvato da uno scrupoloso lavoro di ricerca testuale e di drammaturgia sonora e visiva, si ispira a un viaggio compiuto nel Deserto di Sonora, al confine tra l’Arizona e il Messico, dove la temperatura raggiunge i 51°, «il cielo è uniforme, di un celeste che in alto diventa blu» e in cui «non si riesce a stare fuori dalla macchina per più di 5 minuti. Si rischia di sparire nel vero senso della parola». Questa installazione contemplativa del duo romano – che è anche concerto, con le musiche composte da Alvin Curran, rituale e performance sonora – scava, sin dal benvenuto datoci dalle guide Chiara Caimmi e Francesco di Stefano, subliminalmente nel nostro inconscio, determinando una graduale e profondissima immersione dei sensi e amplificandone la ricezione: «Non c’è confine, qui, tra me e quello che mi circonda. Non c’è distanza, non c’è separazione. È come il sonno (…)». Proprio nel secondo movimento di questo dispositivo, quando veniamo accompagnati a entrare in una sala al buio, a distenderci su delle amache, a indossare dei filtri sugli occhi e a lasciarci guidare dalle frequenze sonore e luminose, ecco che nell’istante dell’abbandono, il mio corpo invece, in maniera del tutto incontrollata, si alza agitato e ricerca la luce, scappando così da quella richiesta di distensione che lui in quanto corpo, e quindi non il mio “io” cosciente, rifiuta. Esco allora, perché non potrei fare altrimenti, per entrare, in anticipo rispetto al resto del gruppo di visitatori, in quella stanza di decompressione e di risveglio in cui Claudia (Sorace) mi versa una tisana e con lei parlo di quello provato fino a quel momento, di come nonostante il mio istinto abbia interrotto l’accadimento performativo, io sia ancora immersa in quella dimensione. Mi sento intrisa delle parole scritte e lette nella prima stanza, delle immagini vividissime che queste mi hanno trasmesso, del deserto, del nulla entropico, della luce e del calore, della sensazione quasi scottante di quell’energica fine che sottende alla nostra esistenza. E non posso fare altro che dare libero sfogo al bisogno irrefrenabile che ho di esplicitare verbalmente tutto ciò che i miei sensi stanno provando. Nel mentre, vedo uscire il gruppo di spettatori dalla stanza, il pullman ci è venuto a riprendere, lascio quel luogo, cerco allora di ristabilire un controllo dei miei impulsi, un’aderenza materiale al reale circostante. Un torpore mi avvolge, mi sento stanca.

Nellospazio (nome dato a uno degli habitat del festival corrispondente al Parco Baden Powell) circondati dai suoni martellanti di Scott Gibbons, quasi fossimo partecipi di un rave party nel quale siamo però costretti seduti al nostro posto, veniamo sommersi per più di un’ora dalla visione di una sequenza lunghissima, che inizia lentamente per poi accelerarsi, di parole proiettate su un enorme schermo nero – tutti sostantivi, non ci sono verbi che rimandano quindi ad azioni – ognuna delle quali sembra essere generata da una matrice che le ordina in successione e, a seconda della sua lunghezza visiva, viene associata a una precisa lunghezza di suono (consulenza informatica Alessandro Colla). Non succede altro, anticipato da un prologo in cui la coreografia interpretata da Gloria Dorliguzzo vorrebbe fungere da iniziazione al rito ma in realtà si annulla nella preminenza del mezzo installativo ideato da Romeo Castellucci dal titolo Il Terzo Reich, con il quale ha inaugurato il quadriennio da Grand Invité alla Triennale di Milano, nell’ambito della rassegna FOG Performing Arts. Annichiliti, “imboccati” dalla meccanicità sovrastante e totalizzante delle parole, restiamo in silenzio, a ricoprire il nostro ruolo di astanti, costretti per catatonia alla lettura, istinto del resto involontario in quanto non possiamo impedirlo all’occhio che guarda e al cervello che rielabora. Vorremmo poi conoscere chissà, attraverso un consulto neurologico a fine spettacolo, quanti e quali termini abbia selezionato la nostra capacità retinica e mnemonica perché, anche se nell’apparente passività alla quale siamo costretti, abbiamo percettivamente operato una scelta. Tuttavia, restiamo inconsapevoli di questa re-azione sommersa: come nelle parate propagandistiche orchestrate dal ministro Joseph Goebbels e riprese dalla regista Leni Riefenstahl, siamo stati caoticamente soggiogati dalla comunicazione mediatica, ricorderemo semmai una decina di parole, non di più, impresse nella corteccia visiva; le altre invece, la maggioranza, nel caos le avremmo conservate per assimilazione indotta ma senza coscienza alcuna.

«Per uno spettatore alla volta» è l’indicazione del terzo lavoro preso in oggetto, Plus One dell’artista e performer residente a Berlino Sophie Guisset, facente parte anch’esso della sezione Interzone. La dicitura relativa alla specificità di fruizione comporta una preparazione altrettanto specifica: sai sin da subito che il rapporto con l’opera sarà esclusivo. In questo caso, non solo con l’opera stessa ma anche con l’artista presente e alla quale ti siedi vicino davanti a un puzzle scomposto. Da sole, nel sottoscala della Scuola Pascucci, facciamo conoscenza, in lingua inglese, poi mi versa un bicchiere d’acqua e mi chiede di aiutarla a comporre il puzzle, per Sophie «un’attività centrale, una sorta di fuga mentale durante il lockdown». Nel mentre, a turno, peschiamo entrambe una carta dal mazzo sul tavolo e rispondiamo alle domande che vi compaiono. Sono questioni dapprima generiche poi più intime, che ci danno la possibilità non solo di conoscerci vicendevolmente nella breve durata della performance (30’) ma di scendere un po’ più a fondo nella percezione di noi stessi, scoprendoci sicuri per alcune affermazioni, dubbiosi e incerti per altre. Una dimensione anche questa liminale, in cui viviamo di una temperatura erotica non solo formale – la ricerca del giusto pezzo che possa comporre il puzzle e rivelare l’immagine celata e verso la quale è tesa la nostra curiosità – ma anche contenutistica. L’immagine del puzzle rappresenta infatti una scena pornografica scattata in un parco a Berlino e realizzata dal cineasta porno Goodyn Green e 5 performer: «concentrare il nostro sguardo su un’immagine, un’immagine di natura sessuale, e dover comunicare il contenuto di quell’immagine libererà il nostro discorso, e creerà un’atmosfera intima, rafforzata dalla nostra prossimità fisica (ma protetta)».

Percettivamente, non ci sentiamo affatto protetti invece. Prendendo parte a tutti e tre i lavori, tanto quello di Muta Imago, di Romeo Castellucci e di Sophie Guisset, e seppure nella loro diversità di fruizione, siamo certi che il nostro ruolo di spettatori sia stato sollecitato nella sua intimità, la quale ha subito inevitabilmente un’ingerenza. Che qualsiasi atto artistico sia di per sé un atto di stravolgimento è assunto stratificato, ma l’alveo di protezione nel quale viviamo e fuori dal quale decidiamo di lasciare qualsiasi agente esterno che possa turbarci, acuito sinteticamente in questi due ultimi anni, è stato, nei tre casi studio, definitivamente compromesso. E di questa alterazione ne conserveremo il segno, in nuce soggiace la sensazione dalla quale deriveranno altri mutamenti e cresceranno ulteriori sinestesie di sensi, intellettivi e animali. Dopo aver conosciuto lo shapeshifting voluto e costruito dalla direzione dei Motus, ci avventuriamo con esperienza nei prossimi anni, attivando nuove posture e innesti, transizioni e fluidità, rimuovendo sempre di più la posa da spettatore e facendo sì che questa sia sostituita dagli atti singoli degli individui inseriti però nella collettività della piazza/mondo/ambiente. Se la percezione è effimera e mutevole, la cui traccia può sedimentarsi a distanza di tempi distanti dal presente e poi tornare successivamente, chissà nel futuro come guarderemo, e ci guarderemo, con gli occhi di quali nuovi “animali umani”.
Lucia Medri
SONORA DESERT
regia, luci, scene Claudia Sorace / testi, ricerche e drammaturgia sonora Riccardo Fazi / musiche originali Alvin Curran / direzione tecnica, realizzazione scene e luci Maria Elena Fusacchia / assistenza alla direzione tecnica Simona Gallo, Camila Chiozza / guide Chiara Caimmi, Francesco di Stefano / organizzazione Martina Merico / cura Ilaria Mancia / da un’idea di Glen Blackhall, Riccardo Fazi, Claudia Sorace / produzione Muta Imago / coproduzione Teatro di Roma, Fondazione I Teatri Festival Aperto di Reggio Emilia / con il sostegno di Azienda Speciale Palaexpo, Mibact.
IL TERZO REICH
installazione di Romeo Castellucci / suoni Scott Gibbons / coreografia e interpretazione Gloria Dorliguzzo / realizzazione video Luca Mattei / consulenza informatica Alessandro Colla / produzione Societas / © SRS.
PLUS ONE
di e con Sophie Guisset / in collaborazione con Est Coulon / drammaturgia Lisa Vereertbrugghen / suono Diana Dobrescu / immagine del puzzle creata in collaborazione con Goodyn Green / con il supporto di Bâtard Festival, Garage 29, Buda Kortrijk, Workspace Bruxelles.












