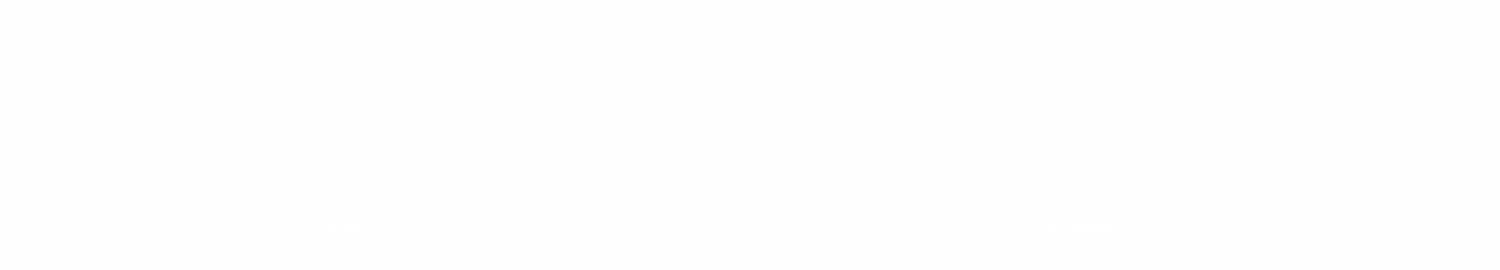Primo reportage dalla Biennale Danza di Venezia – quest’anno con un programma ‘olimpico’ (e olimpionico…), pieno di danza d’ogni tipo, e per tutti i tipi di pubblico (che sempre cambia, però, e non è detto che sia un bene) – nella necessità di meglio mettere a fuoco visioni e questioni.

Non appena muoiono le luci, in quell’istante di passaggio prima dell’inizio, ecco che si inforca, non visto, un paio di occhiali da vista. Mentre nessuno lo vede, quando la performance sta per iniziare, con malcelato pudore. Hanno una montatura sobria, leggerissima, invisibile. Di nessuno stile, ma nella piena utilità della loro funzione: la messa a fuoco dei fantasmi della sua cronologia. Tanta prepotente irruzione del principio di realtà a me, confesso, ha proprio stretto il cuore. Di forte simpatia. Una immediata empatia. L’ardore di un vero affetto. Questo ragazzone sempre-giovane, liscio da sempre come un neonato, è fra i coreografi meglio pagati (si dice) al mondo e pure di recente nomina a baronetto del (nativo suo) regno; in fondo questi cinque lunghi, lunghi anni di Biennale Wayne McGregor se li porterà pure un poco sulle spalle. E a pensarci ora, fatica per fatica, come sarebbe pure interessante oggi una programmazione dedicata alla miopia della visione, alla violenza del tempo che scivola via, alla propaganda dei discorsi così in voga sull’imperituro (per sorvegliare e occultare «guaj e guasti» del transitorio). Piuttosto che questo Olimpo Globale di Miti, largo quanto un menù per tutti i gusti e le età, non senza premi maggiori al mainstream internazionale, e con almeno una performance engagée di cui tutt* parleranno, con anche un po’ di folklore, spiritualità, il posto d’ufficio ai nativi, e il botto finale col Gran Visir di Spagna. Insomma, la varietà di un programma da villaggio turistico che in fondo è stato Myth Makers. (Ma che avrebbe poi anche tutte le sue buonissime e giustissime e condivisibilissime ragioni ideologiche, se costruito in forma fortemente critica, in questa Venezia da perenne crociera, dove trovi tutto purché la strapaghi, quando anche i gioiellieri rabbiosi tasserebbero chi non compra…).

Myth Makers è stato dunque il titolo/tema onnicomprensivo della Biennale Danza di quest’anno, dai grandissimi numeri, e dai fiumi di pubblico, e dall’illustrissimo sponsor. Eppure, insisto, le ragioni più necessarie di McGregor, proprio in quel decente suo ritegno nell’inforcare le lenti sul primo buio della sala, per vedere meglio e coprire la distanza, per essere capace lettore del proprio lavoro, e quindi testimone all’altezza del proprio tempo, tali ragioni pretenderebbero, io credo, tutt’altro. (Abbassate i fucili: è solo un racconto, un mio personale mito, aiuta a sognare, e a riflettere).
Torno dopo due anni di assenza (non mia, della danza) in Biennale come un vero e proprio ritorno apotropaico. Qui in effetti ci sono gli spazi più belli, qui in passato abbiamo visto tutto, moltitudini di spettatori hanno allenato e sprovincializzato lo sguardo, capito il contemporaneo in danza, generazioni diverse hanno anche danzato per le calli e i campi, nei quattro anni di Virgilio Sieni, in un esercizio di democrazia del corpo e del gesto che non doveva dirsi poetico per trasformarsi in politico. Paolo Baratta (imperituro presidente di allora) ne era estasiato. Ma anche confuso: uomo ormai di altri tempi, coltissimo e navigatissimo, aristocratico caparbio timoniere, eppure in fondo testardo, dunque provinciale (nel senso di Longanesi, sia mai…), egli cambiò rotta. E impose logiche internazionali di corta visione, che ancora perdurano e perdureranno perché di pronta cassa, facendoci perdere, in fondo, soltanto tempo. Tanto tempo, in realtà: se contiamo le quattro rassegne minimali della canadese Marie Chouinard, e le sei, con quella prossima, molto brandizzate e quasi seriali di Wayne McGregor (che fu scelto da Roberto Cicutto), sono già dieci anni. Senza significative ricadute per il sistema danza italiano, che qui proprio diserta: non si incontra nessuno. E sono ben due generazioni perse di giovani: quasi un sabotaggio delle ragioni della felicità. Solo resta una mera ratifica del presente, che è sempre un poco differente da sé perché eternamente uguale: esattamente proprio come il Mito, appunto.

L’avvio del programma purtroppo è dei meno azzeccati. Chunky Move dall’Australia catapulta un impegnativo armamentario scenico all’Arsenale, di cui poco poi fa uso, e lì rimane inesploso nonostante sei performer si arruffino a collegare e scollegare e manipolare protesi e arti artificiali come in un can-can da matinée. A partire dal macchinoso titolo U>N>I>T>E>D si poteva intuire però l’esile portata di tanta impresa, le brevi sequenze di danza sono piene di impaccio e riempitive, mentre la drammaturgia prevederebbe una trasformazione ‘spirituale’ «degli esoscheletri robotici» (roba da sassate: chiedo pazienza a chi di dovere, perché con queste proposte è già tutta una strada spianata…). Qui macchina e tecnologia non dànno vita ad alcuna mitologia, solo alimentano un’estetica cyborg vecchiotta, che non incontra mai una qualche riflessione sui corpi che vi si aggregano (alla mia destra Maria Paola sbotta: roba da videogiochi!, mentre Renzo, a mancina, colora subito un suo disegno, di gran lunga più genesiaco del suo modello). Qui il vero mito è Elisa Guzzo Vaccarino che nel talk post-performance del debutto con il coreografo Antony Hamilton, fa dire apertamente quel che non si è proprio potuto né vedere né intuire, evitandogli scogli e ostacoli, salvando il salvabile (lezione, e pure monito, magistrale). Mi imbatto per via con un collega, biennalista osservante, inviperito e deluso per questa (costosa) mossa di avvio, gli dico bene quindi lo scriverai, e lui perentorio macché non perderò tempo e spazio, scriverò solo di quel che è più importante! Ecco. Io davvero non saprei quel che è più importante. So invece bene quel che più mi è piaciuto.
A partire dal Leone d’oro di quest’anno a Twyla Tharp. A Venezia con due lavori bellissimi e riusciti: Diabelli (1998) sulle omonime variazioni beethoveniane e Slacktide (2025), suite per ensemble dal titolo Aguas da Amazonia di Philip Glass, arrangiata per percussioni dal Third Coast Percussion. È stata una maratona di perfezione compositiva, di ricchezza inventiva nella continuità e nel flusso, impressionante; a tratti anche soporifera ma in senso buono, credetemi: ossia capace di accompagnare a un torpore che è godimento e scaccia-incubi (nessun* andrà via dal Malibran scontent*). Prevale, nel segno di Tharp, una continua dissimulazione dello sforzo richiesto, che sconfina in altre culture estetiche, come quella del musical, ad esempio, meglio centrate con l’ortodossia protestante del prenditi cura di te e non rompere l’anima al prossimo. Sorpresa maggiore, l’incontro post-debutto condotto dallo stesso McGregor, preparatissimo, intelligentissimo, e perfettamente a suo agio nel raccogliere verbo e legacy di questa brillante, potenzialmente spigolosa, ottuagenaria.

La grande sorpresa dei danzatori di Biennale College arriva in una esecuzione attenta e potente, vorrei aggiungere salutare e prodiga, di In C di Sasha Waltz (2021), con le musiche di Terry Riley mirabilmente eseguite dal vivo dall’ottimo Syntax Ensemble. Ed è una grande occasione per questi danzatori di praticare l’improvvisazione strutturata qui richiesta; a questo serve infatti la ripresa di capolavori, tutti qui sembrano perfettamente in grado di farsi carico della presenza dell’altro, e di raccogliere sequenze a partire dalla forza del gruppo (qui, per me, emergono con forza la minuta eppure vulcanica Alice Del Frate, il magnifico controllo dell’energia di Davide Cesari e la ricchezza di linee con una sorprendente morbidezza della presenza di Lamone Sadler).

Tale da far dimenticare l’incomprensibile commissione ad Anthony & Kel Matsena di un nuovo lavoro per questi straordinari (già molto formati) danzatori (altro che college, questo è un post-doc), in una operazione antididattica e antipedagogica, con The Remaining Silence (in prima assoluta!) che è una sorta di aquario mancato, in cui sono annegate tutte le idee sventolate, perché create in movimenti sempre uguali, con prese mai in dinamica, rallentamenti senza senso e un po’ prendi tempo, senza contare le solite citazioni insopportabili da Clown/Show di Shechter o dai passetti di Sharon Eyal. Tutti i danzatori sono in bianco, tutti uniformi, uguali, e in tanto livellamento non è un abbaglio scorgere tra i volti pure qualche disappunto (uno dei punti più bassi di questa edizione: mi chiedo se era proprio necessario spostare dal Galles tanta modestia, mentre con più ingegno magari trovare qui coreograf* italian* capaci di segno, e di pensiero?).
Stefano Tomassini
Biennale Danza, luglio 2022, Venezia