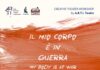La ventesima edizione del festival Short Theatre a Roma vede una nuova direzione collettiva, composta da Silvia Bottiroli, Silvia Calderoni, Ilenia Caleo e Michele Di Stefano. Una conversazione per indagare le linee curatoriali.
Cavi, tiranti e misteriose flycase costellano il pavimento dei grandi hangar, un brulicare discreto di tecnici e addetti alla logistica percorre a testa bassa i locali dell’ex Mattatoio di Testaccio, a Roma. Io lo attraverso alzando il bavero, sorridendo e tossendo un piccolo raffreddore, in un anticipo d’autunno. Penso a tutte le passate edizioni di Short Theatre, alle lunghe serate affollate, alla sensazione di “primo giorno di scuola” provata incontrando, anno dopo anno, la comunità del teatro romana e non solo, in anticipo sulla stagione che verrà.
Venti anni. Era il 20 giugno 2006 quando Roma dava i natali a un nuovo festival di arti performative, allora allocato al Teatro India. «Non un festival, né una rassegna, semmai si avvicina all’idea di una manifestazione, una manifestazione di idee, di modalità, di temi, di strategie. Nasce dalla necessità di osservare come il teatro, nelle sue varie declinazioni, risponda alle provocazioni del nostro presente». Così recitava il primo annuncio.
Oggi Short Theatre compie 20 edizioni e accoglie un nuovo gruppo curatoriale: Silvia Bottiroli, Silvia Calderoni, Ilenia Caleo e Michele Di Stefano mi danno appuntamento al bar che sta alle spalle de La Pelanda, avamposto e culla per il festival che quest’anno si terrà dal 5 al 14 settembre.
Ordiniamo da bere, ci sediamo a un tavolo e con piacere scopro d’essere la prima persona a parlare con tutte e quattro, in questa surreale quiete che anticipa la “tempesta”.

SILVIA BOTTIROLI Sì, ci stiamo godendo quel momento di calma prima dell’intensità. Ieri eravamo in riunione con il gruppo di lavoro al completo, una squadra di oltre quaranta persone. E così ci siamo ritrovate per la prima volta a raccontare il progetto a chi lavora con noi. Abbiamo immaginato, desiderato, costruito una proposta in maniera davvero collettiva, pur avendo approcci molto diversi.
Quasi tutte avete già avuto occasione di firmare direzioni artistiche, ma è un debutto per questa formazione. Come siete riuscite a integrare quattro prospettive anche molto diverse?
ILENIA CALEO La risposta alla call apriva uno spazio completamente libero; sapevamo di portare diverse esperienze sul piano curatoriale. L’interesse non è mai stato solo professionale – altrimenti avremmo forse fatto altre scelte – era piuttosto una risposta di desiderio. Lì abbiamo iniziato a immaginare e a desiderare, soprattutto riguardo all’oggetto e al dispositivo festival. Gli inizi sono stati estremamente naturali, molto improntati a rompere, rinominare, spacchettare…
MICHELE DI STEFANO Abbiamo sempre discusso di totalità, senza pensare alle proprie specificità.
SB Portiamo pratiche diverse. Per me è importante vedere lavori dal vivo, perché ho bisogno di radicare un’immaginazione dentro alla visione dello spettacolo, di incontrare un’artista e parlarci per comprendere le ragioni per cui è lì. Insieme abbiamo guardato materiali, incontrato le persone, tramite infinite conversazioni virtuali, cercando di non esser mai da sole.
IC Abbiamo anche lavorato molto contagiandoci a vicenda.

SILVIA CALDERONI Abbiamo instaurato relazioni plurali, anche tentando di disinnescare relazioni personali e senza dare niente per scontato, mentre va tutto riaffrontato da capo. C’erano molti lavori che ci interessavano, ma che sono fuori scala rispetto alle dimensioni di Short Theatre, eppure anche questi ci hanno insegnato a crescere e a nutrire un’idea. Altri artisti presenteranno formati trasformati dalla relazione con il festival.
Quanta attenzione avete messo nel garantire una continuità al percorso portato avanti fino a quel momento? In che modo, in quell’esercizio di immaginazione, è stato tenuto conto di quel che c’era stato prima?
SB C’è un aspetto che abbiamo immediatamente letto e che è stato una delle calamite per il nostro pensiero, quello della militanza artistico-culturale, del lavoro collettivo, il viaggio verso una maggiore assunzione di responsabilità da parte di un gruppo di lavoro. La natura di Short Theatre è anfibia, in equilibrio tra l’essere un festival internazionale di arti performative a Roma e l’aver mantenuto un aspetto molto poco istituzionale; in altre parole estremamente professionale dal punto di vista del rigore e delle capacità di lavoro ma con una postura spontanea e responsiva rispetto alla città, anche nel rispetto delle diversità di visione. Il desiderio era quello di continuare a invitare sguardi altri, che però si impastassero maggiormente dentro a un’aspirazione a una crescita molteplice, di moltitudine, di gruppo.
Insieme ad altri festival, anche questo fa parte di una geografia e di una filosofia curatoriale che immaginano che l’arte possa dire qualcosa al di là dell’arte. Come vi relazionate a questa identità?
IC Penso che non sia tanto una tendenza curatoriale, quanto una tendenza proprio della scena. Con estetiche e poetiche molto diverse, oggi c’è una presa di parola, un radicamento politico, un modo di pensare l’arte anche come forma di attivismo. Per me questo è anche un elemento problematico, non necessariamente positivo. Da studiose e studiosi stiamo provando a mappare questo fenomeno: se prima i riferimenti dei lavori erano letterature e cinema, negli ultimi anni sono quasi prevalentemente filosofia e saperi critici. Questo è un cambiamento, che però produce poi oggetti diversissimi: lavori più politici in senso classico, che cioè portano un messaggio; oppure oggetti puramente estetici che però attingono a fonti diverse. Credo quindi si tratti del sintomo di un mutamento del lavoro artistico, che magari una visione curatoriale è chiamata a cogliere e riattivare. Forse proprio date le nostre biografie, personalmente la sensazione è di non dover affermare troppo una dimensione politica; abbiamo quindi fatto delle scelte un po’ in controtendenza. Innanzitutto il festival non ha un tema né un titolo; questo è già un elemento in discontinuità con una tendenza a esplodere degli statement. Abbiamo invece lavorato in maniera più intuitiva, ambientale, atmosferica, affidando ai gesti artistici dei lavori quel discorso politico.

È vero che c’è un trend nelle arti performative contemporanee che punta a far loro dire qualcosa di specifico da un punto di vista politico; è vero che qui non c’è un titolo, ma allora come si struttura un’autorialità collettiva? Nel mettere un ordine, titolo o non titolo che sia, c’è la vostra firma.
SB Il festival non è un’illustrazione di domande di ricerca nostre, ma una pluralità di discorsi dissonanti, un campo agonistico in cui stanno dentro questioni anche difficili da tenere insieme. Noi cerchiamo di cogliere delle sensibilità – certe urgenze a livello di forma, di posizioni situate da artisti e artiste che parlano di alcune cose – ma anche di guardare ai linguaggi con cui lo fanno. Per me è più importante l’atmosfera, l’ambiente, le condizioni climatiche in cui qualcosa può o non può accadere. Ed è un passo ulteriore rispetto alla somma degli spettacoli e delle posizioni che si possono prendere. Nessun lavoro sta qui perché debba dire una cosa rispetto ai temi di cui parla; questo è anche un posizionamento nostro rispetto una forma di politica identitaria. Un lavoro esiste nella misura in cui incontra altre persone in una sala, in maniera prismatica; attiva altre memorie, altre proiezioni e immaginazioni. Un lavoro non sta per qualcos’altro. Allora dov’è un’autorialità che non pone un tema, non crea un recinto ma delle condizioni di incontro?
MDS I nostri scambi non si basano sulle specificità singole, c’è sempre qualcosa di più ampio oltre i confini di quel che stiamo discutendo. Negli ultimi vent’anni l’arte in questo paese ha praticato in maniera chiara un’intenzione ambientale, quella di fare e costruire spazio: lo spazio mette in evidenza i conflitti, a volte li risolve ma non sempre. E io penso che la facilità di scambio e di progettazione viene da questo “fondo comune”. E forse questo ha accomunato le generazioni degli ultimi quindici anni, in cui questa intenzione ambientale è messa ora in pericolo da disequilibri normativi dei massimi sistemi, sta diventando un’intenzione legata alla merce, allo sfruttamento, alla filiera. E noi in questo non vogliamo riconoscerci: questa conversazione con la scena non si è invece mai interrotta, a partire dagli inizi di Short; anche prima di entrare in un pensiero curatoriale, quella continuità si lega forse all’atto di ascoltare costantemente questa voce.

Ambiente, atmosfera, sono due termini citati spesso; ma, a guardare il programma, la metafora geologico-meteorologica investe principalmente gli spazi della Pelanda. Come è stata raccolta l’intenzione di decentramento che caratterizzava il triennio precedente?
MDS La meteorologia tratta sistemi evolutivi complessi che partono da regole semplici. Noi immettiamo certi elementi, certe vibrazioni, contenuti e densità in condizione di evolversi, partendo dalla stratificazione di un ambiente anche fisico. Il fatto di continuare a tornare in Pelanda dimostra un bisogno di reiterare l’incontro in modo che questo spazio possa vivere ogni giorno delle posture che le correnti generano, donando diversità a questa unicità. Però poi abbiamo lanciato un finale “a estuario”, nelle ultime due giornate, che si svolgono al Palazzo dei Congressi all’EUR, dove cerchiamo di penetrare in quella corrente con tutte le scommesse del caso, di trasformare un luogo molto connotato e che appare come un monumento vuoto con dei volumi che rendono molto precisa la posizione dei corpi. Io penso profondamente che non vi sia una discontinuità con un desiderio di decentramento, piuttosto abbiamo voluto attrarre in maniera magnetica un’eredità.
IC Nelle ultime giornate si sposta l’intero organismo, che compie un viaggio in un’altra destinazione. L’ambiente non è materiale, ma rappresenta un’intensità affettiva, è uno spazio modificato, una turbolenza che ci fa interrogare su come accostare elementi in maniera né analitica né logica, ma proponendo una costellazione di progetti che mette in relazione arti e teorie critiche, in condizione di poterla ripensare.

Soprattutto in festival internazionali, le performance girano, avendo però – di contesto in contesto – una rilevanza diversa. Qual è il grado di consapevolezza che le persone che avete invitato hanno del valore che avete dato al loro intervento?
SB La risposta non può che essere molto variegata: alcune artiste – per il tipo di processo, per la forma in cui sono invitate, per la qualità dei dialoghi – hanno un desiderio di ascolto specifico, altre dei gradi diversi, ma non abbiamo mai parlato con un/una producer, ma sempre con le artiste: non c’è un artista che arrivi senza aver avuto un dialogo con noi. Di certo credo che arrivare in un luogo conoscendone l’atmosfera e il carattere, comprendendone la profondità di pensiero, sia qualcosa di importante e raro.
MDS Anche nelle relazioni vis-à-vis c’è sempre stata la ricerca di un livello di intimità su questa intenzione più ampia. E dove abbiamo sentito che quella intimità non era reversibile abbiamo portato la conversazione su quel piano.
C’è un’intenzione di creare una continuità di relazione con persone che potrebbero stare qui anche per più di una edizione e così nutrire l’ecosistema artistico romano?
IC Non abbiamo pensato a un’artista con cui costruire una triennalità. Certo abbiamo ereditato alcune relazioni, ma abbiamo lavorato in maniera intuitiva. Il progetto Camera, sulle drammaturgie, è un incubatore, ma non ci interessa definire fin da subito se quei processi porteranno a un risultato; al contempo è importante fornire loro un ambiente per poter crescere. Abbiamo progettato formati attraversabili.

Liryc Dela Cruz, Camera, Salon… da quel che posso capire sono dei moduli di creazione alternativi, che si occupano di garantire tempi e spazi per la creazione. Azione che oggi ha molto senso, anche senza prevedere un atteggiamento programmatico.
SC Dal mio punto di vista è importante posizionarci come festival di creazione e non di produzione. C’è una differenza fondamentale: noi non abbiamo economie per poter produrre lavori. Creazione e produzione devono viaggiare insieme e, se non possiamo garantire una produzione, possiamo assumerci la responsabilità d’immaginare degli ambienti e così chiedere ad artiste e artisti di attraversarli nel loro modo e con grandissima libertà, sempre condividendone le responsabilità. Mettiamo a disposizione quello che abbiamo, la possibilità dei germi creativi.
Questo è il ventesimo anno di Short. Che cosa immaginate che possano trovare le persone a Short Theatre 2025? Avete pensato a creare un nuovo pubblico?
SC Di certo non c’è un ragionamento sul pubblico “in provetta”; il pubblico non viene “rifatto” da noi. Contiamo molto sulla proposta che stiamo facendo?
SB L’immaginario è molto variegato, cerca di parlare a persone anche molto distanti dal teatro contemporaneo, pubblici diversi, in uno spazio di negoziazione e di gioco.
C’è poi una politica di accesso al festival con prezzi molto accessibili, ma l’attenzione all’accessibilità riguarda anche la sfera delle disabilità. Al contempo c’è l’intenzione di retribuire, seppur simbolicamente, le persone che parteciperanno alle sessioni di formazione.

MDS Stiamo sperimentando un approccio multicentrico, che genera un piacevole tipo di approssimazione: un termine molto vicino alla parola “prossimità”; c’è un invito a essere prossime e prossimi a una dimensione come questa, anche con richieste piuttosto specifiche. Si tratta di mutare la prospettiva rispetto al semplice andare a vedere una singola azione, che può essere definita come un micro-evento. C’è invece bisogno di guardare a una dimensione più ampia, insieme a un atteggiamento di “rinselvatichimento”, lasciando alcuni ormeggi, in modo che alcune cose vadano dove devono andare. E questo è un principio di seduzione.
Se oggi Roma è abituata a vedersi servito un piatto fatto e finito, al quale si aderisce o meno, qui magari c’è lo spazio per scegliere se approssimarsi.
MDS E questo è ciò che speriamo.
Sergio Lo Gatto