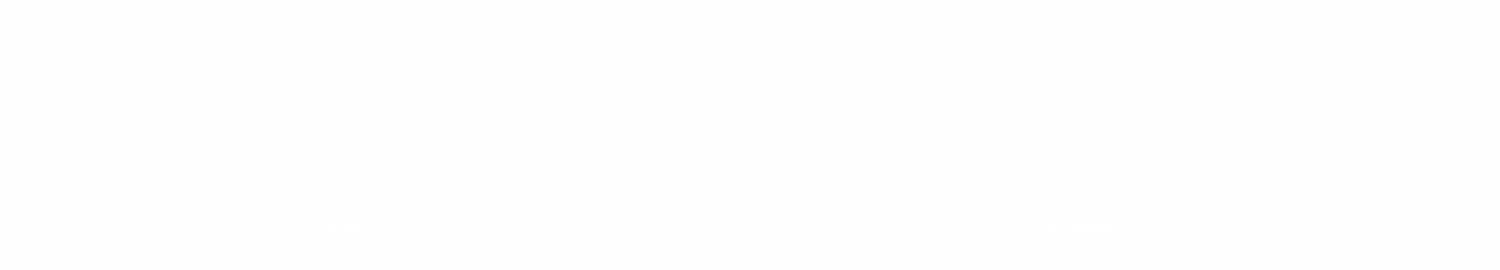The Seer di Milo Rau visto in prima nazionale durante Biennale Teatro 2025. Una riflessione a partire dal discorso dell’attrice Ursina Lardi insignita del Leone d’Argento

«Forse il valore di una cosa si coglie davvero soltanto quando questa è minacciata. Questa minaccia non riguarda me stessa ma ciò che questo premio rappresenta: il rispetto e la stima per l’arte. Soprattutto in tempi come questi, con le destre estreme e libertarie ma anche con forze conservatrici più moderate che continuano a smantellare e ad annientare non solo i finanziamenti e le infrastrutture, ma le condizioni stesse che rendono possibile l’arte». Questo è il discorso dell’attrice Ursina Lardi – Leone d’argento in questa ultima edizione della Biennale Teatro 2025 diretta da Willem Dafoe – alla consegna del premio, a seguito del debutto in prima nazionale di The Seer di Milo Rau in cui è protagonista, in scena nel Teatro alle Tese, insieme a Azad Hassan, in video. Il discorso è stato pronunciato nella giornata finale dell’edizione, il 15 giugno, ma sembrava anticipare quello che sta accadendo in questi giorni (leggi I finanziamenti allo spettacolo dal vivo e il caso Quirino. Che fine fa il teatro pubblico?). Ovvero, si sta smantellando proprio “il rispetto e la stima” per l’arte. Così sembra rappresentarsi nella realtà quello che accade nell’ultimo lavoro di Rau in scena: la veggente fotografa (dall’inglese “the seer”) interpretata da Lardi anticipa quello che accadrà di lì a poco e, in merito alle vicende relative alle politiche culturali, più che predire ha certificato, anticipandolo, uno stato dell’arte adesso rovinosamente definito. Rispetto invece alla guerra e alla violenza perpetrata oggi nel mondo e raccontata nello spettacolo, ciò che riguarda i finanziamenti al teatro attiene di certo a ben altra sfera di priorità ma, come dice in conclusione Lardi, «il teatro ci impedisce di dimenticare ciò che l’uomo sa dell’uomo» e impoverirlo, ridurne la pluralità e la ricerca, significa comunque attuare una distruzione.

Milo Rau è una delle figure innovatrici della scena contemporanea, di cui ciclicamente si aspetta il prossimo lavoro perché se ne vuole conoscere il pensiero critico; i suoi spettacoli pongono questioni sociopolitiche, i testi esprimono militanza e resistenza senza essere appesantiti da ideologismi o schieramenti. Milo Rau ha sì presentato The Seer a Venezia ma contemporaneamente – come raccontato in un’intervista a il manifesto – sta per debuttare con The Pelicot Trial, sul caso di Gisèle Pelicot, al Festival d’Avignone, e al Festival di Vienna a maggio ha presentato Burgtheater, il testo di Elfriede Jelinek che racconta dei celebri attori del teatro nazionale austriaco, il Burghteater appunto, che durante il nazismo collaborarono attivamente col regime; testo i cui diritti non erano più stati concessi dall’autrice fino a quest’anno. Basta citare, quindi, questi due nuovi progetti, guardare a ritroso nella sua carriera e comprendere come ciò che lui scrive, e le persone come Lardi che lavorano con lui, testimonino quanto siano interpreti indispensabili da guardare e ascoltare, per evitare l’annichilimento delle coscienze e continuare a porre punti interrogativi dove si vorrebbero risposte semplicistiche.

The Seer è ispirato al Filottete di Sofocle, come indicato nelle note di regia, ma potremmo dire che la tragedia dialoga parimenti, e facilmente è ravvisabile la connessione, con il saggio di Susan Sontag Davanti al dolore degli altri, con la postura della fotografa Diane Arbus e la rappresentazione di ciò che rifugge allo sguardo normato e convenzionale; per allargarsi e comprendere, nella sabbiosa scena, le innumerevoli questioni scientifiche e sociali che attengono all’intelligenza artificiale e alla sovrapproduzione di immagini. Nella sala dell’arsenale di Venezia, dune basse di sabbia riempiono lo spazio (scena di Anton Lukas): ci sono dei rifiuti, probabilmente detriti, tutto ciò che resta quando il mare se ne va. Sul fondo uno schermo, al centro Ursina Lardi, voce/corpo discreto e potente, grandissimo e minuto, composto e libero; fuori e dentro, coro e corifeo fusi insieme in un’unica figura in camicia e jeans, i cui occhi brillanti e acquosi si fanno vedere fino alle ultime file. Lei, unica attrice presente, dialoga in tedesco e in arabo, con Azad Hassan in video interpretando una fotografa vittima di stupro, capace, a seguito della violenza, di prevedere gli eventi e quindi essere già pronta sul posto a fotografare l’accaduto. Una Cassandra/Filottete/Arbus ferita come il mito sofocleo ma smaniosa di tendere verso quella stessa violenza da lei esperita, rappresentando e dando voce alle tante storie vere di fotografe e fotografi di guerra, come indicato nelle note dal regista: «Non accade nulla che io non abbia vissuto in prima persona, o che non mi abbiano raccontato persone a me vicine. Le foto di cui si parla sono state scattate davvero; le conversazioni e gli incontri, tragici o amichevoli che siano, sono realmente avvenuti».

Anche Azad Hassan è stato incontrato da Rau e Lardi a Mosul, si ricorderà infatti del regista il suo Orestes in Mosul del 2019 in cui il tema era proprio la reiterazione della violenza. Hassan ha perso una mano che gli è stata tagliata dallo Stato Islamico e, come Filottete, è stato abbandonato con la sua ferita. Il vuoto che circonda Hassan – ripreso in video in mezzo a un campo roccioso, sterminato, dal cui centro avanza fino a raggiungere la telecamera – è emblematico di questa solitudine in cui il malato, il vulnerabile, viene abbandonato. Stessa solitudine vissuta parallelamente da Lardi, generata da una violenza che scava una ferita profonda nei due protagonisti: per l’uno, un’amputazione, per l’altra, uno stupro, entrambi sullo stesso piano tragico del Filottete di Sofocle abbandonato da Ulisse sull’isola di Lemno a causa della ferita a un piede: «Ho scritto The Seer anche per estrarre qualcosa dalla nostra vita quotidiana e rendere visibile quello che potremmo definire tempo del mito. Forse per via del mio legame quasi infantile con i classici, ancora oggi io leggo ogni conflitto attraverso la lente delle tragedie greche». La sofferenza umana per Rau coincide allora con l’abbandono, il pregiudizio, la messa ai margini della realtà per individui colpevoli “soltanto” di portare una ferita, visibile o invisibile. Lardi/fotografa soffre di disturbi mentali, non ha più un lavoro ed è ricoverata in una clinica; Hassan è in esilio, non può più fare il professore e viene allontanato anche dalla sua famiglia.
The Seer è anche una riflessione tautologica sul potere, a volte distruttivo, dell’immagine, sulla sofferenza che questa è in grado di immortalare e quindi far perdurare nell’eternità. La domanda posta dal regista attiene inoltre alla pornografia intesa come estrema conseguenza di un mondo che genera e si serve di quella stessa violenza e quindi ha bisogno degli strumenti – le fotografie, i video – per diffonderla. Drammaturgicamente parlando risultano allora strumentali, e rivelatrici, due scelte: il metavideo che l’attrice filma in scena inquadrando il taglio che si incide sulla gamba e dal quale fuoriesce il sangue; e, al contrario, una rivelazione è la volontà registica di non proiettare la scena dell’amputazione e di rappresentare quella dello stupro solo attraverso il ricordo, la musica, la parola, che per Milo Rau assume da sempre, all’interno del suo repertorio, un significato figurativo e performativo. È infatti la parola, quindi la lingua, che Lardi e Hassan usano per comunicare tra di loro (Traduzione e dialogue coach arabo Susana Abdul Majid) a creare un ponte umano tra il qui e ora e la riproducibilità del video (Consulenza e coordinamento Iraq: Sardar Abdullah). Quel ponte che il teatro deve essere messo nelle condizioni di poter consolidare e rinnovare per il presente ma soprattutto per le generazioni future, affinché il panorama culturale di questo paese possa nutrirsi di sempre più spettacoli come questo, che educano al dialogo e, sapendo parlare di violenza, la prevengono.
Lucia Medri
Biennale Teatro 2025 – Venezia, giugno
THE SEER
Testo e regia: Milo Rau
Lingue: Tedesco, Arabo
Con: Ursina Lardi, Azad Hassan (video)
Scene e costumi: Anton Lukas
Design sonoro: Elia Rediger
Video: Moritz von Dungern
Drammaturgia: Bettina Ehrlich, Carmen Hornbostel
Ricerche: Ursina Lardi, Milo Rau
Luci: Stefan Ebelsberger
Traduzione e dialogue coach (arabo): Susana Abdul Majid
Consulenza e coordinamento (Iraq): Sardar Abdullah
Coproduzione: La Biennale di Venezia, Schaubühne Berlin, Wiener Festwochen | Free Republic of Vienna
Foto: © Moritz von Dungern