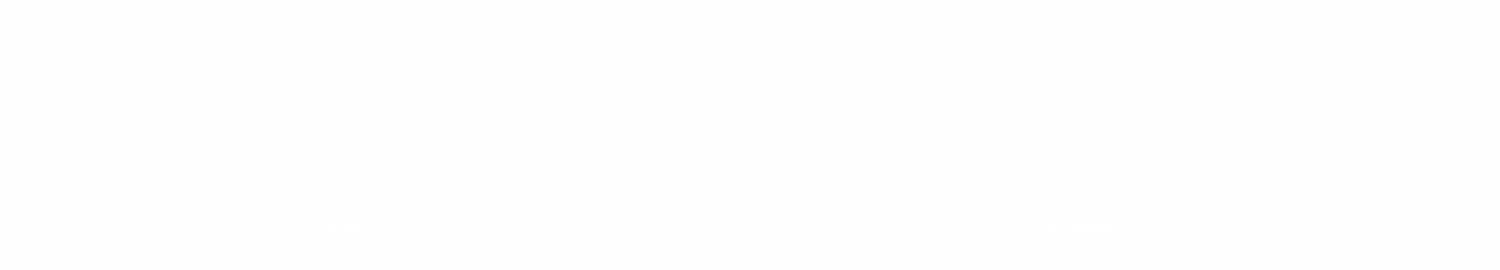Recensione. Carmelo Rifici mette in scena La pulce nell’orecchio di Georges Feydeau, pièce rappresentata per la prima volta a Parigi nel 1907. Visto al Teatro Vascello di Roma.

Basta poco, appena la scena comincia a illuminarsi nel Teatro Vascello, per capire che non saremo spettatori e spettatrici di un semplice e fedele allestimento de La pulce nell’orecchio: Carmelo Rifici ha deciso di entrare negli ingranaggi più raffinati del vaudeville di Georges Faydeau per azionare vere e proprie cariche esplosive. Cominciamo dallo spazio, non siamo nel salotto di casa Chandebise, quello descritto minuziosamente in tutti i dettagli dell’autore. Quello dallo stile inglese, in cui le porte vengono disegnate con particolare attenzione – perché sono i luoghi di accesso dei protagonisti al grande meccanismo -, in cui è tutta un’esposizione di mogani, caminetti, pannelli di seta con fantasie floreali gialle, e mobili a tre cassetti, scrittoi inglesi «a forma di X». Quando, nel testo, il sipario si apre Camillo è appoggiato a uno chiffonier, legge qualcosa prelevato da uno dei cassetti – un dossier precisa Feydeau nella sua lunga e particolareggiata didascalia – Elide lo interrompe, gli dà un brusco bacio sorprendendolo. Il giovane fa il brontolone, si lamenta un po’ presentando così al pubblico il proprio tratto comico, ovvero il difetto per il quale non riesce a pronunciare bene le consonanti, e poi cede a un altro bacio prima che entri Etienne, il marito della donna. Nella creazione (prodotta dal Lac di Lugano insieme al Piccolo e al Vascello) diretta da Carmelo Rifici, che ha curato anche l’adattamento drammaturgico insieme a Tindaro Granata, la scrittura scenica simbolicamente ci indica da subito un punto in cui il regista vuole farci guardare: le jeu, un grande gioco, una macchina comica di cui però fortunatamente non vengono messi in evidenza i meccanismi come spesso e in maniera stucchevole accade, ma soprattutto gli effetti, l’esplosiva ilarità delle invenzioni di Feydeau reinventata per un pubblico dei nostri giorni, per la nostra epoca. La scena di Guido Buganza allora è uno spazio dinamico determinato da cubi in gommapiuma colorati, soprattutto gialli e rosa; potrebbero far pensare alla geometria comica dell’autore francese, ma soprattutto hanno un valore “attorale”, si pensi a quando i tre personaggi femminili principali, Raimonda (moglie di Vittorio Chandebise), Luciana (moglie del focoso De Istangua) e Elide, appaiono sulla cima della struttura, come fosse un ballatoio.

La pulce nell’orecchio del titolo viene palesata da Raimonda la quale ha il dubbio che il marito possa tradirla, così Luciana le consiglia di scrivergli una lettera (come fosse quella di una possibile amante) per poi dargli appuntamento all’Hotel, che in questo gioco di citazioni e specchi si chiama proprio Feydeau.
Più volte in questi anni la riflessione sulla scena contemporanea mi ha portato a ragionare sulle possibilità del comico a teatro, ecco che nel caso de La pulce nell’orecchio (come per quel recente gioiello di Capitolo Due di Civica) vi è un testo di riferimento, appartenente addirittura a un epoca classica, gloriosa, della commedia, ma il vaudeville, espressione della Belle Époque parigina, difficilmente potrebbe assolvere il proprio dissacrante compito senza un adeguato lavoro di adattamento. Il comico, si sa, deve aderire alla propria epoca, è qualcosa che ha fortemente a che fare con la comunità spettatoriale dentro la quale cerca l’innesco. Basta aspettare sei battute dall’inizio della commedia per imbattersi nell’emblematico “Oh mio marito”, lo pronuncia la cuoca della casa del signor Vittorio Emanuele Chandebise mentre flirta con il rampollo Camillo, il timidone imbranato con il difetto di pronunzia che infatti fugge quando sta per palesarsi il marito della donna. Quel “Oh mio marito” poi in realtà sarà un topos decisivo in grado di percorrere tanta comicità teatrale e cinematografica lungo tutto il Novecento popolare, ma appunto oggi difficilmente avrebbe l’effetto sperato.

Il Camillo di Tindaro Granata cita Charlot, con quei riccioli e i baffetti, la camminata a passi stretti, negli occhi quell’incapacità di stare al mondo, una sorta di appartenenza lunatica a un altro sistema – non ancora corrotto dalle falsità borghesi – e poi all’improvviso le braghe che calano, come in quel cinema anni Venti di poveracci e slapstick, con Camillo/Charlot che guarda al pubblico, come guardasse nell’occhio della macchina da presa, prima di continuare a girare intorno alla scenografia e trovarsi nuovamente di fronte al pubblico con le braghe calate mentre Elide, con un sorprendente accento romanesco – «so’ ‘ntruppata» dice crollando su un cubo di gomma -, lo rincorre divertendosi in un amoroso acchiapparella che termina con Camillo definitivamente in mutande: la scena è realmente esilarante, a causa degli inciampi fonetici di Camillo, della musica di accompagnamento suonata dal vivo (sulla destra nella semi oscurità due musicisti occupano lo spazio di una tastiera, una batteria e una chitarra), della vitalità di Elide e poi quel “Oh mio marito” che qui viene pronunciato da entrambi, come in una sineddoche post drammatica con cui viene citato un intero sistema di segni teatrali, e che però ha valore di ineluttabilità drammaturgica. Ma è irresistibile anche il breve dialogo tra Vittorio e Camillo, nel quale il primo mima la lingua mozzata del secondo, oppure quando sempre Camillo per farsi intendere scrive le parole che vorrebbe far comprendere al proprio interlocutore alla lavagna ma mancanti delle stesse sillabe incomprensibili.

Sono tante le trovate comiche, quelle inventate e quelle già esistenti nel testo che vengono accuratamente amplificate. Feydau qui non è solo un genio della comicità ma un fustigatore dei costumi, un artista che sa prendere la temperatura alla propria epoca, ecco allora che l’Hotel è il centro erotico dell’opera, radice dei tabù, miraggio al quale gi uomini si riferiscono come una sorta di paradiso del piacere nascosto. Il sesso d’altronde è il fulcro dal quale tutto si intreccia, la pulce nell’orecchio ad esempio, il dubbio di Raimonda, potrebbe derivare solo dalla mancata affettività del marito legata a una improvvisa impotenza, e De Histangua dirà a Vittorio (nella versione di Rifici e Granata) «Io amo el mi gingillo» prima di leggere la lettera ricevuta da Chandebise in cui riconoscere la calligrafia della moglie (che l’avea scritta per l’amica) e dunque impazzire di gelosia credendo che la aspirante amante di Vittorio sia la moglie Luciana. E poi c’è la questione relativa al palato di Camillo, qui Faydeau ci porta su un altro piano, quasi metafisico: come una magia della scienza medica sarà il dottore a fornire l’organo mancante al ragazzo donandogli così la facoltà del linguaggio civilizzato, prima che il giovane possa perderlo proprio nei meandri dell’Hotel Feydeau.

Numerose sono anche le intuizioni registiche per far esplodere il meccanismo, come l’utilizzo della scena girevole, delle musiche che sottolineano o accompagnano – alla fine del primo atto tutti suonano e cantano Girls Just Want to Have Fun -, dei costumi di Margherita Baldoni che mescolano gli stili di un Secondo Novecento coloratissimo. E poi l’ensemble degli interpreti, vero e instancabile motore di un’opera che per due ore e mezza tenta anche il difficilissimo impegno di intrattenere e divertire il pubblico, di non fare pesare la lunghezza dello spettacolo, usando tutte le armi a disposizione: non solo quelle citative, ma pure i paradossi, le iperboli, gli straniamenti al limite del demenziale, come nel caso del personaggio di Rugby che nella versione originale è un inglese e invece qui è un americano (strepitoso Alfonso De Vreese) che si presenta tutto bardato da giocatore di Football. Ogni personaggio è curato dal proprio interprete in maniera dettagliata e ricca di giochi e sfumature e il risultato è un’opera sfaccettata, complessa e piena di vita teatrale, vero e proprio laboratorio di ricerca sulla recitazione comica che può avvalersi di una scena in cui gli attori si muovono in modo totale, salendo sui cubi, nascondendosi dietro di essi, cadendoci sopra…

Se le rotazioni del palcoscenico sottolineano l’intrecciarsi delle vicende – nel secondo atto non mancheranno gli scambi di persona e i giochi sul doppio -, con l’avvicinarsi della parte finale la commedia comincia ad adagiarsi su toni più intimistici: l’americano, scimmiesco e vestito da giocatore da football, apparentemente incapace di tenerezza si siede alla tastiera e comincia a suonare qualche nota di Into my Harms, ma solo leggermente, prima che la grande macchina comica prenda ancora il sopravvento. Però ormai qualcosa si è modificato, anche i personaggi d’altronde, mettendo a nudo le loro trame, hanno mostrato insoddisfazioni e fragilità: le luci di Alessandro Verazzi si abbassano, il comico diventa recita grottesca, l’americano riprende a cantare mentre gli amanti vengono scoperti, la pistola del macho latino spara… e poi Luciana (Francesca Osso) che con una voce sorprendente suona e canta quell’Addio scritto da Franco Battiato per la voce di Giuni Russo; anche i sotterfugi falliscono, ma pure gli amori borghesi sono «una brutta commedia che recitiamo da sempre », rinfaccia Elide al marito.

Tutti rimarranno incastrati nelle proprie maschere intenti a recitare i soliti gesti, mentre il palco girerà ancora e arriverà il tempo del perdono: «siete un Otello grottesco» dice con tenerezza Luciana al marito geloso. E tutto dovrebbe ricomporsi «perché è così che dovrebbe finire la commedia, con noi due che andiamo d’accordo» afferma quasi polemicamente Raimonda, intanto Antonietta e Elide, le due serve, fuggono dalla propria condizione e la malinconia si prende definitivamente il palco mentre la scena continua a girare su se stessa e questo meraviglioso gruppo di artisti e artiste (in ordine alfabetico Giusto Cucchiarini, Alfonso De Vreese, Giulia Heathfield Di Renzi, Ugo Fiore, Tindaro Granata, Christian La Rosa, Marta Malvestiti, Marco Mavaracchio, Francesca Osso, Alberto Pirazzini, Emilia Tiburzi, Carlotta Viscovo) a piena voce canta In The End di Scott Matthew; perché tutti abbiamo i segni delle nostre cicatrici e nonostante questo fingiamo una risata: We all bear the scars/ Yeah, we all feign a laugh / We all cry in the dark / Get cut off before we start / And as your first act begins / You realise they’re all waiting / For a fall, for a flaw, for the end.
Andrea Pocosgnich
Teatro Vascello, Roma, aprile 2025
LA PULCE NELL’ORECCHIO
di Georges Feydeau
traduzione, adattamento e drammaturgia Carmelo Rifici e Tindaro Granata
regia Carmelo Rifici
con (in ordine alfabetico)
Giusto Cucchiarini
Alfonso De Vreese
Giulia Heathfield Di Renzi
Ugo Fiore
Tindaro Granata
Christian La Rosa
Marta Malvestiti
Marco Mavaracchio
Francesca Osso
Alberto Pirazzini
Emilia Tiburzi
Carlotta Viscovo
scene Guido Buganza
costumi Margherita Baldoni
luci Alessandro Verazzi
musiche Zeno Gabaglio
assistente alla regia Giacomo Toccaceli
regista assistente Alice Sinigaglia
coaching movimenti acrobatici Antonio Bertusi
coaching clownerie Andreas Manz
realizzazione maschera Alessandra Faienza
supporto realizzazione scene e attrezzeria Matteo Bagutti
costumista assistente Ilaria Ariemme
direttore di scena e capo macchinista Ruben Leporoni
macchinista e movimentazione pedana girevole Fabrizio Cosco
capo elettricista Alessandro Di Fraia
suono Nicola Sannino
fonici Stefano Gualtieri, Riccardo Roghini
sarta di scena Margherita Platé
aiuto sarta GIuseppina Corbari
trucco e parrucco Enrico Maria Ragaglia
costumi realizzati presso il Laboratorio di Sartoria del Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa
produzione LAC Lugano Arte e Cultura, Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, La Fabbrica dell’attore – Teatro Vascello di Roma
durata 2h 20′ senza intervallo