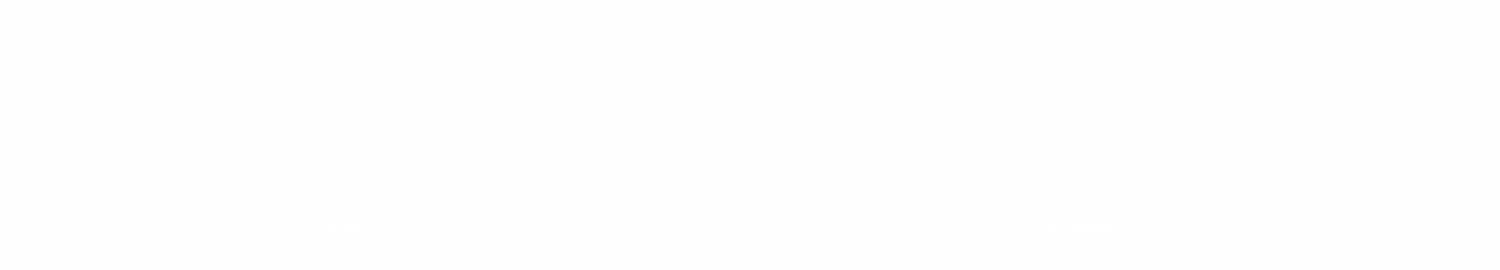Continuiamo a raccontare e analizzare l’ultima tornata di finanziamenti ministeriali per lo spettacolo dal vivo. Dopo i punteggi del teatro, della danza e dei multidisciplinari qui le assegnazioni, con uno sguardo analitico su numeri e statistiche e una riflessione sugli esiti.

Ne Il teatro e la paura (Luca Sossella Editore) Thomas Ostermaier racconta che un giorno, preso un taxi in Olanda, la destra da poco al governo, si sente dire dall’autista (saputo che il cliente è un teatrante) «è ora di restituire!». Ostermeier assorbe la frase e ripensa al modo in cui, prima di un dibattitto pubblico, fu salutato da un deputato del Partito Liberale tedesco: «Come stai, ladro di sussidi che va a champagne?». «Questa sembra la tendenza» commenta, siamo al battutismo con cui dire che «i sinistroidi della cultura, per anni rimpinzati, si ritroveranno finalmente senza finanziamenti». Ma, avverte Ostermeier, «la questione è più complessa».
In Italia per settimane nei social e sui giornali s’è paventata un’aggressione economica al settore, anche utilizzando parole che altrove sanguinano davvero: dichiarazione di guerra, conflitto, vittime, distruzione. Oggi abbiamo a disposizione i documenti coi numeri. Che vanno letti, perché poi ci si chieda: qual è la logica? Che progetto c’è in atto?
Il 24 luglio il Ministero rende note le assegnazioni-danza. Riduzione dei soggetti rispetto al 2024 (da 161 a 146, -9,3%) e aumento del gettito complessivo, che da 18.329.258,18 euro passa a 18.902.701 euro (+3,1%). 17 prime istanze, pari all’11,6% del totale e dunque 129 realtà confermate, il 96,1% delle quali riceve un incremento economico rispetto all’ultimo anno del triennio precedente. Quattro giorni dopo tocca al Multidisciplinare. Anche in questo caso diminuiscono gli appartenenti al settore, da 81 a 79 (tre festival in meno, un organismo di programmazione in più; 14 sono le realtà 2024 assenti, 12 i nuovi ingressi), a fronte di un aumento del gettito: da 16.733.573 euro a 17.140.000 (+406.027 euro, pari allo 0,2%). Il sensibile aumento complessivo annuncia gli esiti dei singoli: dei 67 soggetti confermati 8 (11,9%) ricevono un contributo pari a quello dell’anno scorso, 18 (il 26,8%) subiscono un taglio e 41 (il 61,1%) hanno un aumento. Insomma il 73,1% del settore non ha danni economici. Si tratta, più che di un rinvigorimento del sostegno, di una stabilizzazione. Lo conferma un dato: 41 delle 59 variazioni di denaro (il 69,4%) sono sotto i mille euro. Ciò riguarda anche chi ha subito tagli nei punteggi di valutazione della Qualità Artistica, come ad esempio Margine Operativo (+252 euro), Teatro delle Moire (+402), Mittelfest (+617), Kilowatt (+675) mentre il festival di Santarcangelo ottiene 1.131 euro in più.
Cosa accade invece al teatro? Il decreto arriva l’8 agosto. Primo dato è il totale dei contributi, che sono 459 ovvero, tournée escluse: 44 in più rispetto al 2024 (+10,6%), 40 in meno se torniamo all’anno-ponte stabilito nel 2021 per covid (-8,71%), 174 in più del 2018 (+61,1%) e 180 in più del 2015 (+64,5%), primo anno d’applicazione della riforma dei criteri d’assegnazione del FUS. Per intenderci: il numero attuale delle attività teatrali finanziate (459) è più alto del numero di domande presentate al Ministero dieci anni fa (450). Quasi un intero e ulteriore sistema dunque, in un decennio, è stato aggiunto al sistema teatrale sostenuto nel 2015 dal MiC. Contando invece il denaro, ai 459 soggetti vanno 96.792.018 euro, 1.338.375 euro in più rispetto alla dotazione definitiva del 21 novembre 2024 (+1,4%). Sono 102 le prime istanze (il 22,2%), tra nuove domande accettate e passaggi d’ambito (un festival che diventa una compagnia, una compagnia che diventa Centro di Produzione, un Centro di Produzione che diventa Teatro della Città). Restano dunque in 357 che, presenti nel 2024, hanno ottenuto conferma. A questi com’è andata? Per lo 0,2% – ossia una realtà, Teatri di Pistoia – c’è l’aumento (+5.742 euro), il 41,7% riceve la stessa quantità di denaro dell’anno scorso, il 59,1% dei soggetti registra un taglio. Di quanto? Entro i mille euro (25,0% dei casi), tra mille e cinquemila euro (37,7%), tra cinquemila e diecimila euro (16,5%), oltre i diecimila (20,2%). Per aggregazione: il 62,7% perde cinquemila euro annui o meno o, se preferite, il 79,7%, ovvero i quattro quinti del sistema, ha perdite sotto i diecimila. In assoluto al MiC costano meno Nazionali, imprese, festival e accademie mentre sale l’investimento lì dove si è verificato un rilevante aumento di soggetti: i Teatri delle Città (passati da 18 a 21 e da 19.453.579 a 21.974.994 euro), le imprese di teatro di figura (da 23 a 30 e da 1.478.369 a 1.739.567 euro) e di teatro di strada (da 6 a 10 e da 138.231 a 194.994 euro), i festival di teatro di strada (da 13 a 19 e da 299.375 a 386.822 euro), l’ambito della Promozione (i progetti di ricambio generazionale, coesione sociale, perfezionamento professionale e formazione del pubblico: da 30 a 35, passano da 1.548.489 a 1.626.992 euro). E naturalmente i Centri di Produzione, cui è stato riscritto l’articolo, ch’erano 36 e sono 56: ricevevano 17.650.098 euro, ottengono 21.027.520 euro. Insomma, il gettito s’alza dove proprio non è possibile fare altrimenti. Eccezione: gli organismi di programmazione che da 26 diventano 30 ma vedono calare il contributo di 154.075 euro. Variazioni singole di rilievo? Tieffe di Milano (ex Centro di Produzione, +139.878 euro) e Teatro Due di Parma (-56.846 euro), Elfo di Milano (-40.384), Metastasio di Prato (-24.811), Bellini di Napoli (-22.935) nei Teatri delle Città. Tra le imprese teatrali: Politeama di Roma (-95.469 euro), Mauri-Sturno (-35.236) e Umberto Orsini (-27.583). E poi Fattore K (-58.251 euro), Lombardi-Tiezzi (-23.944), Raffaello Sanzio (-19.006), Scena Verticale (-10.497) tra le compagnie di ricerca mentre è destabilizzato, tra perdite e aumenti, il capitolo dei Centri di Produzione, aggregati non per identità e proposta ma per quantità di poltrone in platea (450, 250, 200). È in quest’ambito che il Quirino, ex organismo di programmazione, passa da 104.904 euro a 334.487 euro (+229.583, un aumento del 218,8%) con la United Artists, che ne ha rivendicato la proprietà, che è stata riconosciuta tra i Teatri delle Città (557.723 euro). Chi dirigerà cosa dunque? Perdura nel merito l’assenza di chiarezza. Infine il Teatro della Toscana, escluso dai Nazionali. È un Teatro della Città, il contributo ministeriale è di 1.515.825 euro, 382.783 euro in meno rispetto al 2024.
Considerazioni. A fronte di un aumento del 10,6% dei soggetti il Ministero ha previsto una crescita finanziaria dell’1,4%. Ma anche confrontando il gettito per il teatro 2025 (96.792.098 euro) con quello di luglio ‘24 pre-aumenti (90.127.631 euro, differenza: +7,3%) avremmo uno squilibrio. Il MiC aumenta infatti la platea dei progetti sostenuti ma offre in proporzione meno risorse. Sia chiaro, è prevedibile l’integrazione in autunno ma il messaggio è chiaro: ciò che facevate potete continuare a farlo con meno soldi. Inoltre alle prime istanze 2024 andava il 13,3% del totale, le 102 del 2025 ricevono il 10,0% per cui i nove decimi del gettito serve alle conferme. Il MiC bada innanzitutto alla conservazione e riduce l’investimento nel ricambio. È tra gli effetti della scelta di Franceschini del 2022, presa tra gli applausi del settore. L’allora ministro infatti, dopo l’anno-ponte pandemico (449 soggetti, tournée escluse, di cui 231 prime istanze), dà mandato perché la platea dei sostenuti s’allarghi: passa, da un triennio all’altro da 285 a 420. Franceschini così contraddice le finalità della riforma (meno soggetti, contributi più alti, si finanzia l’eccellenza mentre le attività di respiro locale vanno supportate da Regioni e Comuni) e commette l’errore d’usare la Legge con cui è nato il FUS per fronteggiare una condizione d’emergenza. Risultato? Distorce nell’impiego una norma passata per mettere in sicurezza il presente, stringendo i varchi al futuro. Il nuovo ha bisogno di spazio, la prospettiva è invece l’immobilità del settore o, in primis, il mantenimento degli introiti di chi già ne fa parte. Ma così l’esistente divora il domani. Inoltre: la stabilità (Nazionali, Teatri delle Città, Centri di Produzione) pesa di più (il 55,8% nel 2024, il 58,9% nel 2025) eppure Teatri delle Città e Centri di Produzione hanno un contributo-medio ridotto. Siate in concorrenza, con mezzi minori. Infine resta inalterato il rapporto tra i soggetti che si occupano in modo esclusivo o maggioritario di produzione (270) e quelli votati alla distribuzione (90). In pratica per ogni tre realtà che fanno nascere spettacoli ne esiste uno solo che lavora espressamente perché questi spettacoli girino. Gran parte dei debutti continueranno a morire in sede. Non avranno tournée, possibilità di maturare e di crescere, l’incontro con il pubblico di un’altra città.
In Italia manca una legge di settore per il teatro. In sua assenza si cercano nei decreti ministeriali indicazioni di politica culturale pur trattandosi di provvedimenti regolativi. Ad essere riformati nel 2015 sono i criteri d’impiego del FUS. Dominano nella scrittura della riforma i dettami assunti dal capitalismo privato e usati dalle istituzioni pubbliche per motivare e misurare il proprio investimento. Innalzamento dei minimi, crescita della valutazione numerica, squilibrio tra misurazione quantitativa e vocazione qualitativa, spinta alla produzione in eccesso da smaltire in fretta, come avviene per il terziario. «Poiché questi sono criteri del mercato dei consumi essi riguardano per la maggior parte questioni come l’immediatezza del consumo, l’immediatezza della gratificazione e l’immediatezza del profitto» direbbe Zygmunt Bauman (Per tutti i gusti, Laterza, 2015). In conseguenza ed in pratica: riduzione dei tempi di creazione, ottimizzazione delle risorse, usa e getta degli spettacoli in assenza di tournée. Ventuno giorni di prova, uno o due settimane di repliche, riprese non previste e via col prossimo titolo da dare in offerta al cliente. Siamo cresciute e cresciuti con l’idea del teatro d’arte per tutti e leggendo delle prove di Peter Brook e ci ritroviamo con «la logica degli scaffali ripieni» chioserebbe Bauman. L’impostazione data dall’allora ministro Franceschini, coerente con la dottrina del New Public Management con cui si governa in Italia e in Europa l’uso del denaro pubblico nei settori sensibili (cultura, sanità, istruzione e trasporti) – culto del risultato e certificazione formale e numerica in cambio del denaro investito – è avvertita già dalla prima Commissione Prosa, che nella Relazione del 26 settembre 2015 scrive che «l’entità del contributo è determinata in maniera significativa e rigida da fattori amministrativi che finiscono per favorire le imprese di dimensioni maggiori e con una maggiore capacità produttiva» e che premiano «realtà chiaramente commerciali a discapito di soggetti focalizzati sul rischio culturale» per cui due conseguenze: è tradita «la logica meritoria del finanziamento» e si riduce «la capacità di intercettare nuovi fenomeni artisticamente validi»; lo affermano negli stessi giorni anche Massimiliano Civica e Attilio Scarpellini ne La fortezza vuota (Edizioni dell’asino, 2015) inventando la categoria ossimorica del «Teatro pubblico commerciale». È il ribaltamento della logica posta alla base del contributo dello Stato, sostengono: dovrebbe «permettere agli artisti e alle artiste di lavorare al riparo dai compromessi del mercato» così che opere dalle alte ambizioni culturali giungano a quante più persone è possibile, è finalizzato invece per «fare numeri».
E la destra? Completa l’impostazione data da ciò che chiamiamo “centro-sinistra” con un pensiero perseguito con ferocia. A dirlo ad alta voce è il sottosegretario Gianmarco Mazzi il 14 marzo 2024 ai microfoni di RTL. Parla di cinema, vale per il teatro: «Lo Stato finanzia tantissimi film che poi non vede nessuno». I soldi dovranno andare a chi incassa e ottiene risorse private. Tant’è, il segno inferto dal governo Meloni non va cercato, fatte eccezioni e per ora, nelle assegnazioni economiche ma nei dettagli che hanno ulteriormente ridefinito il Decreto: la cancellazione del rischio artistico tra gli obiettivi; la riscrittura dell’articolo dei Centri di Produzione, accorpati per capienza e spinti a un’offerta indifferenziata («attività teatrale classica, moderna, contemporanea, di teatro sociale, di innovazione e di teatro per l’infanzia e la gioventù nonché di produzione di commedia musicale, operetta, teatro di figura, teatro di strada e teatro di poesia») purché abbia riscontri al botteghino; la riforma della Qualità Indicizzata attraverso la moltiplicazione dei parametri (da 10 a 15 per le compagnie, da 7 a 14 per i festival, da 8 a 15 per i Teatri delle Città, da 9 a 16 per Nazionali e Centri di Produzione), così da renderne meno comprensibile la valutazione. E nella Qualità Indicizzata: l’inserimento della “Congruità gestionale”, che pone in rapporto il costo del progetto col numero di spettatori e gli incassi; la variazione di peso, nel punteggio, data alle risorse pubbliche e alle risorse private ottenute (fino al 2024 valevano gli stessi punti per Nazionali, Tric e Centri di Produzione, oggi il rapporto è di 1 a 5); l’incidenza dei parametri finanziari nel calcolo complessivo, che passa ad esempio dal 44,0% al 50,0% per i Nazionali, dal 32,0% al 46,0% per i Centri di Produzione, dal 48,0% al 73,0% per gli organismi di programmazione. Il progetto ha quindi almeno dieci anni e diventa a ogni passaggio più radicale.
Assenti dalla quotidianità del dibattito pubblico stanno intanto questioni primarie. Il Fondo Nazionale dello Spettacolo dal Vivo innanzitutto, che incide lo 0,02% sul PIL e che dal 1985, calcolato a prezzi costanti così da eliminare l’effetto dell’inflazione, è diminuito del 57,6%. Se è vero, come dice la Carta Costituzionale, che «l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro» (art.1) e che «la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto» (art.4) ciò non può non valere anche per chi opera per lo spettacolo dal vivo ovvero in un settore che, privato nei decenni e dai governi delle risorse necessarie, sono più incerte e faticose la continuità d’impiego e la pratica in concreto del mestiere. E la sperequazione tra aree del paese (il 69,7% dei contributi alle attività teatrali è nel Centro-Nord, il 30,2% tra Isole e Sud) e tra metropoli e medi o piccoli centri. Tant’è: ci sono regioni in cui manca una filiera lavorativa e di crescita e in cui è offeso ogni giorno il diritto all’acceso all’esperienza formativa dell’arte. Sono asimmetrie che il Decreto amplierà non tenendo davvero conto – nei calcoli – delle diversità territoriali esistenti. Sono inoltre abitudini che non fanno mai scandalo il ritardo di comunicazione degli esiti, a stagioni già programmate e presentate al pubblico, e l’opacità delle valutazioni. Eppure la Commissione Prosa del 2015 avvertiva: «Il FUS è sostenuto col denaro dei contribuenti. Le motivazioni e le modalità di sostegno pubblico a ciascun soggetto devono dunque essere chiare, trasparenti e soggette a controllo e verifica». Occorrerebbe perciò «rendere pubbliche le sintesi dei progetti richiedenti il finanziamento, con l’esclusione dei dati sensibili». Aspettiamo da dieci anni. E ancora: c’è un dialogo mozzato tra il Ministero e gli organi di rappresentanza del settore, con C.Re.S.Co. escluso dal tavolo (certe decisioni «sono state prese in assenza della nostra voce» si legge nel report reso pubblico il 28 luglio) e l’AGIS intesa invece come referente con cui confrontarsi nelle fasi di decisione e stesura. Infine c’è una Commissione Prosa senza i rappresentanti degli enti locali, che costituisce un insulto al principio di cooperazione istituzionale e che perciò andrebbe rinominata o quanto meno integrata. Ma chi vi entrerà in autunno, sapendo d’avere a che fare con colleghi che non hanno alcuno scrupolo a procedere a colpi di maggioranza ogni volta che vogliono?
Alessandro Toppi
Leggi anche:
Ministero, Teatro. E se facessimo parlare le carte?
FNSV: comunicato congiunto degli assessori e delle assessore
AIDAP chiede un confronto urgente sul nuovo DM: la danza ha…
I finanziamenti allo spettacolo dal vivo e il caso Quirino. Che fine fa il teatro pubblico?
Il sottosegretario Mazzi annuncia un gruppo di studio sull’assegnazione dei contributi…
Per un teatro pubblico. L’appello di Massimiliano Civica e del Teatro Metastasio
Pericoli e opportunità del Decreto Ministeriale. Intervista a Franco D’Ippolito