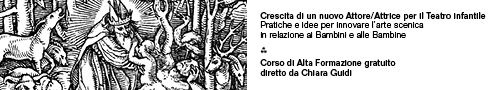Dal seminario residenziale “Curare la curatela”, organizzato alla MAB Maison des Artistes di Bard da C.Re.S.Co. e Palinodie, all’Assemblea Nazionale della neonata Rete Illumina a Napoli, una ricognizione del settore alle porte del nuovo triennio.
 La mia breve stagione di trasferte estive inaugura con un invito di Elena Lamberti al seminario residenziale Curare la curatela, organizzato da C.Re.S.Co. e Palinodie alla neonata MAB Maison Des Artistes di Bard, splendido borgo valdostano.nLa tre giorni intensiva è dedicata alla figura del libero/a professionista nei campi della comunicazione, della programmazione, della distribuzione, progettazione e gestione di spazi e progetti di spettacolo dal vivo, con l’intento di “definire un vocabolario comune fra coloro che si occupano di curatela”. Per quanto il seminario sia incentrato sulla figura del lavoratore autonomo, la partita iva è un attributo che, concretamente, caratterizza pochi di noi trenta partecipanti. Il “libero professionista” diviene una dimensione quasi spirituale che caratterizza non tanto una forma contrattuale o un meccanismo di fatturazione, bensì una condizione lavorativa ibrida, spesso non inquadrata, non continuativa, non tutelata e non riconosciuta in cui entrambi i termini, “libero” e “professionista”, assumono tratti grotteschi e anacronistici.
La mia breve stagione di trasferte estive inaugura con un invito di Elena Lamberti al seminario residenziale Curare la curatela, organizzato da C.Re.S.Co. e Palinodie alla neonata MAB Maison Des Artistes di Bard, splendido borgo valdostano.nLa tre giorni intensiva è dedicata alla figura del libero/a professionista nei campi della comunicazione, della programmazione, della distribuzione, progettazione e gestione di spazi e progetti di spettacolo dal vivo, con l’intento di “definire un vocabolario comune fra coloro che si occupano di curatela”. Per quanto il seminario sia incentrato sulla figura del lavoratore autonomo, la partita iva è un attributo che, concretamente, caratterizza pochi di noi trenta partecipanti. Il “libero professionista” diviene una dimensione quasi spirituale che caratterizza non tanto una forma contrattuale o un meccanismo di fatturazione, bensì una condizione lavorativa ibrida, spesso non inquadrata, non continuativa, non tutelata e non riconosciuta in cui entrambi i termini, “libero” e “professionista”, assumono tratti grotteschi e anacronistici.
Come dichiarato senza troppi preamboli dal titolo scelto per il seminario, il tema della cura è centrale nella discussione che ci accompagna durante i lavori. Presto ci rendiamo conto che “cura” e “curare” non sono affatto termini condivisi e che in molti non li sceglierebbero per definire le proprie pratiche. Ci si interroga sul senso odierno di questa parola tanto frequentata, “cura”, nella sua dimensione immanente e quotidiana del “prendersi cura” – un processo di delicatezza, osservazione e ascolto spesso fatto di piccoli gesti, poco rumoroso – e “curare”, ovvero intervenire in un contesto di emergenza, come si cura una patologia.
A braccetto con quello di cura spesso va, nel gergo comune, un altro concetto, quello di prevenzione. Quello tra cura e prevenzione è un binomio che caratterizza la politica e, nella fattispecie, ormai da anni, la gestione politica di un paese come l’Italia. Una condizione diffusa, costante, permanente di crisi ed emergenza richiede la presenza instancabile di chi è chiamato a curare e prendersi cura. Intervenire tempestivamente è, spesso, l’unico modo per arginare un contesto in via di esplosione. Curare ed essere sottoposti ad una cura è dispendioso, spesso si occupa dei sintomi piuttosto che delle cause e rinuncia, per motivi di tempo, a una visione olistica del paziente. La prevenzione, invece, è legata alla capacità di sguardo sul futuro. Prevenire è un investimento, ovvero un dispendio di energie sui cui risultati bisogna portare grande fede, poiché essi si vedranno molto tempo dopo, e non è affatto detto siano quelli sperati. Prevenire è una pratica sperimentale dagli esiti incerti.
Intanto, gli splendidi spazi della MAB ci accolgono in un esempio virtuoso di collaborazione e dialogo tra pubblico e privato in ambito culturale, così come ci dimostrano il fondamento di questo dialogo sono non soltanto le buone intenzioni e il coraggio delle scelte, ma anche, e forse soprattutto, le risorse. Ci ricordano l’esigenza, profonda, di luoghi che sappiano accogliere nei territori e che si facciano casa non di produzione, ma di permanenza residenziale, di ricerca spassionata e pure disordinata. Questo è lo spirito del primo incontro seminariale, che inaugura un processo che vuole farsi approfondire e che fa dell’orizzontalità il perno per un confronto che sappia essere, oltre che costruttivo, sincero.
Quello della trasparenza, dell’onestà e dell’ipocrisia è uno dei temi che ci troviamo ad affrontare nel vorticare dei tavoli di lavoro. Se ne sta in agguato dietro a ogni discussione, poiché tutti sappiamo di essere, spesso, i primi a non farci garanti di noi stessi, in un settore che sempre più è costretto a considerare concetti come quello di incasso, profitto, amicizia politica. Chi sono i nostri pazienti? Di chi è che ci prendiamo cura? Soprattutto, chi è che si prende cura di noi?
Serve arrivare in fondo alla discussione per rendersi conto che la paura di definirsi può portare con sé un’ossessione di originalità, può far emergere il contrasto tra le dimensioni dell’arte, di ciò che sono gli artisti, e l’infrastruttura che permette all’arte di esistere ed esprimersi.
Lo denota la tendenza, la necessità di definire il proprio mestiere “creativo” pur non essendo artisti, in questo marcando una differenza con tutti gli altri mestieri, forse anche per l’abitudine tutta italiana di confondere problem solving con creatività. Ma se non intendiamo essere confusi con “semplici” lavoratori, come pretendiamo di essere come tali tutelati? Emerge anche qui la necessità di una dimensione amministrativa e legale che sia in grado di tutelarci pur rispettando l’inerenza temporale e procedurale dei nostri mestieri e, soprattutto, la fluidità di ruoli che li caratterizza. Il mondo del teatro stabile o del grande teatro di produzione in cui un fonico non può, da contratto, attivare un’americana mobile rappresenta una faccia minore del comparto, una nicchia operativa rispetto a una stragrande maggioranza di lavoratori che vive nell’alternanza e sovrapposizione di ruoli tecnici, artistici, organizzativi. Non che questo debba necessariamente essere un vanto, anche perché non è facile capire se sia nata prima la fluidità dei ruoli, o la necessità e la scarsezza di risorse che determinano un approccio multitasking anche al di là delle proprie competenze e passioni. Interventi come quelli di Giulio Stumpo, presidente di A.C.T.A. (associazione dedicata lavoratori autonomi e freelance che potrebbe divenire un ottimo interlocutore per il settore), ci riportano la necessità di un approccio pragmatico, di una competenza anche tecnica a cui affidarsi e che padroneggi il linguaggio necessario per tradurre questa complessità, questa molteplicità di personalità, nei contesti sindacali e legislativi. Risulta a mio parere fondamentale la necessità di figure tecniche e nel contempo organiche che possano assumersi il ruolo – e, soprattutto, essere delegate – a rappresentare quella che fa una grande fatica nel definirsi come categoria. A Bard, intanto, sono nati un comunicato stampa, un report e l’inizio di un n-calogo (disponibili qui) che rimane volutamente aperto e che, si spera, saprà nutrirsi in futuro.
La tematica del lavoro, della sua tutela e della sua regolazione, è ovviamente centrale nell’ambito dello spettacolo dal vivo. Convive, ad esempio, con la difficoltà di certificare competenze diversificate, spesso fortemente legate alla pratica; così come deriva da livelli di professionalizzazione profondamente eterogenei nelle dinamiche di settore, a loro volta connessi alla frequente necessità di sopperire alla scarsezza di risorse economiche e, di conseguenza, umane. Prestarsi ai ruoli organizzativi e direttivi spesso genera carenze dal punto di vista gestionale ed economico, sacrificando progettualità potenzialmente virtuose e basate su idee dal grande valore artistico. Anche di questo si parla a Bard, dove, per esempio, emerge l’idea di un percorso di accreditamento – capitanato da C.Re.S.Co. – che sappia certificare l’acquisizione di competenze specifiche, nominabili e riconoscibili al di là del percorso di formazione precedente. La precarietà di forme e retribuzioni, lo scontro che avviene tra lavoratori stessi nello spettro che va dall’amatoriale al professionale, spesso rende quasi impossibile adottare una narrazione e una mobilitazione di settore, comporta profonde ricadute su ambiti più specifici, e approfondisce i divari che già vessano il mondo del lavoro tout court. Sono dinamiche che coinvolgono, per esempio, i temi della formazione teatrale, del teatro sociale; della disabilità e, ovviamente, delle dinamiche di genere.
 Pochi giorni dopo mi trovo a Napoli, nelle eleganti sale della centralissima Chiesa di San Severo al Pendino per la prima e fondativa Assemblea Nazionale di Illumina, Rete Nazionale per la parità di genere nelle arti performative. All’Assemblea, riservata alle socie e dedicata allo Statuto, segue un pomeriggio aperto al pubblico in cui si presenta il progetto Il mondo salvato dalle ragazzine, proposto da 11 enti sul territorio nazionale e capitanato dalla sicula Associazione Culturale Madè che, per giunta premiato tra i Progetti Speciali del Ministero (sempre attento alle occasioni celebrative), prevede un’annualità di spettacoli, percorsi laboratoriali e formati misti dedicati all’anniversario della morte di Elsa Morante.
Pochi giorni dopo mi trovo a Napoli, nelle eleganti sale della centralissima Chiesa di San Severo al Pendino per la prima e fondativa Assemblea Nazionale di Illumina, Rete Nazionale per la parità di genere nelle arti performative. All’Assemblea, riservata alle socie e dedicata allo Statuto, segue un pomeriggio aperto al pubblico in cui si presenta il progetto Il mondo salvato dalle ragazzine, proposto da 11 enti sul territorio nazionale e capitanato dalla sicula Associazione Culturale Madè che, per giunta premiato tra i Progetti Speciali del Ministero (sempre attento alle occasioni celebrative), prevede un’annualità di spettacoli, percorsi laboratoriali e formati misti dedicati all’anniversario della morte di Elsa Morante.
Purtroppo, nonostante un comunicato stampa nazionale e la presenza patrocinante dell’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, la due giorni non riesce ad attirare pubblico più ampio della cerchia delle sue organizzatrici. Nel cuore di Napoli – capoluogo di una delle regioni che, dati alla mano, dimostra tra le peggiori percentuali di presenza femminile nei ruoli apicali – si sente la mancanza di un pubblico, sia esso generalista o composto dalle stesse maestranze femminili che abitano il territorio e che qui, appunto, non abbiamo il piacere di incontrare.
Durante l’incontro, che soffre di una struttura poco solida e diviene presto conversazione poco indirizzata; si parla sì della parità di genere e della necessità di immaginare azioni congiunte nei territori capaci di alimentare una “rivoluzione gentile ma profonda”; ma si parla anche di un’istituzione che si chiude rigidamente nei confronti del territorio e forse anche di un territorio che sempre meno cerca il dialogo con l’istituzione e che la confonde nella pluralità e conflittualità dei propri rappresentanti. Il mondo salvato dalle ragazzine, progetto virtuoso nell’intenzione di promuovere una figura non sempre pacifica nel panorama artistico-letterario femminile italiano, si fa contenitore per una proposta progettuale molto ampia, dai contorni non sempre chiari, eterogenea nelle modalità. Così come un’opportunità per dare rinnovata visibilità a lavori editi ma di vita breve, oppure per realizzare nuove produzioni non necessariamente legate alla figura della Morante. Questo primo progetto collettivo aspira a una dimensione più consolidata, magari a quello che viene definito “un festival diffuso e nazionale” che sappia riunire, a dire delle organizzatrici, esperienze diversificate ma che, insieme, si ostinano nel portare il tema della parità a confronto con i pubblici e i territori. Un progetto ambizioso, specie di questi tempi di vizio nel dialogo con le istituzioni.
Risulta inevitabile, per un osservatore minimamente partecipante, non stupirsi della capacità di un settore come quello dello spettacolo dal vivo di replicarsi e disperdersi nella molteplicità dei processi. Nella molteplicità delle esperienze seminariali che si chiudono con un “stavolta teniamoci in contatto”, “su questo continuiamo a lavorare”, ma che spesso divengono luoghi disabitati. Nel moltiplicarsi di iniziative, ognuna per sé virtuosa, ma che non sono capaci di fortificarsi nella convergenza e che rischiano di disperdere risorse e di generare impatti assolutamente marginali.
Quello che emerge è, spesso, un brulicare di enti, progettualità, individui che fa molta fatica a contestualizzarsi e mettersi in discussione, che preferisce deresponsabilizzarsi unicamente individuando cause esterne e contingenti, che non utilizza, nella maggior parte dei casi, strumenti analitici di valutazione del proprio operato. Un settore che spesso tende a chiudersi, e a dimenticarsi dell’esercizio costante di andata e ritorno dal generale al particolare.
Nelle pause caffè, negli interventi in cui non si fanno nomi, serpeggia spesso, subdola, una forma di rancore affatto professionale, una mala parola che cambia, da contesto a contesto, il proprio destinatario. Torna costante il tema della trasparenza, il tema di un’ipocrisia che avvelena le relazioni di un settore che si ostina nel volersi rappresentare come tale ma che spesso non condivide i presupposti stessi di una lotta sempre più diffusa e che chiede sempre più di essere una lotta totale.
La migliore progettualità finisce, spesso, per cadere nella volontà di marcare la propria differenza e la propria superiorità rispetto all’altra. Col senno di poi, quelle di Bard e Napoli e prima ancora le infinite occasioni di dialogo, costruzione (conflitto poco, anche se forse avrebbe bisogno d’esser sviscerato, prima o poi, ad armi pari) appaiono come prove generali prima della tempesta che, da anni latente e spesso alimentata da comportamenti scorretti e opportunistici, è esplosa ancora una volta a fine maggio nel rapporto con l’istituzione con la I maiuscola, il Ministero. Una tempesta che è appena iniziata, che ci chiama all’assemblea e all’azione pubblica e che proverà, forse definitivamente, la nostra capacità di coesione e quella di tutte le parti civili, la capacità di mettersi da parte per scegliere un catalogo di priorità da ribadire, una forma rappresentativa chiara, professionale, dignitosa.
Angela Forti