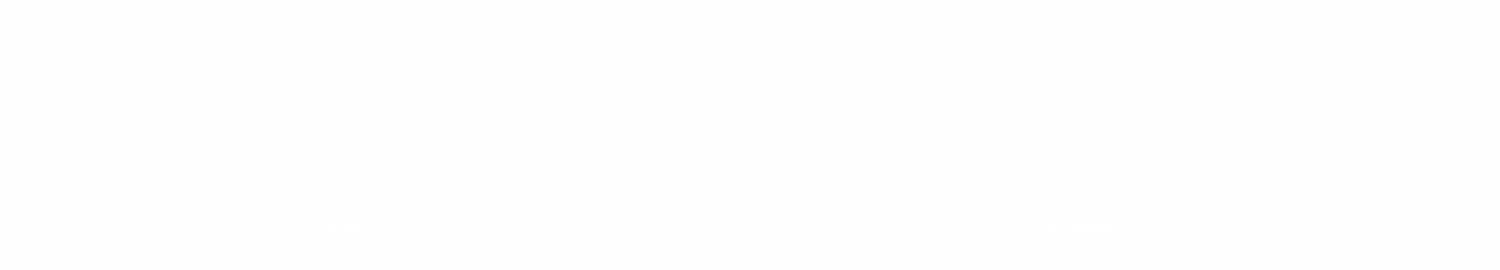Una conversazione con Francesco Villano sul mestiere dell’attore. Villano in questo periodo è in scena con L’eterno marito (da Fëdor Dostoevskij con la regia di Claudio Autelli).
«Di questo mestiere non ho capito nulla» annota Louis Jouvet dopo essersi interrogato per una vita: cos’è il teatro? Chi sono i personaggi? Che rapporto hanno con me? Che vuole il pubblico? E cosa vuol dire recitare? Leo de Berardinis che a ogni micro-scoperta associa notti di tormenti; Isa Danieli che a Roma, davanti a ragazze e ragazzi che le chiedono come fa ciò che fa non trova le parole. «L’attore è un mistero» afferma d’altronde Roberto De Monticelli dopo aver scritto per un’intera carriera d’attori e di attrici. Eppure, aggiunge, «non si può non parlarne». Magari direttamente con loro. Con Francesco Villano ad esempio: interprete, performer, insegnante di recitazione in vari moduli didattici, in collaborazione con la cattedra di Storia del Teatro dell’Università la Sapienza di Roma; all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma; alla Scuola Europea per l’Arte dell’Attore Prima del Teatro di Pisa e l’Accademia d’Arte Drammatica Ernst Busch di Berlino. Collabora inoltre stabilmente con Carrozzerie n.o.t. a Roma e ha vinto l’Ubu come miglior attore nel 2023. Proviamoci, dunque.

Stanislavskij e le marionette, Reinhardt che s’innamora di ciò che non vede (ma sente) dall’alto della galleria, Kantor che scova il teatro la notte di Natale o, per fare esempi del nostro tempo, i vhs di Eduardo per Lino Musella, Emma Dante a Siracusa (il sole che scalda le pietre, il vento tra i gradoni, il tramonto che cambia luce alla scena), Giorgina Pi che a quattro anni s’affaccia dal palchetto del Petruzzelli di Bari. C’è un’aneddotica degli inizi che riguarda anche te?
Non ho un’epica da raccontare. O un amore precoce. Famiglia proletaria, infanzia e adolescenza con interessi, certo, ma in cui il teatro non c’è né come presenza avvertibile, apparato culturale o in forma di libri né come spettacoli. Solo un breve corso tipo dopo-scuola alle superiori, a 17 anni, fatto con la stessa curiosità con cui m’avvicinavo alla danza o allo sport e che ha avuto l’incidenza che ha un sasso gettato nel vuoto perché poi sono venuti il diploma, a 19 anni il militare («così te lo togli da mezzo», il consiglio di mio padre) e l’università alla Sapienza.
Vissuta anch’essa senza teatro?
Ancora senza teatro davvero. D’accordo, i corsi, le lezioni, il Teatro Ateneo, l’eco ancora percepibile di Carmelo Bene, le parole illuminanti di certi professori e Il punto in movimento di Brook, il nome di Yoshi Oida, le videocassette di Grotowski. Ma erano idee, immaginari, teorie senza il corpo della pratica. Fino ai 22 anni: m’imbatto in un gruppo di professionisti e professioniste (ricordo Sonia Barbadoro, Laura Mazzi, Emanuela Mandracchia), mi intrufolo, lo frequento galleggiandovi. Ci sto, tenendomi in superficie. Loro che dicono «perché non provi l’Accademia?». Io che penso «se mi prendono bene, altrimenti continuo l’Università e faccio altro». Preso. È il 1997.
Ed è stato?
Un risucchio tanto forte da strapparmi a tutto il resto. E un crash conflittuale tra ciò che avevo in testa (l’idea di me e del teatro, inapplicabili entrambe) e quel che lì capitava ogni giorno.
Eppure Louis Jouvet scrive ad allieve e allievi del Conservatoire dicendo loro che l’Accademia serve innanzitutto alla formazione di sé: «Non cercare di dimostrare che sei il personaggio» – non recitare, è presto – «mostraci invece quello che vorresti essere o come cerchi di esserlo e, soprattutto, quello che sei veramente».
Credo dipenda dagli anni in cui capiti, dagli insegnanti che incontri, dalla classe di cui fai parte. Era una fase polverosa, da naturalismo declamatorio italiano, in cui chiedevano di replicare vecchi versi con intonazioni scovate da chi ci aveva preceduto. I fogli con le battute, la sensazione d’essere finito nello scatolone sonoro e fonetico allestito da una generazione d’attori e attrici passata di lì e ora andata via. Ripetere forme vacanti, addosso abiti che non erano per me, e l’idea insopportabile che non mi stessero dando gli strumenti per affrontare un testo, abitare uno spazio, fare uno spettacolo. A questo opponevo un teatro del corpo e dell’energia di cui credevo di sapere ma che non conoscevo davvero. Tant’è, potessi parlare al me di allora direi: Francesco, affronta ciò che capita senza cercare con affanno risposte immediate. Ma avrei capito solo negli anni che più sei libero dalle certezze più è alta la possibilità di scoprire e conoscere. Di contro, m’era già chiaro che una dinamica all’orizzonte non m’interessava.
Che dinamica?
«Sei piccolo» mi dissero. Non giovane, «piccolo». Ti tocca perciò il corridoio all’inizio, dove stare in attesa della chiamata (della fila, del turno, del provino) con cui comincia post-accademia la buona carriera attoriale. Magari facendo l’alabardiere con Stein, Castri, Ronconi. Coi Grandi insomma, fisso sul fondo di scena, con addosso il costume. Avevo invece bisogno di studiare e comprendere, facendo. Per una ragione.
Quale?
Che questo mestiere necessita di pratica. E la pratica s’acquisisce o si passa agendola. Certo, ho casa piena di libri e dissipo la pensione che non avrò in drammaturgia ma è l’esercizio del corpo che forma la preparazione d’un attore. Pestare il legno, tra quattro pareti, con colleghi e colleghe. Per capire quanto più è possibile: non solo la dinamica d’un gesto ad esempio, ma quanto può durare il silenzio o come gestisco il flusso vocale. Per intenderci: in quest’arte tempo, spazio e punto di vista hanno una consistenza materica. E queste cose per essere comprese vanno studiate, fisicamente. D’altronde quando ciò avviene, quando un attore o un’attrice ha un approccio effettivo alla sala, te ne accorgi: perché sa rielaborare una serie di dati e di circostanze esterne di natura testuale o reale (dov’è la quinta, quant’è grande il palco, a quanto dista la prima fila o la mia compagna di recita, quant’è durata stasera la scena, che tempo ho per quest’azione, se la battuta è stata efficace) dando valore alla propria presenza, allo stare qui adesso veramente. E perché è in questo modo che splende. Ma tutto ciò, sia chiaro, deve essere provato, allenato, esercitato, lavorato. Per una vita, sapendo che non avrai mai certezze.

Mi fai tornare in mente Jouvet che prende appunti dopo quasi ogni replica per interrogarsi su cosa significhi essere un attore: «non ho ancora capito». Toni Servillo che al Corriere dice «per me il teatro rimane un mistero», Elena Bucci che ancora studia il suo fare, Ermanna Montanari che prima di entrare sul palco vorrebbe che ogni teatro bruciasse o Roberto Herlitzka, di cui ieri leggevo il dialogo con Emanuele Tirelli (Voglio fare l’attore, Caracò, 2018): «Quando mi dicono “grande attore”… Forse è timore, scaramanzia. Come se tutto potesse sparire. L’ho sognato talmente tanto fin da ragazzo che sentirmelo dire lo fa apparire quasi uno scherzo, un’illusione. Evidentemente ho un’estrema mancanza di sicurezza nei miei confronti. Parlo del modo in cui gli altri possono ricevere quello che ho, mentre non ho nessuna insicurezza nei confronti di quello che ho. Ma un conto è averla e un altro è saperla rendere agli altri. Anche per questo, prima di entrare in scena, mi pare di buttarmi nel mare. Ogni volta posso temere che il pubblico mi cacci via e non ho mai una certezza, quindi sentirmi dire che sono un grande attore… mi sembra impossibile».
Ecco, invece lui, proprio lui, mi è indimenticabile. In ExAmleto per esempio, visto sette volte e in cui porta la voce in maniera sovrannaturale dandomi la sensazione che mi stesse parlando all’orecchio, le sue labbra al mio lobo, col fiato che si riversa nel timpano.
Herlitzka l’ho incontrato da vecchio, e l’ho veduto lavorare piegato, silente, applicato. Una sera, dopo una replica, l’ho pure inseguito. «Vorrei parlarle», «facciamo un’altra volta» mi disse la moglie facendomi capire che quello era il tempo in cui tornavano a casa assieme, passeggiando. E l’ho veduto alle conferenze, senza mai eccessi, proclami, grandi gesti con le braccia, in affermazione di sé. Quest’attorialità seria invece, da studioso e schiva, lontana dalle chiacchiere e che parla attraverso le opere.
D’accordo, ma come si forma nel tempo un attore? Scorro la tua teatrografia, 63 spettacoli, 35 tra registe e registi diversi, dall’Aminta del 1998 a L’eterno marito che Davide Carnevali trae da Dostoevskij, passando per Shakespeare e Bovell, dai lavori di compagnia allo Stabile…
A lungo ho attraversato il teatro come il narratore de La passeggiata di Walser, provando ad acquisire quanto più mestiere possibile con l’osservazione, l’incontro, l’esperienza e la sua condivisione fatta in scena, e tentando sempre di applicare al meglio ciò che mi sembrava di sapere in quell’istante. Mi sono lasciato guidare da quel che organicamente mi accadeva ed è così che piano piano ho compreso che ciò che mi preme è che si riconosca il lavoro, senza una predominanza evidente dell’attorialità.

L’amore che hai per l’interprete che non mostra i ferri del mestiere.
Penso a The Repetition di Milo Rau. A un punto un attore dice che «recitare è come consegnare una pizza. Non è il fattorino che conta. È la pizza». Ho cercato di coltivarlo negli anni, anche quando i progetti non rispondevano a un desiderio ma erano di passaggio, e buoni per farmi capire quel che non m’interessa, ciò che non voglio. In questo percorso c’è tutto: il giovane sottopagato che conviene alla compagnia che ti scrittura; le opere in cui credi e che fai con quel che ci possiamo permettere; la produzione da Stabile/cast da cui ricavi quel che t’aiuta a crescere (il testo, quel ruolo, la collega con cui lavori per la prima volta e che proverai a ritrovare domani), il gruppo cui appartieni anche se sei in stagione con altri; i due mesi di prova per Orgia, in secca a un festival, perché l’opera di Pasolini era più forte di ciò che avrei potuto fare altrimenti.
In una video-intervista del 2023 consigli di «coltivare la propria unicità, perché è quella che infine porti in scena». Hai (co)firmato sei regie (La rotativa, 2005; Sonata per ragazza sola, 2011; Piccoli pezzi poco complessi, 2011; A zonzo, 2013; Genesiquattrouno, 2015; Edeyen, 2017), partecipato a scritture collettive, preso parte a processi compositivi di gruppo ma sei un attore innanzitutto. Mi chiedo dunque come un attore definisca la propria unicità: sono «le scelte compiute tra un’apertura e una chiusura di sipario» per dirla con Strehler? È un modo riconoscibile, per cui «lui è questo tipo d’attore», per citare Garboli alle prese con Cecchi? È una diversità integrata o messa a disposizione di un insieme?
Credo pertenga allo stare in scena, che precede il fare in relazione ai compagni e a un testo, i suoi appuntamenti, gli archi narrativi, gli snodi. L’arrivare alla soglia così preparato, aperto e morbido da consentire alle persone – siano cinque o mille – di guardarti fino ad attraversarti. Questa per me è l’unicità. Che non ha a che fare con la diversità di cui parli perché non penso di portare una differenza rispetto a qualcosa o qualcuno, né sono un attore-autore per cui siedi in platea (anche) per vedere me e il mio teatro. Voglio invece si veda lo spettacolo, che restino in memoria a chi guarda i suoi momenti perché lui o lei continui a interrogarsi ripensandoli. Momenti che io, con la mia presenza, contribuisco a far esplodere. Ecco, più hai forte questa struttura più hai la possibilità di aprire una porta e di farti scrutare. E so che talvolta è accaduto o m’accade. E quando capita dà un senso ulteriore all’incontro.

Le sere «in cui ci si ascolta, ci si sente» scrive Jouvet in Elogio del disordine (Cue Press, 2016) dovute comunque allo studio. E all’accumulo d’esperienze, fallimenti compresi.
Certo, non ha nulla di mistico. È come guidare senza pensare ai passaggi dei piedi da pedale a pedale o alla mano che sposta la marcia. E non è uno stato di partenza, sia chiaro: è l’approdo invece, il punto d’arrivo nella pratica del mestiere. Cui si giunge lavorando sul respiro, le capacità cognitive e sapendo quel che devo fare in scena al punto da potermi permettere di stare.
Te ne accorgi quando succede?
Ti faccio un esempio. In Anatomia di un suicidio mi sono ritagliato un minuscolo pozzo di presenza. Varco la linea degli anni, raggiungo una sedia, piego le spalle di poco, il capo reclina, porto le mani allo schienale. Lì non penso a nulla e sono privo di progettualità: appoggio le mani e sto. Lo spettacolo per me termina qui. Mi godo l’istante, in contatto con un riferimento privato, mentre il resto scorre. C’è chi ha visto quei pochi secondi e li ha fermati in una recensione. Forse erano un pozzo anche per lui. Ecco, questa piccola cosa che fa l’attore e che il personaggio non sa significava per entrambi, era condivisa da entrambi e per entrambi è rimasto. Lo considero un breve stato di grazia. Compartecipata perché ci ritroviamo entrambi, per alcuni attimi, a contatto con sensazioni che c’appartengono.
Perché usi la parola «sensazioni»?
Perché si parla troppo di sentimenti. Non per forza io lavoro coi sentimenti. Le sensazioni invece, che sono elementari, concrete, radicate: caldo e freddo, comodo e scomodo, agio e disagio – per dirne alcune. Il sentimento è la punta dell’iceberg, se viene bene altrimenti si va in scena lo stesso. Tanto quanto stai sul palco in una rete di gioco fatta di appuntamenti fitti.

Mi viene quindi di chiedere del rapporto tra rete e libertà. Ricordo Cieslak quando a Schechner dice che «la partitura è come un vaso di vetro dentro il quale c’è una candela accesa. Il vetro è il solido, sta lì, puoi farci assegnamento. Contiene e guida la fiamma. Ma non è la fiamma. La fiamma è il mio processo interno ogni sera. La fiamma è ciò che illumina la partitura, ciò che lo spettatore vede attraverso la partitura. La fiamma è viva» e aggiunge: «Così come la fiamma dietro il vetro si muove, fluttua, cresce, si abbassa, sta per spegnersi, all’improvviso brilla con forza, reagisce a ogni alito di vento, anche la mia vita interna varia di sera in sera, di momento in momento».
Quand’insegno faccio un esempio. Il pubblico esce di casa, attraversa la città, parcheggia, compra il biglietto, siede, ci attende, ha sete. Dobbiamo portargli l’acqua. Che è il testo e come faremo il testo. Per cui per me la struttura (lo spettacolo nella sua interezza, le singole scene, le dinamiche nelle scene) che io tripartisco (inizio, sviluppo, fine o se preferisci: trattenere, esplosione e rapidità) in frammenti sempre più piccoli – pensa alla rapidità, per cui l’attore deve uscire prima che la scena sia finita così che lo spettatore abbia nostalgia di lui – mi mette nelle condizioni di poter stare con libertà, «di momento in momento» per citare Cieslak. Reagendo a ciò che accade veramente.
E questo «fa tutta la differenza del mondo» nota Erland Josephson in Memorie di un attore, accorgendosi del respiro collettivo che muove una compagnia di cui sta vedendo uno spettacolo.
Fa tutta la differenza del mondo sotto due aspetti, almeno. Il primo: un altro attore non starà mai come sto io e viceversa. Il che ci rende insostituibili, nonostante per certe produzioni pare si tratti solo di cambiare un nome sul manifesto o a foglio paga. L’attore è un essere umano unico, l’attrice è un essere umano unico, e se manca lui o lei cambia la scena tanto quanto cambia il valore di ciò che vivi se sei con una persona che ami o che ti è indifferente. D’altronde se così non fosse staremmo parlando di dialoghi tra personaggi, non tra persone. Secondo: la compagnia. Io so come mi guarda Emiliano Masala, lo conosco, so cosa può dargli fastidio e come ottenere che provi questo fastidio e reagisca. Pensa al sasso che produce i cerchi nell’acqua. Questa è una relazione. E la relazione non è limitabile alla battuta da dire o alla narrazione del testo. È la performazione del testo invece, che sta sotto e che brucia tanto quanto la fiamma cui stavi accennando.
Tutto ciò in una compagnia lo puoi allenare, assieme. Fuori è casuale, nella migliore delle ipotesi.
E questo, aggiungo, è un discorso che riguarda anche il pubblico.
In che senso?
Perché uno spettacolo complesso, prodotto con un cast che non si conosce, in ventuno giorni di prova e, alla meglio, una dozzina di repliche non potrà mai raggiungere i picchi di qualità nello stare che ha una compagnia d’attori e d’attrici che si conosce, si sceglie, che ha quaranta o cinquanta giorni di prove e una prospettiva decente di date future. Sarà banale ma puoi dare di più tanto quanto di più hai frequentato la materia che porti. In caso contrario? Prove risicate, assenza di tournée, sovrapposizioni random di spettacoli – di giorno ne provi uno, la sera fai memoria di un altro – induce a pensare alla partitura, alla costruzione, al bicchiere, per tornare alla metafora. La pièce ben fatta o eseguita, se siamo stati bravi o fortunati. Ma che quanto incide su chi guarda, stando in platea, dall’altra parte?
In queste condizioni un attore o un’attrice non può mostrare la propria unicità. Non ha avuto il tempo, lo spazio, l’opportunità di diventare ciò che sarebbe potuta diventare. Mi viene in mente un libro che sto rileggendo…
Quale?
Stanislavskij alle prove di Vasilij Toporkov (Ubulibri, 1991; Cue Press, 2023). Scrive nel giorno di debutto d’un lavoro: «Adesso hai cominciato il tuo viaggio. Tra cinque anni capirai cos’è il tuo personaggio, tra dieci saprai recitarlo»…

Oddio, Nemirovič-Dančenko che invita Efros a vedere Il giardino dei ciliegi che ha stroncato in prima, vissute le repliche («Non riconoscerà in questo quadro leggero come un ricamo il pesante e faticoso dramma che era il primo anno. Ma se il teatro avesse voluto raggiungere questo risultato subito avrebbe dovuto rinunciare a tutta una serie di particolari essenziali, esistenziali e psicologici che allora balzavano agli occhi per la loro esagerata evidenza mentre oggi balenano come gocce d’acqua leggere e precise»), o Peter Brook che ne Il punto in movimento ricorda che il processo teatrale non ha due tempi (produrre, vendere) ma due fasi: «preparazione e nascita. Una bella differenza», ma anche Thomas Ostermeier che scrivendo dell’Hamlet, visto al Bellini di Napoli, ne Il teatro e la paura (Sossella, 2020) ricorda che «grazie a questo nostro lavoro comune dopo appena nove anni, nel 2008, Lars Eidinger era capace di recitare Amleto». Dopo appena nove anni…
Capisci? Tutto questo è un fatto. Se a teatro non attraversi la materia in una certa maniera rischi la coreografia (nell’accezione superficiale che si può dare al termine) della tua idea del testo. Ma il testo non va informato, didascalizzato o illustrato agli spettatori ma performato. Perché anche soltanto poggiare le mani alla sedia è un mondo. Ed è un mondo come mi guarda Tania [Garribba ndr.] volgendosi, all’inizio di Anatomia di un suicidio e così dandomi un colpo al centro esatto del cuore. Devo averlo provato, anche e soprattutto alla presenza del pubblico. Al quale e con il quale cerco di vivificare l’istante tra due persone perché appartenga a più persone ancora.
Questo penso, e questo sto provando a fare…
E come si riesce a non far morire qualcosa che invece ha centoventi repliche (penso per esempio a When the Rain Stops Falling) così da offrirlo vivificato al pubblico?
La domanda è inesatta perché lo spettatore o la spettatrice di stasera non lo sa che When the Rain ha centoventi repliche. Noi siamo di fronte, faccia a faccia adesso per la prima volta, forse per l’ultima, chissà, per cui tutto appartiene a questo stretto tempo in comune. Inoltre, una buona compagnia arriva sul palco e, rispettando il disegno, cerca di portare il lavoro più vivo possibile. Il che significa pure che quando una scena comincia non so come finisce (se non in una qualche parte per il momento silente del cervello).
Ecco, come riesci a non essere anticipatorio?
Perché pensi e lavori non per risultati ma per forze, linee, direzioni. Faccio Amleto? So che una spada mi trafiggerà. Ergo, combatto fin dall’inizio per non morire. Devo cioè avere un contro-movimento opposto a quello che sarà la fine della scena. Se la scena termina con me e te che diventiamo amici comincio col desiderio, l’idea o l’intenzione che io e te non saremo mai amici. Finché tu non mi farai cambiare idea. Posso fare un esempio?

Dimmi.
L’Otello del 2008, regia di Claudio Autelli. Io Otello, Jago era Lino Musella. Che non ha mai messo la maschera del mellifluo che mi truffa, mi imbroglia, m’inganna. Lino invece tutte le sere cominciava diventando il mio migliore amico, quello da cui attendermi la mano tesa o la domanda sincera «come stai?». E tutte le sere mi sono fidato, sacrificando chi avevo di più caro e cioè Desdemona, finendo travolto dal vincolo che si ristabiliva puntualmente con lui. T’assicuro, è così: gli credevo. Per come mi parlava, per come guadava me (non il personaggio), fino a convincermi per poi convincere di rimando il pubblico. È la relazione, ed è un viaggio. Senza cui faremmo dicitura della trama e la recita degli effetti, rendendoli una caricatura.
L’Otello, l’Amleto ma anche When the Rain Stops Falling, Anatomia di un suicidio o Il Ministero della solitudine. Opere scritte ieri o quattrocento anni fa. Cui associo il concetto di «contro-movimento» di cui hai detto perché, nei materiali d’insegnamento, parli di drammaturgia anche come «una mappatura, aperta e conseguenziale, di eventi causali generati dalle circostanze date e che ostacolano il percorso e spingono gli attori ad attivarsi». Come se un attore s’opponesse al testo tanto quanto, per citare Georges Banu, l’uomo s’attiva contro il tempo e le condizioni che il destino gli ha inferto, cercando di sopravvivere e di lasciare un segno nel mondo. Insomma, infine è una reazione?
Sì, è una reazione. Declan Donnellan (L’attore e il bersaglio, Dino Audino, 2007) ci dice che basta una linea per terra che crei un limite perché tu debba agitarti e lottare. Entrare in scena invece di starsene a casa è già una reazione a qualcosa, dice che la storia o il conflitto c’è stato e che le cose non vanno come dovrebbero. Per dirla altrimenti: il desiderio d’avanzare in proscenio a parlare col pubblico nasce dal fatto che sono scontento, che ho bisogno di convincerti che ho ragione, o che necessito d’aiuto. D’altronde i personaggi non sono dei letterati, potessero non parlerebbero. Se lo fanno è perché hanno un problema. Amleto ha il padre morto e sta in lutto, capo calato, abito nero, sui bastioni, trascinando i piedi tra lacrime, ricordi e letture. Non compie alcuna azione finché lo spettro dice «vendicami» senza sporcarti la coscienza. Lui deve reagire a quel «vendicami» e reagisce male tra l’altro, non sapendo com’è che ci si vendica. È questa sua inadeguatezza che produce un insieme di azioni e reazioni che trovano compimento nella strage. Insomma: per me gli attori entrano in scena in reazione a qualcosa che c’è già stato. E le parole che usiamo, per tornare a Donnellan, «non servono che a tentare di dare ordine al caos».
Penso a Ostermeier quando afferma che «il teatro trova la propria ispirazione, la propria ragione, nella rivolta contro le delusioni della vita. È un’arte che viene fuori dall’indignazione di essere nati». D’altro canto «certe volte ci troviamo di fronte a domande impegnative e nessuno ci ha chiesto se ci andasse di affrontarle» sostiene. Hai citato Shakespeare. Vale anche per i testi scritti adesso e in che modo?
Pensa al mio primo ingresso in Anatomia di un suicidio. Apro la porta, avanzo di poco, Tania è di spalle, non ci siamo guardati, sfiorati, parlati ma dentro ho almeno tre questioni che pulsano sbattendomi nel cranio e contro la pelle: mia moglie ha già tentato di uccidersi e dunque cosa ho sbagliato? (uno), lo rifarà? (due), come posso impedirlo? (tre). Poi lei si volta, i suoi occhi finiscono nei miei e io comincio anche davanti a voi a cercare di mettere in ordine il mio caos.

Ricordo quell’istante e i capelli che mentre si gira le toccano la fronte facendole ombra sul collo, le sue mani poi sul tuo petto e gli istanti di silenzio, con l’indice e il mignolo della destra che le tremano. Ecco, questo mi sembra io lo debba al fatto che lacasadargilla – nei modi che il sistema ti permette, coi compromessi o le mediazioni cui il sistema di costringe – riportandovi sul palco assieme quando possibile sta provando a suo modo a salvare ciò che può nascere solo in una compagnia. Perché ci resti in memoria.
Ti racconto qualcosa che non ho mai detto prima pubblicamente. 2015, Lear di Edward Bond. Ernia, impossibile camminare, collo bloccato. E con addosso certe botte che l’esistenza in quel momento m’ha dato. Prove saltate di continuo. Le dico «toglimi, protestami, sostituiscimi pure». Mi risponde «t’aspetto». Mi ha atteso davvero. Ecco, se dieci anni fa Lisa non mi avesse aspettato non so poi che teatro avrei fatto. Forse non so neanche se avrei ancora fatto teatro.
Quel «ti aspetto», per intenderci, è un patto fondativo. Che prima di contribuire a formare un ensemble di lavoro, una costellazione di persone, ha funzionato come snodo decisivo della vita.
Alessandro Toppi