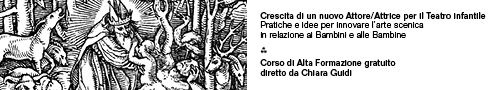Dal 12 luglio al 12 agosto a Borgio Verezzi la 59a edizione del festival che ha visto passare i grandi nomi del teatro novecentesco, dalla scorsa edizione diretto da Maximilian Nisi che abbiamo coinvolto in una conversazione per affrontare temi caldi della politica culturale recente e scoprire le condizioni in cui opera un festival di questo tipo. Intervista

C’è un festival giunto all’edizione numero 59 a Borgio Verezzi, sulla riviera ligure di ponente. Eppure, negli ultimi decenni almeno, raramente è stato raggiunto dalla carovana che viaggia per i festival teatrali d’Italia. Qual è la sua storia?
Quello di Borgio Verezzi è un festival nato nel 1966 per volontà di Enrico Rembado che all’inizio pensava di aver dato vita a una creatura del tutto personale, poi invece si accorse di aver creato qualcosa di comune di cui ci accorgiamo ancora, quando qualche persona anziana del luogo racconta di aver portato le sedie per gli spettatori o cucito i costumi per qualche spettacolo; si faceva inizialmente un solo allestimento e ci si lavorava oltre un mese, quindi è un festival cresciuto in sordina. Io sono arrivato qui come attore nel 1997, in uno spettacolo con una compagnia di 30 persone, il Billy Budd di Melville. Ho avuto modo di osservare il lavoro di Rembado prima e di Stefano Delfino poi, che ne ha continuato l’opera, finché lo scorso anno è stata offerta a me l’opportunità di prendere in mano il timone e così dirigere un festival problematico, che si svolge a una distanza proibitiva, in un luogo decentrato che è complicato raggiungere in treno, ma che è un festival molto prestigioso e l’anno prossimo farà 60 anni, dove è passato tutto il teatro italiano e dove ancora le persone vengono con grande desiderio. Ma va tenuto conto che è passato del tempo ed è cambiato il sistema: prima per esempio un debutto qui al festival era una vetrina anche per poi vedere lo spettacolo nelle stagioni durante l’anno, mentre invece ora le stagioni si fanno in anticipo e quello spettacolo non potrà girare se non un anno e mezzo dopo; quindi bisogna riassestare delle cose perché, se questa è la situazione del circuito, allora è chiaro che un comune così piccolo deve rivolgersi all’area del teatro commerciale e insistere forte sullo sbigliettamento per coprire le spese.
Tu senti che la programmazione di questi anni ti rappresenta in pieno, oppure hai volontà diverse, intenzioni, desideri?
Negli anni passati, in cui sono stato qui come attore, devo dire che a volte ho sentito un po’ di disagio perché, nonostante le cose belle e importanti fatte in precedenza, c’era stata una deriva un po’ ridanciana che non mi rappresenta. Con questo non dico che bisogna fare in assoluto il teatro impegnato, perché va comunque considerato che a Borgio Verezzi, luogo vacanziero dove magari si va per svagarsi, c’è una forte necessità di leggerezza, che non vuol dire però superficialità; ho cercato allora in questo mio primo cartellone, dopo quello condiviso con Delfino lo scorso anno, di fare scelte piccole ma significative in una direzione diversa, per salvaguardare prima di tutto il concetto fondamentale di teatralità, ma tenendo anche uno sguardo alla gestione complessiva e alle necessità del pubblico. Per questo in programma si troveranno compagnie solide e poco frequentate, a fare testi di autori importanti, magari però inserendo in queste produzioni fortemente teatrali attori o attrici che possano avere una riconoscibilità cinematografica o televisiva, quindi cercando un equilibrio tra scelte facili o meno facili.
Ma qual è il pubblico che viene a Borgio Verezzi? Cosa si aspetta?
Il pubblico varia molto, la programmazione dura un mese ed essendo un luogo di vacanza dipende da chi passa in quel momento. C’è da considerare anche il clima, perché magari capita un luglio più freddo come lo scorso anno e c’è naturalmente meno turismo. Ma non è un pubblico di bassa cultura, arriva da Milano o da altre città, è un pubblico di professionisti.
E allora perché c’è bisogno di un’offerta commerciale? In vacanza si perde curiosità intellettuale? È un problema di clima?
È cambiato tanto negli anni, ricordo che un tempo per venire a teatro c’era un rito: la gente si cambiava dal mare, si metteva elegante ed entrava ad ascoltare i testi della nostra drammaturgia o commedie esportate. Oggi, per capire la differenza, da quando è iniziata la vendita di quest’anno ci sono spettacoli che hanno fatto il sold out in 48h e spettacoli che fanno fatica. E basta guardare il programma per capire quali siano. Mi sono spesso fatto delle domande su questo, sul perché il teatro che piace a noi sia diventato per poche persone. Può essere di certo la TV commerciale che non aiuta, ma tra l’impegno e la leggerezza manca quella via di mezzo, illuminata, che è in grado di arrivare ad un pubblico più vasto e stratificato, dove l’alto e il basso non ci sono, perché la bellezza – questa è una cosa importante – quella vera arriva dappertutto. Un’altra questione potrebbe essere l’educazione teatrale, perché ti dà coscienza spaziale, ti dà immaginazione. Adesso l’educazione teatrale chi la fa più? Forse le scuole, gli oratori, il teatro universitario, le famiglie? E nel frattempo la stampa, quotidiani o periodici, evita proprio l’argomento “teatro”, ma non è più l’articolo che esce a far venire le persone a teatro, piuttosto è la cura, un certo tipo di promozione che c’è durante l’anno a mantenere un livello di qualità più alto.
Ma appunto vorrei capire meglio: durante l’anno il tuo pubblico che ha la casa in Liguria sta a Milano, mettiamo, dove vive e lavora. In quella città i teatri popolari che cercano di fare arte, anche con qualche apertura più commerciale, come per esempio il Franco Parenti, per dirne uno, sono pieni. Come mai gli stessi poi d’estate non vedono quel teatro ma hanno bisogno di una “spinta” ancor più commerciale?
Ecco, quella cura di programmazione può essere una chiave per evitarlo, anche se ci vuole tempo. Noi abbiamo deciso per esempio di dedicare questa programmazione alla commedia, genere frequentato da Čechov, da Shakespeare, addirittura da Beckett; dunque la commedia non è solo qualcosa che fa ridere e basta, ma qualcosa che oltre al divertimento ti fa pensare ai difetti della politica, alla giustizia sociale. Quest’anno iniziamo con la commedia latina, il Miles Gloriosus di Plauto, della Compagnia del Sole, un testo che attraverso i giochi di parole, i personaggi divertenti, lascia intravedere sempre una denuncia sociale. Quando si legge nelle schede questa definizione si pensa a qualcosa di troppo pesante, ma se è una commedia a portarlo magari è un buon compromesso per raggiungere anche il pubblico che desidera l’evasione estiva. Lo so che c’è una contraddizione, che i titoli su cui ho investito personalmente sono quelli che hanno uno sbigliettamento, almeno iniziale, molto fiacco, ma il mio lavoro è cercare di stare in questa contraddizione e difenderla per garantire al pubblico quel servizio che in realtà non riceve.

Osservando i dati delle recenti assegnazioni ministeriali si nota come, a fronte di un declassamento generale di molti festival, il vostro è stato al contrario premiato con 5 punti in più, passando da 18 a 23. Come ti spieghi questo successo?
È così, ci sono dei parametri, può succedere… Rispetto a quanto accaduto agli altri festival, a me dispiace se chi fa delle scelte per tenere il livello più alto e una certa varietà deve essere penalizzato, magari perché non ha un guadagno subitaneo; deve esserci il modo di salvaguardare certe esperienze con una commissione di esperti adeguata, ma poi l’errore è anche nostro di artisti, c’è bisogno di maturare da questo punto di vista: noi dobbiamo fare arte, che dovrebbe stare lontana dalla politica.
E se io ti dessi come motivazione provocatoria il fatto che il Festival di Borgio Verezzi, con questo tipo di programmazione, anche se con delle differenze notevoli rispetto agli anni scorsi, è nei contenuti un po’ meno pericoloso di altri festival?
Sì, lo posso capire. Ma devo dire che rispetto agli anni precedenti sta diventando un po’ più pericoloso. Tanto è vero che io mi aspetto adesso di arrivare su e sentirmi dire: No, guarda, questo spettacolo il prossimo anno forse non conviene, questo non va bene, perché io già timidamente ho fatto delle scelte ardite rispetto al passato. Fare Dorfman, Pierattini, ma anche lo stesso Leo Gassmann, sono scelte ardite, perché magari fai sì una commedia ma una commedia nera, cattiva, che il pubblico potrebbe non apprezzare. Poi le risorse economiche ed umane che abbiamo a disposizione sono piccole: al festival lavorano quattro persone e dipendiamo dalle istituzioni. Per quello è necessario farsi aiutare dal nome perché un po’ te lo chiede il pubblico, un po’ lo stesso Comune che non sa quando e quanto gli arriverà di finanziamento e deve far quadrare i conti che sono altissimi, tra diaria degli attori, mangiare, dormire…
Infatti, il costo del biglietto – 30 euro circa – è piuttosto altino…
Avendo 21 serate da coprire i conti sono facili: il finanziamento da solo non basta a coprire tutto. Solo così puoi concederti di avere anche spettacoli che vendono poco, prendendoti il rischio. La vendita biglietti copre il 90% del cachet, che è altissima come percentuale. Ma ci sono costi fissi di IVA, SIAE, allestimenti, logistica, sicurezza, promozione, ufficio stampa, prevendita, che tutti insieme richiedono le stesse cifre dei cachet; questi costi vengono coperti per il 35% da contributi privati e fondazioni, per il 50% dal comune stesso e solo per il 15% da contributi pubblici, in massima parte FNSV, molto meno dalle istituzioni locali. Il Comune copre anche il restante 10% dei cachet, il che significa che la macchina Festival va avanti grazie al pubblico affezionato e ad un piccolo Comune che fa uno sforzo immenso, dando benefici in realtà a tutto il territorio. Poi sul discorso dei cachet si può approfondire: se dai un garantito si rischia che la compagnia si senta lontana dal discorso, quindi partecipa poco alla promozione, quando basterebbe magari anche solo che l’artista di nome faccia un saluto sui social per permetterci di stimolare il pubblico e aumentare le vendite, con cui pagare tutto quanto.
Qual è l’ambizione culturale ed economica del festival nella sua prosecuzione, anche banalmente, perché dovrebbe avere maggiori finanziamenti?
Se avessi più risorse mi piacerebbe aprire le cave (una zona caratteristica del luogo ndr) per ospitare un certo tipo di drammaturgia e per fare la tragedia greca classica, che in piazza non funziona. Vorrei la possibilità di selezionare il meglio, per affrontare temi di attualità, colmare la distanza non soltanto tra noi e il pubblico, perché poi uno spettacolo più rischioso devi anche fare in modo che lo vengano a vedere, ma anche proprio tra di noi. Per me infatti è fondamentale fare dei gemellaggi: quest’anno ho stabilito una relazione con il Mittelfest, c’è un protocollo di intesa con il Festival di San Miniato e altri, così come mi sono messo in contatto con il Festival di Siracusa o con il Festival di Verona. Stringere delle coalizioni è importante perché abbiamo la possibilità di realizzare degli spettacoli che possono essere più necessari, più importanti, piuttosto che fare tante piccole cose. Mi piacerebbe poi aprirmi ai giovani, lavorare sul territorio realmente come si fa per esempio ad Avignone dove le persone sono coinvolte, vengono organizzate attività attorno al teatro, perché in una zona come la nostra, in inverno, dove non c’è niente, avere degli enti o degli associazioni che fanno il teatro e tolgono queste persone dalla strada è importante: il teatro ti può migliorare, bisogna lavorare per far sì che uno spettacolo nel momento in cui abbandona la piazza possa cominciare, non che finisca.
Simone Nebbia