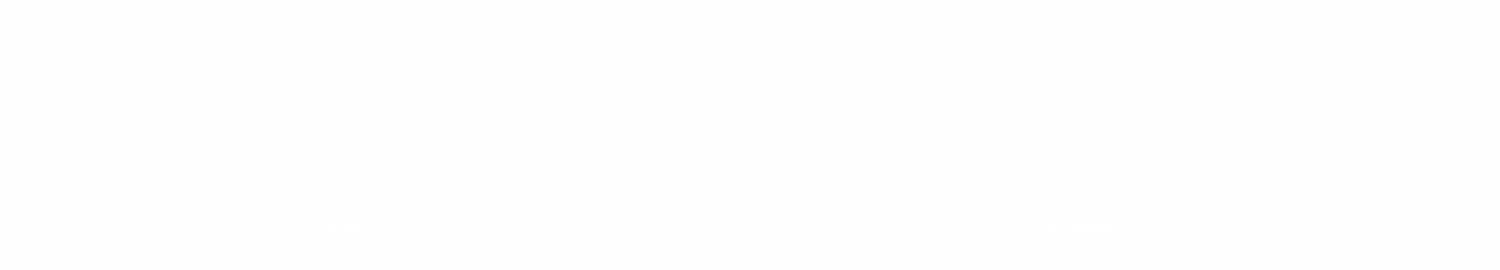Da Centrale Fies, per il festival Raical Love, un’intervista a Sotterraneo, compagnia fiorentina che nel 2025 ha festeggiato 20 anni di attività

Ho incontrato i Sotterraneo nell’interstizio tra due performance a Centrale Fies, durante i giorni di apertura al pubblico che il centro di ricerca ha organizzato dal 17 al 27 luglio 2025. Erano ospitati all’interno della sezione RADICAL LOVE, in cui gravitavano alcune delle realtà italiane che da anni collaborano con Centrale Fies: tra loro, DOM, Marco D’Agostin, Silvia Calderoni. La sera prima, la compagnia fiorentina, parte del progetto Fies Factory, aveva messo in scena la produzioni degli ultimi tre anni: L’angelo della storia, spettacolo che prende le mosse dalle Tesi di filosofia della storia di Walter Benjamin; Il fuoco era la cura, rilettura di Fahrenheit 451 di Ray Bradbury; e Dj show – Twentysomething Edition (2025), cortocircuito tra il linguaggio del club con quello della controcultura acida evocata dagli ultimi scritti di Mark Fisher, auspicanti una convergenza di «coscienza di classe, autocoscienza socialista-femminista e coscienza psichedelica» (da Il nostro desiderio è senza nome. Scritti politici. K-punk/1). Un auspicio in linea con la poetica antagonista e anti-capitalista che Sara Bonaventura, Claudio Cirri e Daniele Villa stanno costruendo da esattamente vent’anni.

Una domanda di riscaldamento: che libri state leggendo?
C.C. Io ho appena finito Quando abbiamo smesso di capire il mondo di Benjamin Labatut.
S.B. Io L’arte della gioia di Goliarda Sapienza. Mi era salita la curiosità due anni fa perché un’attrice de Il fuoco era la cura lo leggeva durante il periodo delle prove.
D.V. Io incrocio sempre un romanzo e un saggio. Faccio il secchione. Il romanzo è il terzo volume de Il problema dei tre corpi di Liu Cixin, un autore di fantascienza cinese che racconta una saga di conflitti interplanetari. Il saggio, invece, si intitola We Have Never Been Woke, di Musa Al-Gharbi, un docente della Columbia University che critica le contraddizioni della woke culture americana da un punto di vista progressista.
Ora parliamo di quello che avete presentato ieri sera. Inizierei con una domanda sul fuoco, che nei vostri lavori mi pare una presenza ricorrente e polisemantica: ne L’angelo della storia, è un motore di racconti; ne Il fuoco era la cura, al contrario, è uno strumento di silenzio; mentre nel Dj show è un luogo di cura, di abitazione. Da dove nasce questa attrazione per il fuoco? E come ci avete riflettuto nel corso del tempo?
D.V. È da molto tempo che siamo affascinati dal fuoco inteso come elemento totemico attorno a cui l’Homo Sapiens si raduna per trasformare la realtà in una storia, e quindi per costruire un immaginario, per formare una comunità, una civiltà. Devo dire, però, che ne L’angelo della storia il fuoco è un riferimento di passaggio, mentre ne Il fuoco era la cura è più presente perché il suo ciclo è uno dei sottolivelli tematici che attraversano Fahrenheit 451:si va dal fuoco come strumento di costruzione ed evoluzione culturale al fuoco come bomba atomica, e quindi distruzione

Se in Bradbury quella distruzione provocata dal fuoco ha essenzialmente una connotazione negativa, mi pare che per voi essa abbia un valore più ambiguo. La battuta del capitano Beatty «Fuoco = Silenzio» riassume senz’altro la furia anti-intellettuale del potere dominante in Fahrenheit 451, ma ho l’impressione che il vostro spettacolo interpreti questo silenzio come un tempo di stasi rispetto alla iper-produzione di contenuti della società contemporanea.
D.V. È una frase che sintetizza una nostra preoccupazione, ossia che il sovraccarico di contenuti e di narrazioni possibili stia creando uno stato confusionale collettivo che potrebbe condurre a un bisogno di semplificazione tale da far trionfare la storia che funziona meglio, che di solito è quella totalitaria.
C.C. Nella parte dello spettacolo che noi chiamiamo “mockumentary”, gli attori, rispondendo a delle fantomatiche domande dal pubblico, si dicono effettivamente sollevati dai roghi dei libri e dalla semplificazione che questi hanno portato con sé.
S.B. Mentre il fuoco dell’ultima scena, che vede riunirsi gli uomini-libri, è il fuoco di cui si parlava prima, cioè quello attorno a cui si può provare a elaborare delle narrazioni costruttive.
Ma la narrazione non è sempre e comunque un esercizio di semplificazione del reale?
S.B. È questa la contraddizione che ci interessa. Il fuoco di Beatty cerca la semplificazione proponendo un unico racconto, quello autoritario, che fornisce un’opinione preconfezionata, rilassante, lontana da ogni possibile interpretazione. Ma gli esseri umani, spinti come sono da un bisogno interno di narrazione, cercano spiegazioni alle cose che vedono: per questo Bradbury, con il suo finale aperto, permette una riemersione delle varie narrazioni, delle contraddizioni, sicuramente della confusione, ma anche dell’arricchimento cognitivo.

Questa narrazione interna di cui parlate può essere legata anche a un bisogno politico. Pensate che il vostro sia un teatro politico? O preferite l’aggettivo “militante”?
D.V. Teatro politico? Assolutamente sì, nel senso di un teatro che cerca di stare a contatto con i problemi del proprio tempo e cerca di analizzare quello che Walter Benjamin chiamava il “divenire storico”, cioè le trasformazioni che attraversano la società di cui facciamo parte. Fare un teatro politico vuol dire chiamare a radunarsi il pubblico per condividere un problema attraverso una strategia di trasfigurazione teatrale, che non intende risolvere il problema, né proporre soluzioni, né indicare dove stia il giusto e lo sbagliato – e in questo senso quindi non definirei il nostro un teatro militante. Si tratta, piuttosto, di allenare noi stessi e chi partecipa ai nostri spettacoli a stare ravvicinati a quel problema, a leggerne la complessità e le zone grigie.
Ma come si fa ad affrontare la complessità del reale stando dentro la bolla di consenso in cui sembra essere immersa la nostra comunità teatrale? C’è un modo per generare delle crepe al suo interno o, addirittura, per uscirne?
D.V. Pur consapevole della necessità di una complessa alleanza d’intenti tra artisti, operatori, critica e pubblico, io credo che il primo passo sia allargare l’uditorio, cercando di praticare quei linguaggi artistici che producano un po’ più di biodiversità nelle comunità che frequentano le sale teatrali. Il punto, infatti, non è tanto il “cosa” si dice, quanto il “come”. Non in termini di sperimentazione formale, ma metodologici: come poniamo i problemi, come trattiamo i temi, come raccontiamo il nostro tempo. Il teatro deve essere una palestra cognitiva di complessità, che alleni alla frustrazione di non avere una soluzione.

A proposito del “come”: in molti ragionano sulla difficoltà di restituire scenicamente il reale; voi addirittura sull’impossibilità di percepirlo, disseminato com’è nei vari modelli di realtà. Ma se il personale modello di realtà è l’unica nostra certezza; se il reale non esiste e ci è data solo la percezione; se, conseguentemente, crolla qualunque modello morale in grado di orientarci all’interno del mondo, perché sparare nella culla di Adolf Hitler? [riferimento a Dies Irae, prodotto dai Sotterraneo nel 2011]
D.V. Ma noi non pensiamo che il reale sia percezione. Noi pensiamo che la condizione umana preveda una riconfigurazione della complessità della realtà, sempre in un formato narrativo che tende a semplificare, a privilegiare certe informazioni rispetto ad altre, guidato da tutta una serie di automatismi neuropsicologici che sono in gran parte al di fuori del nostro controllo. Questo non vuol dire che il reale là fuori non esiste, al contrario vuol dire che, come specie, dobbiamo farci consapevoli che abbiamo una struttura neurobiologica che non è quella della macchina razionale che si emoziona, ma, al contrario, quella dell’animale emotivo che con grande sforzo cognitivo e grande dispendio di energia e calorie riesce ad avvicinarsi a una comprensione sufficientemente razionale del reale. Quando, come specie, ci diciamo che essenzialmente siamo programmati per essere scimmie non troppo intelligenti che sopravvivono nella giungla, ma che adesso siamo di fronte alla complessità della civiltà umana del 2025, dobbiamo adottare delle strategie che ci avvicinino a una comprensione del reale. Una di queste strategie è coltivare il dubbio attraverso il teatro: c’è Adolf Hitler neonato in culla, lo vuoi uccidere? Perché? Era solo Hitler il problema o c’era un apparato di cui Hitler era una punta? Che cos’era l’antisemitismo nell’Europa degli anni trenta? Che cos’era il fenomeno dei totalitarismi? Caricarsi di tutte queste domande senza andare in tilt, stare a contatto con quella complessità, avvicinandosi a quello che Umberto Eco chiamava lo “zoccolo duro di realtà”, cioè tutto quello che non si può negare: questo è il nostro pensiero rispetto alla relazione fra percezione e realtà.

Riuscite a immaginarvi un modo diverso dal FNSV (ex FUS) per sostenere economicamente questo allenamento alla complessità?
D.V. Questo è un gioco molto interessante al quale però bisogna giocare in modo serio e competente – il nostro lavoro di solito verte più sul simulare realtà parallele attraverso gli spettacoli piuttosto che sul simulare calcoli amministrativi… scherzi a parte: il funzionamento del finanziamento alla cultura può essere tranquillamente ripensato e riformato. La questione è che, in primo luogo, servono degli investimenti robusti, perché una Riforma non è tale se non è finanziata. Inoltre è necessario salvaguardare il principio politico del teatro pubblico come polmone culturale capace di aumentare il grado di salute di una democrazia, se non si riconosce la necessarietà del teatro pubblico si manca completamente il centro del discorso. Ciò detto, esistono linee di lavoro che già conosciamo e che possono essere implementate: defiscalizzazioni, sponsorizzazioni, decentramenti amministrativi, collaborazioni con turismo e istruzione, integrazione delle sale teatrali con altre forme di socialità (cinema, musei, ristoranti, locali, ecc). Accanto a queste ovviamente se ne possono inventare molte altre, servono proposte tecniche approfondite, quindi sarebbe interessante immaginare una fase di consultazione che possa portare tutti i livelli del sistema dello spettacolo dal vivo a confrontarsi e immaginare una Riforma vera e propria: un’iniziativa legislativa che abbia lo scopo di valorizzare la specificità del teatro nella dieta culturale del paese. Purtroppo non è neanche lontanamente quello che sta accadendo in questo momento.
Matteo Valentini