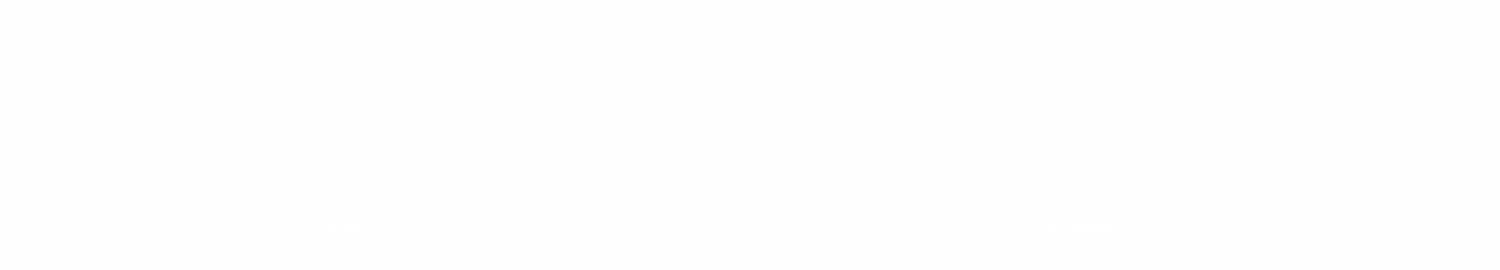Il Festival Contemporaneo Futuro ha promosso una indagine sulle drammaturgie per le nuove generazioni, chiedendo a ragazze e ragazzi di scuola media e superiore testimonianza su preferenze e idee per il futuro. Ne è nato un dibattito sorprendente presentato in forma pubblica al Teatro India durante il festival. Questo ne è un parziale resoconto, sulla base dei contributi offerti da due delle otto classi coinvolte.
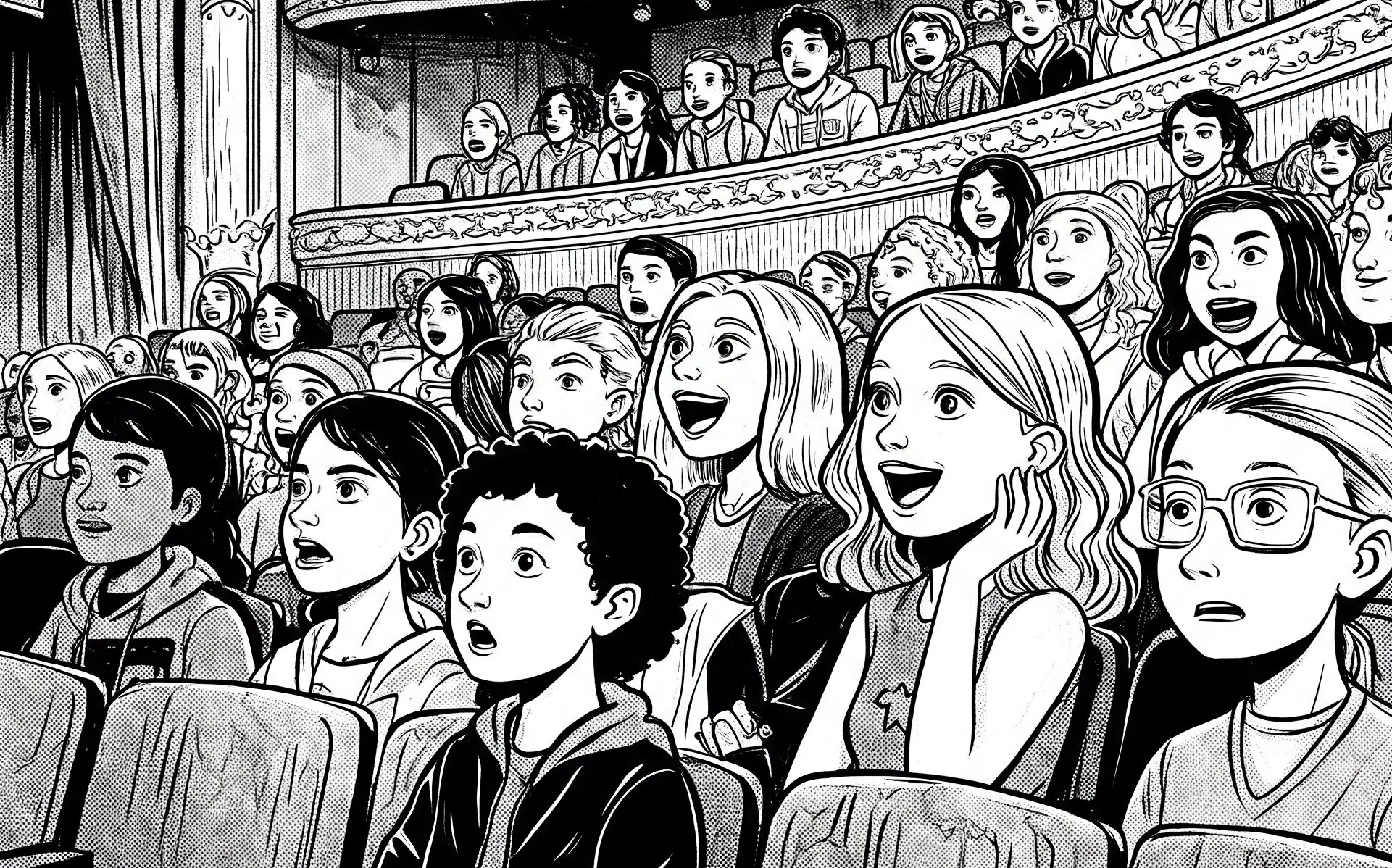
Nel rapporto tra chi pensa o scrive per il teatro e chi, dall’altro lato, ne interpreta le intenzioni sulla scena c’è un terzo vertice, la cui voce talvolta si fa fatica ad ascoltare: il pubblico, chi fruisce l’opera e in fondo ne determina il successo o il passaggio a un archivio di memoria. Se questo è vero per il teatro in generale, lo è doppiamente per quello dedicato alle nuove generazioni, ossia chi vedrà il teatro da ora in avanti e quell’archivio della memoria non può ancora concepirlo: per questo pubblico il teatro è ancora una forma esperienziale primaria, fluida, non mediata da una solidificazione intellettuale. A tal proposito il Festival Contemporaneo Futuro diretto da Fabrizio Pallara per la Fondazione Teatro di Roma, ha promosso una indagine coinvolgendo cinque scuole del territorio romano nell’ambito del progetto La storia siamo noi; tale indagine è stata poi condivisa nei giorni di festival al Teatro India in una sessione pubblica denominata Teatro e Altrove, condotta da Federica Iacobelli e Sergio Lo Gatto e dedicata proprio alla drammaturgia per le nuove generazioni.
Pubblichiamo qui alcuni spunti emersi dalle testimonianze di due tra le otto classi coinvolte, precisamente 57 ragazze e ragazzi – più o meno in parità di genere – della classe terza di una scuola secondaria di primo grado, attraverso un dibattito in classe e una relazione scritta sugli argomenti trattati, sulle ambientazioni e le vicende narrate e sui personaggi che le interpretano. Dai pensieri di ogni studente, certo un campione ben lontano dal potersi dire esemplare, si evidenziano dati interessanti e a volte sorprendenti.
ARGOMENTI
In merito agli argomenti, emerge con molta nettezza come ci sia preferenza non più o non solo per l’avventura, la scoperta, che comunque per alcun* rappresentano ancora un’esperienza interessante, ma soprattutto per tematiche sociali, capaci di mettere chi fruisce l’opera nelle condizioni di confrontarsi con problematiche del mondo in cui viviamo oggi, quindi il bullismo, l’isolamento, i conflitti con i genitori, la violenza dilagante, la differenza di genere, la paura dell’aspetto fisico e molto altro; argomenti “da adulti” con cui potersi confrontare perché offrano spunti capaci di suggerire strategie per affrontare i propri problemi. In particolare, e questo può sorprendere, un buon numero menziona la necessità di leggere storie in cui siano presenti delusioni, sofferenze anche gravi, perché questo fornisca il necessario per quando dovesse accadere a loro. Più che la scelta di tematiche specifiche, risalta agli occhi il bisogno di trovarsi di fronte a punti di vista diversi dal proprio, quindi accettando che questo confronto faccia cambiare idea. Ciò è sorprendente e lascia sperare, considerando al contrario la tendenza adulta a non accogliere facilmente la possibilità di modificare la propria posizione. Un altro punto manifesta interesse: si dovrebbe, scrive una ragazza, “trattare argomenti sensibili ma senza etichettare i giovani in maniera negativa, far vedere quindi che si può essere in maniera diversa e non buoni da una parte e cattivi dall’altra”. Ecco come dunque la necessità sembri quella di eliminare il giudizio nei confronti dei personaggi e delle storie, forse chiedendo che sia eliminato il giudizio anche nei loro stessi confronti. Inoltre – e forse soprattutto – si richiede che gli argomenti producano forti emozioni, quindi affondare nel sentimento perché ne escano risvolti intriganti, non banali che invece rischiano di annoiare.
AMBIENTAZIONI
“Un ambiente completamente immaginario non ci interessa, perché a questa età cominciamo a capire la realtà”, questo dice uno dei ragazzi. E dunque si tratta di una esigenza sviluppata nel tempo e non ferma al gusto, ma definita attraverso la trasformazione da un’età all’altra. Le ambientazioni realistiche per la quasi totalità degli interpellati sono preferibili a quelle fantastiche (con qualche richiesta di sviluppare trame horror), ribaltando l’idea stereotipata che i giovani abbiano bisogna di evasione, che si rifugino lontano dalla realtà. Dunque, che si tratti di luoghi aperti in cui può succedere di tutto o ambienti casalinghi, scolastici, anche fosse la propria camera, l’idea condivisa è vivere situazioni in cui il contesto, presentandosi come familiare, “fa sembrare il concetto più vicino alle nostre esperienze”, dice una di loro. Eppure c’è chi, rispetto alla virtualità, fa un passo ulteriore suggerendo che l’esame dei sentimenti possa essere fatto all’interno di “ambienti virtuali generati dalla nostra fantasia”. L’emergere della propria fantasia, all’interno di un discorso su ambientazioni che sono il frutto della fantasia altrui, fa comprendere come in fondo il tipo di virtualità richiesto non sia necessariamente ipertecnologico, come può sembrare pensando ai giovani, ma possa bastare quanto del virtuale è già in dotazione alla nostra mente. Un altro elemento interessante è la richiesta che ci siano oggetti comuni capaci di raccontare storie perché semplicemente l’uso ne suggerisce una memoria, quindi la volontà di fidarsi del simbolo come elemento poetico significante, che richiama a un teatro meno classico.
PERSONAGGI
“I personaggi che piacciono a me sono quelli che si presentano prima come esseri umani e poi come personaggi di una storia”. Emerge in percentuale maggiore la necessità che ci siano dunque personaggi reali, poco più grandi della loro età, definiti nelle loro caratteristiche umane ma non descritti completamente, in modo da lasciare spazio all’immaginazione. E poi, che siano solidi, capaci di prendere decisioni difficili ma per lo più all’interno di un contesto riconoscibile, in cui magari tentare di raffigurare i propri problemi quotidiani. La figura dell’eroe o del supereroe, pertanto, non è più calata in una dimensione altra, priva di legami con la realtà, ma deve esprimere i propri caratteri esemplari a partire da una situazione realistica, capace di incarnare le possibili esperienze di un adolescente. Si potrebbe dunque considerare questa scelta come un rifiuto dei personaggi fissi, degli archetipi, ma ciò non stupisce se si tiene conto dell’età in questione, appena fuori dall’infanzia in cui la quasi totalità dei personaggi non ha evoluzione e profondità ma una certa fissità del ruolo (principesse, maghi, cavalieri, ecc), quindi per opposizione questo attuale bisogno di personaggi verosimili e quanto più vicini a sé stessi è leggibile come una reazione, finché da più grandi non possano rintracciare nuovamente un ulteriore livello di profondità nel confronto con l’archetipo. “Adoro personaggi che all’inizio si detestano e si sfidano, ma che conoscendosi iniziano a scoprire qualcosa di profondo l’uno dell’altro”, dice una ragazza che sembra identificare come necessaria la relazione tra i personaggi, indipendentemente da quali ne siano le caratteristiche. Uno spunto ricorrente poi è che si preferiscono i personaggi in trasformazione, la cui crisi è un motivo di interesse per chi li osserva agire, quindi anche fragili ma che sappiano poi trovare, anche grazie all’aiuto degli altri e perché no attraverso la forza dell’ironia, la strada per emergere; dice ancora un’altra ragazza: “Secondo me, vedendo i problemi che molti hanno con l’autostima, portare nelle storie dei personaggi perfetti potrebbe causare nei giovani spettatori un sentimento di inadeguatezza”; le fa eco un’altra voce che dichiara come sarebbe importante che le storie “ci insegnassero ad abolire l’idea che una persona triste sia automaticamente pazza”. La fragilità, dunque, è un tema ritenuto fondamentale, nella direzione di una integrazione non solo nominale ma effettiva, come se queste ragazze o ragazzi sapessero che tutte e tutti possono sentirsi in modo tale da subire un’etichetta difficile da staccare.
CONCLUSIONI
“Più che il lato bello della vita, preferirei andare a toccare il lato più brutto e crudele: durante il periodo dell’adolescenza, infatti, molte ragazze e ragazzi si sentono tristi o persi e, forse, osservare ciò che ci accade nella vita di ogni giorno sul palco può essere utile, per capire come affrontare questi sentimenti”. Cosa chiedono? Ascolto, da un lato, ma anche e soprattutto verità. Questo è un dato determinante è probabilmente il più urgente da discutere: molto spesso vengono trattati ancora come bambine e bambini mentre il loro mondo è già adeguatamente sviluppato per poter gestire l’impatto con gli eventi, mentre la società adulta, mai come in questa epoca, produce limitatori di esperienza per le giovani generazioni, cercando di pulire i contesti in cui si possa incorrere in emozioni forti e difficili, forse temendo che il turbamento eccessivo provochi la conseguenza di sentirsi privi di strumenti per affrontarlo; ma se così fosse cosa accadrebbe? Sarebbe poi tanto strano trovarsi senza strumenti utili e adeguati? In tal modo l’atto di affrontare, spesso, rischia di trasformarsi in un annullamento dell’evento e dei possibili effetti. Se si decide che l’utile è in tutto superiore a ciò che non è utile, che conta solo essere pronti, cosa resta della meraviglia della rivelazione? Cosa dell’esperienza imprevista? Ragazze e ragazzi, che siano loro a portare dentro il buio adult* che hanno perso la torcia e urlano di paura.
Simone Nebbia