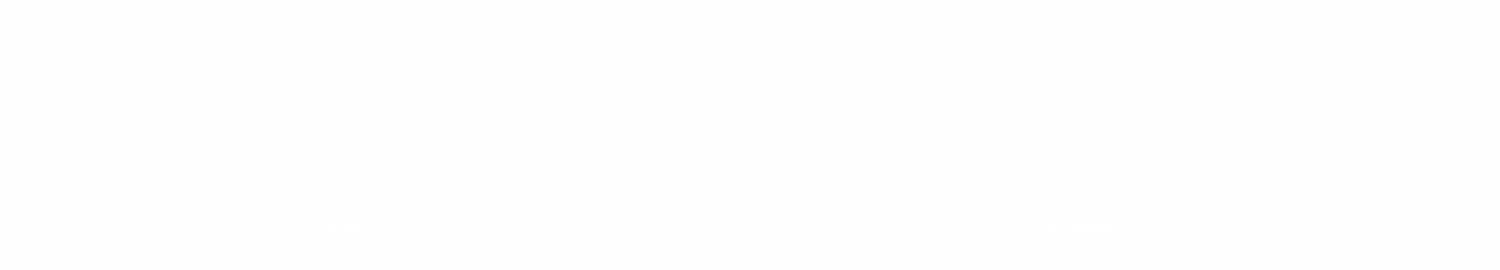| Cordelia | aprile 2025
Tra le tre figlie di Re Lear, Cordelia, è quella sincera. Cordelia ama al di là del tornaconto personale. Gli occhi di Cordelia appaiono meno riverenti di altri, ma sono giusti. Cordelia dice la verità, sempre.
Cordelia è la rubrica delle recensioni di Teatro e Critica. Articoli da diverse città, teatri, festival, eventi e progetti. Ogni recensione è anche autonoma, con una propria pagina e un link nel titolo. Cordelia di aprile 2025 è online da oggi, seguila anche nei prossimi giorni, troverai altre recensioni.
#GENOVA
D’ORO. Il SESTO SENSO PARTIGIANO (regia di Giorgina Pi)
Il regno della memoria e quello dei sogni sono prossimi: in entrambi, le immagini, sottoposte a imperterriti frazionamenti e montaggi, mascherano o suggeriscono speranze, delusioni, paure del passato. A loro, per la stessa ragione, è assimilabile anche il regno del teatro. Deve essere stata questa l’intuizione di Giorgina Pi nel far iniziare D’oro. Il sesto senso partigiano con quattro giovani ragazzi addormentati a cui, in sogno, si presentano otto partigiani e partigiane realmente attivi durante gli anni della Resistenza. Una dopo l’altra, le figure si susseguono sul palco accompagnate da una leggera nebbia e da un oggetto di scena ogni volta diverso (una bicicletta, un forno elettrico, una scrivania…), raccontando le origini e le conseguenze della loro scelta di lotta, le loro avventure, i sacrifici, le violenze, i timori. Gli e le interpreti non sembrano seguire una precisa direzione registica per, piuttosto, affidarsi alle personali competenze e abilità: lo spettacolo assume, quindi, un fare a volte enfatico, dolente e retorico (Francesco Patanè e Aurora Peres), altre volte uno più mobile, ora sarcastico, ora sornione, altezzoso o popolare (Valentino Mannias e, soprattutto, Monica Demuru). Non è disorganico, invece, il modello memoriale proposto da Giorgina Pi, che ricalca quello tradizionalmente inteso nelle tribune politiche e nei monumenti ai caduti: una serie di sepolcri dedicati a personalità eccezionali, oltreumane, degne di indicare un eroico e intatto passato alle giovani ed entusiaste generazioni. Non c’è spazio per le sfumature: le gesta dei patrioti appaiono oleograficamente astratte e imprendibili come in un sogno. Forse non è un caso, allora, che i quattro ragazzi addormentati (attori e attrici non professionisti) piano piano prendano confidenza con la scena e con i suoi protagonisti, vi dialoghino brevemente, si vestano infine da partigiani, con tanto di moschetto e fazzoletto rosso al colo, ma non si sveglino mai, definitivamente intrappolati in un mondo di immagini idealizzate lontano dalla loro contemporaneità. (Matteo Valentini)
Visto al Teatro Nazionale di Genova da un'idea di Gad Lerner e Laura Gnocchi Produzione Teatro Nazionale di Genova Direzione artistica Davide Livermore Drammaturgia, regia e video Giorgina Pi Interpreti Monica Demuru, Valentino Mannias, Francesco Patanè, Aurora Peres e con Silvia Filza, Pietro Muzzini, Mouhamed Ndiaye, Khadija Seye con la partecipazione del Coro di Nuove Partigiane e Partigiani e di Cittadine e di Cittadini, guidato da Mercedes Martini. Crediti completi
#MILANO
BACCANTI Fare schifo con gloria (di Giulio Santolini)
Dioniso è caos, bellezza, violenza, sesso, erotismo, potere; è bestemmia e canto, buco nero ed eccesso, rapimento e liberazione, religione e sacrilegio, croce e delizia dell’umano. Dioniso sono loro, siamo noi, è l’Altro/a, è Me stesso/a. Il debutto coreografico di Giulio Santolini (già performer per CollettivO CineticO, Sotterraneo, Enzo Cosimi) si avvale della drammaturgia di Lorenza Guerrini (pure nella stessa compagnia fiorentina) e ha come punto di partenza la più misteriosa delle tragedie. Euripide non avrebbe mai visto in scena le sue Baccanti e forse nessuno avrà davvero capito i significati profondi di questo dilaniante apologo sulla vendetta, sulla ribellione della divinità contro sé stessa, dove serpeggiano – per noi figli del Novecento – i fondamenti estetico-filosofici della “peste” artaudiana. Nella trama si compie la sanguinosa punizione ai danni di chi non crede nella natura divina del figlio di Semele. Nella proposta di Santolini, però, la sorte delle tebane e il sanguinoso culmine orgiastico sono pretesto per un più astratto affresco sulla forma, il movimento e i suoni del rituale. Mariangela Diana, Ilaria Quaglia, Veronica Solari, nude in scena (e in platea, dove strisciano come serpenti), sono come lembi energici strappati al corpo di questo dio indefinibile. Incantano e provocano il pubblico, parlano un affascinante grammelot che nella musicalità rievoca il greco antico, raccolgono dalla platea il proprio Penteo, che ha il corpo dello stesso coreografo e la voce femminile del coro che le stesse tre officianti consegnano, per completare lo smembramento. Estremamente curata e però liberata da vincoli di partiture troppo rigide è la coreografia di questo generoso corpo collettivo; ingegnosa, se ancor meglio accompagnata, sarebbe l’intuizione di vedere nel regista il virus che ferma una completa liberazione del teatro. Se ancora si assapora un gusto acerbo nella gestione dei significati manovrati dalla drammaturgia, colpisce la fluidità con cui un quadro s’inanella all’altro e questa prova pare un ottimo inizio per un percorso autoriale appassionato e complesso. (Sergio Lo Gatto)
Visto al Teatro Fontana. Crediti: di Giulio Santolini; performers Mariangela Diana, Ilaria Quaglia, Veronica Solari; drammaturgia Lorenza Guerrini; assistenza Coreografica Ilaria Quaglia, Elisabetta Solin; sound design Simone Arganini; light design Lucia Ferrero , Marco Santambrogio; tecnica di compagnia Lucia Ferrero; progetto sostenuto da CollettivO CineticO nell’ambito del progetto IPERCINETICO, da SIAE e MiC all’interno del progetto “Per Chi Crea” e da Sotterraneo
FEDRA (di Jean Racine, regia Federico Tiezzi)
Scritta nel 1677, Fedra di Jean Racine è la tragedia del desiderio impossibile, della nefandezza dell’inconscio, dove la sintassi si fa sempre più inquieta, intrisa di colpa e vergogna. Nello sviscerare la passione erotica di una donna non corrisposta, Racine guarda però alla radice classica, a Euripide e a Seneca, anche se la sua è una tragedia tutta interiore, di cui Federico Tiezzi - con la traduzione di Giovanni Raboni – decide di intercettare e dilatare l’eco psicoanalitico, da Freud a Lacan: si tratta di «un testo di confessioni, ogni personaggio confida a un altro qualcosa che non può esser detto». La scena, cofirmata dallo stesso regista, ricostruisce questa complessa e tortuosa architettura mentale e “confessionale” assumendo un carattere metafisico, sia dominato dal nero abissale che i personaggi abitano sia solcato da tagli di luce fredda, talvolta interrotti da atmosfere magenta che pulsano sanguinose nel dramma. Anche il contrasto tra la radice mitica della vicenda e l’estetica contemporanea – con busti grechi e un quadro di Guido Reni sullo sfondo minimalista – produce un’astrazione segnica conturbante, di straniamento e caos. Di questo linguaggio scenico pulsante, non intravediamo tuttavia un coerente corrispettivo interpretativo, che sia in grado di restituire quella densità letteraria raciniana: come già accaduto nell’ Antigone, i personaggi non modulano complessivamente le sfumature del tragico. Fedra, nella febbrile performance di Elena Ghiaurov, sprigiona fin dal principio solo l’acume del climax tragico, inghiottendo di acuti tutta la scena, mentre l’inquieto Ippolito e la torva Enone, o lo ieratico Teseo, cercano di controbilanciarne l’intensità con un pathos più distaccato, che riesce ad essere esclusivamente cornice marginale rispetto alla tragicità della figura femminile e non ciò che invece la informa. Dilaniato dall’amore impossibile per il figliastro Ippolito, il corpo della donna grida come simbolo di una colpa viscerale che la porterà alla morte. Qui la tragedia collassa nel nero monotono del personaggio, lasciando irrisolto il significato della parola incarnata, tra suono, senso e sua necessaria trasmissione. (Andrea Gardenghi)
Visto al Piccolo Teatro Strehler di Milano. Crediti: di Jean Racine, traduzione Giovanni Raboni, regia Federico Tiezzi, con Catherine Bertoni de Laet, Martino D'Amico, Valentina Elia, Elena Ghiaurov, Riccardo Livermore, Bruna Rossi, Massimo Verdastro, scena Franco Raggi, Gregorio Zurla e Federico Tiezzi, costumi Giovanna Buzzi, luci Gianni Pollini, canto Francesca Della Monica, movimenti coreografici Cristiana Morganti, regista assistente Giovanni Scandella, costumista assistente Lisa Rufini, scenografa assistente Erika Baffico, produzione Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, Teatri di Pistoia Centro di Produzione Teatrale, Compagnia Lombardi-Tiezzi
#NAPOLI
BAÙBO (regia di Jeanne Candel)
«All’inizio abbiamo parlato», tema «cos’è l’amore». Poi una fuga, fermata dal mare. Come mangi il riso, la vergogna d’essere nudi, inventare una lingua perché è solo nostra questa storia. La tua nuca sul collo, starsene chiusi in stanza. E perdersi senza motivo: «È così che l’amore si disintegra?». Agathe ci parla in proscenio, a telo chiuso, con l’uomo accanto che non sa né può tradurre ciò che dice e che prova. Capiamo che: sono passati 647 giorni e 9362 sigarette, lei è «rimasta in albergo», si sente morire. Sipario. Interno, letto sfatto, viso al cuscino. Una sedia a terra, resto d’una sfuriata, una donna in nero (il lutto della sconfitta sentimentale) e un fucile da pesca che Agathe punta al petto. Non s’uccide – altre donne, convocate per un canto funebre la denudano e lavano perché torni a vivere – ma ammazza lui invece simbolicamente, tant’è: va via arrotolato in un tappeto, «è normale abbia fame?» chiede, essendo un morto non morto davvero. Terza parte. Musica, corteo d’oggetti ostentati (il fucile, una pala, un’armatura) per dire che l’uomo è seppellito, la ricerca dello sguardo del pubblico mostrando il pube stampato a mutanda, in ossequio al mito che ispira l’opera: Baùbo, che rimise al mondo Demetra mostrandosi nuda. La regista Jeanne Candel dice che tocca a noi dare senso ai segni proposti. Provo: ripudio d’una mascolinità (sociale, politica, culturale) tossica, il femminile come fertilità salvifica, la dismissione di genere del patimento emotivo. Il passaggio dalla logicità inerte delle parole alla vitalità sussultante del corpo. O una trama di dolore e rinascita. Interessante, ma non per la forma, piena di stereotipie: frontalità, frantumazione testuale, (s)montaggio a vista della scena, richiami alla platea. Tra segni da decriptare e una lunga parte in cui non c’è altro che i musicisti e le musiciste che suonano. Mi chiedo: che ce ne facciamo d’un teatro che non racconta né genera visioni ma s’adopera invece solo ad agire i meccanismi alla base di racconti o visioni? Occhio alla noia, penso citando Peter Brook: dice che qualcosa stasera non ha funzionato. (Alessandro Toppi)
Visto al Teatro Bellini. Crediti: basato sulle opere di Buxtehude, Musil, Schütz e altri materiali, regia Jeanne Candel, di e con Pierre-Antoine Badaroux, Félicie Bazelaire, Jeanne Candel, Richard Comte, Pauline Huruguen, Apolline Kirklar, Pauline Leroy, Hortense Monsaingeon e Thibault Perriard; direzione musicale Pierre-Antoine Badaroux, scene Lisa Navarro, costumi Pauline Kieffer, luci Fabrice Ollivier, collaborazione artistica Marion Bois e Jan Peters, produzione la vie brève-Théâtre de l’Aquarium, coproduzione Théâtre National Populaire, Villeurbanne; Tandem, scène nationale Arras-Douai; Théâtre Dijon Bourgogne, CDN; Comédie de Colmar - CDN Grand Est Alsace;Festival dei Due Mondi, Spoleto; NEST Théâtre - CDN de Thionville -Grand Est; Théâtre Garonne, scène européenne - Toulouse
LE ANIME MORTE (di Peppino Mazzotta)
Le anime morte senza dire i nomi dei personaggi perché la città di N. sia quella di Gogol’ quanto la nostra. Solo una ruota del calesse, degli interni resta una tavola con sopra gli ologrammi di ciò che caratterizza di volta in volta incontri e figure (il grande ricamo, cibo, il fuoco, le candele per una fede falsa quanto l’immagine che vediamo). E dalle 416 pagine la cara struttura dialogica su cui si basa(va) la scrittura teatrale, per la regia fuori-moda e perciò significativa di Peppino Mazzotta, che crede nel valore del testo che ha scelto (nessun riduzionismo pop, nessun abbassamento di livello) e lo coniuga in scena con rigore. Dettagli: il binario/tappeto su cui scivolano le poltrone (l’attraversamento territoriale del libro, che procede per episodi in successione); le proiezioni degli oggetti, coerente con la smaterializzazione delle cose attuata in un romanzo in cui si vendono e acquistano nomi e cognomi defunti; un sentore linguistico meridionale, come fossimo nel Sud de Il gattopardo o I Viceré (la stessa marcia aristocrazia che trasmette modi e immoralità allo Stato borghese). L’orizzontalità che Nabokov vede nella trama resa fisicamente (Cicikov che dorme, il servo che riposa poggiando la testa sulla valigia, la vecchia e l’ubriaco a terra: è la vita già intrisa di morte); un finale che spinge burocrati, possidenti e politici attorno a una giostra (l’eterno meccanismo d’inganno e potere, direbbe Jan Kott) dopo essersi illusi d’aver incastrato Cicikov che, venuto, svanisce: demone tentatore, ha smascherato la nostra corruttibilità. Due pensieri. Il primo, la qualità degli interpreti (nomi nei crediti): in tempi di frontalità, visioni ridotte al proscenio e performer che dicono solo di sé fa bene sapere che resiste la funzione-responsabilità dell’attore (vecchia due millenni) d’incarnare la vita d’un altro per mostrarla al pubblico perché una comunità si rifletta. Secondo: se lo spettacolo non torna l’anno prossimo sarà stato materia gogoliana: sembrava cosa viva, invece il sistema teatrale l’aveva già uccisa. (Alessandro Toppi)
Visto al San Ferdinando. Crediti: testo e regia Peppino Mazzotta, collaborazione alla drammaturgia Igor Esposito, adattamento da Le anime morte di Gogol’, con Federico Vanni, Milva Marigliano, Gennaro Apicella, Raffaele Ausiello, Gennaro Di Biase, Salvatore D’Onofrio, Antonio Marfella, Alfonso Postiglione, Luciano Saltarelli, scene Fabrizio Comparone, costumi Eleonora Rossi, luci Cesare Accetta, contributi digitali Antonio Farina, musiche Massimo Cordovani, produzione Teatro Nazionale di Napoli, Stabile del Veneto-Teatro Nazionale
#Roma
SEMBRA AMLETO (di Francesco Zaccaro, Regia Ivano Picciallo)
Un saltimbanco, un giullare, un figurino da varietà, un buffone con le converse. Un ragazzo, un adulto, un figlio. Francesco Zaccaro occupa tutto lo spazio che ha attorno e dentro di sé e attiva tutto il suo corpo – voce, muscoli, capelli – in un monologo che è un attraversamento, una parabola umana, un rito di crescita. In una lingua musicale e ironica, assistiamo a un dialogo mancato, quello con la tomba di un padre il cui fantasma, in spietato silenzio, tarda ad apparire. Ma vediamo anche un confronto diretto (o forse sognato?) con una madre che ormai è altrove, a una distanza indecifrabile, muta anche lei eppure presente e incombente. Il non detto, il sopito, l’eredità di valori e vincoli pesano come un macigno sulla vita di questo quasi-Amleto che non può fare altro che intrattenere i propri morti, riseppellirli dopo averli animati, rimessi in scena: il dispositivo metateatrale più celebre dell’opera shakespeariana qui diventa avanspettacolo, tra tradizione e tradimento, offrendo tanto l’esercizio godibilissimo di sintesi del classico quanto un affondo laterale inedito sulla figura di Gertrude. Zaccaro ripercorre a zigzag la vicenda del principe di Danimarca, spostando nei suoni la latitudine, ma restando ancorato al portato tragico di un’anima persa che prima di tutto è quella di un orfano. Sulla scena la regia di Ivano Picciallo mette solo terra e pochi essenziali simboli (un fiore, uno specchio, una croce), quelli di un teatro di evocazioni che si regge sul corpo dell’attore, sulla sua espressività generosa e scanzonata e su una lingua poetica e immediata, viscerale. Tra le sue mani l’Opera, l’Amleto, è la bussola per non perdere la rotta, o il segno ineludibile di un destino avverso, granitico, che «sta scritto» e contro cui, invece di prender l’armi, giocarsi le rime. Fino a una finale liberazione, rito di imprecazioni impronunciabili, fiume rotto d’amore e dolore, rabbia e resa. Elsinore e Matera stanno a un passo, se di sangue, radici, identità si tratta. (Sabrina Fasanella)
Visto al Teatro Lo Spazio. scritto e interpretato da Francesco Zaccaro. Regia di Ivano Picciallo. Scene Alessandra Solimene. Luci Joseph Geoffriau. Organizzazione Sonia Polimeno. Produzione IAC Centro Arti Integrate - MALMAND TEATRO
COMMANDER (di Farm in the Cave )
Farm in the Cave è una formazione proveniente dalla Repubblica Ceca sempre alla ricerca di un dialogo tra i diversi linguaggi. Nel caso dello spettacolo del 2022 portato allo Spazio Rossellini grazie ad Orbita e Atcl (secondo di un dittico dedicato a Farm in the cave) il Commander del titolo è il nickname del leader della Feuerkrieg Division, un gruppo neonazista che ha operato in Estonia tra il 2018 e il 2020. Fino a qui non ci sarebbe nulla per cui sgranare gli occhi, i collettivi neonazisti sono purtroppo una realtà europea, solo che in questo caso si trattava di un'organizzazione dedita a fare proselitismo online tra i giovanissimi e il suo leader, Commander, aveva appena 13 anni. Ecco allora che mentre il pubblico si siede nella platea del Rossellini, nello schermo sistemato su un parallelepipedo che incombe sulla scena in loop viene proiettato un video in cui bambini con camicia bianca e cravatta giocano ad acchiapparella: pelle bianchissima, biondi, in salute e sorridenti. Eppure qualcosa di inquietante affiora nei loro sguardi e in quelle divise da perfetto "ariano". Come d'altronde sarà inquietante anche il video successivo, nel quale si vede la camera del ragazzo: un joypad penzola dalla scrivania, c’è un acquario; oppure la scena - sempre proiettata - in cui i ragazzini parlano come adulti di argomenti come sesso e morte mentre mangiano un gelato. La partitura fisica e musicale è potentissima, imita azioni di guerra, combattimenti, fino al grottesco parossismo, alternando soli a coreografie di gruppo, la ricerca è sul gesto, sulla violenza e sulla relazione con la musica dal vivo e il tessuto rumoristico. Una performance totale e sbalorditiva quella diretta da Viliam Dočolomanský (e che è parte di un progetto più ampio sul tema, il quale comprende anche uno sviluppo educativo fatto di video e workshop) che però nulla ha a che vedere con il teatro documentario: costringe lo spettatore a scavare in questa storia (anche successivamente alla visione), a ricercarla nella foresta di immagini e rimandi che compongono la drammaturgia di scena - come per le centinaia di coni che cadono verso la fine alludendo a quei gelati mangiati dai ragazzini-; in un continuo travaso tra performance live e video.
(Andrea Pocosgnich)
Visto allo Spazio Rossellini Concept, regia e coreografia: Viliam Dočolomanský Drammaturgia: Sodja Lotker, Markéta Hrehorová Musiche: Štěpán Janoušek Video: Erik Bartoš, Sláva Pecháček, Karel Šindelář Light Design: Felice Ross Sound Design: Eva Svobodová Con: Andrej Štepita, Gioele Coccia, Nicolas Garsaults, Barbora Ješutová, Matuš Szegho, Hana Vara-dzinová, Štěpán Janoušek, Šimon Janák
CHARLIE GORDON (Teatro Medico Ipnotico/Teatro Caverna)
Dico una banalità che per molti sarà tale, ma per molti altri invece sarà una scoperta: Patrizio Dall’Argine è un maestro indiscusso dell’arte dei burattinai, con il suo Teatro Medico Ipnotico ha dato vita a opere di una rara profondità, attraverso uno stile raffinato che mai si è fatto contorto, ricevendo l’apprezzamento di un ambiente raccolto come quello del teatro per le nuove generazioni (e certo l’intero mondo del teatro di figura) ma restando pressoché sconosciuto al “grande” teatro degli adulti, talvolta frettolosi nel rubricare certe esperienze artistiche come “roba per bambini”, quindi per questo meno interessanti quando quei bambini fossero, in apparenza, cresciuti. Eppure, quella definizione sarebbe salvifica per chi dai bambini riceverebbe una logica imprevista, perduta proprio dagli anni dell’infanzia in una mente adulta. Tale è la riflessione che coglie alla visione di questo Charlie Gordon, spettacolo realizzato insieme al Teatro Caverna e tratto dal racconto Fiori per Algernon di Daniel Keyes, con i costumi di Veronica Ambrosini, in scena al Teatro Torlonia per l’edizione 2025 di Contemporaneo Futuro. La struttura classica della baracca dei burattini, posta al centro della scena e abitata dallo stesso Dall’Argine, è l’occasione per una storia senza tempo che tuttavia a questo tempo nostro rimanda: in un mondo dominato dal denaro e dalla produttività dell’essere umano, non c’è posto per gli stupidi, così che uno scienziato ha messo a punto un esperimento per togliere la stupidità, convertendo all’intelligenza l’intera umanità. Ma sarà possibile far diventare tutti uguali? O non sono forse le differenze che rendono ciascuno speciale, anche se sembra fare poco per la produttività capitalista? Questa domanda, che potrebbe emergere (si spera...) dai discorsi dei grandi, si scorge dal palco rivolta a questi bambini dai 6 anni in su, come dichiarato, sviluppata in una storia esemplare e delicata di bontà e amicizia che rende chiara l’intenzione proprio a tutti e, con sorpresa, anche agli adulti. (Simone Nebbia)
Visto al Teatro Torlonia. Crediti: autore e burattinaio Patrizio Dall’Argine; costumi Veronica Ambrosini; produzione Teatro Medico Ipnotico/Teatro Caverna
MEMORIE DEL SOTTOSUOLO (di Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa)
Quando si pronuncia il nome di questo gruppo – Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa – già se ne intuisce l’originalità che li ha condotti a ideare nel tempo spettacoli complessi e di rara consistenza filosofica. Questa volta la creatività di Marco Isidori e la visionarietà di Daniela Dal Cin, che hanno fondato a Torino la compagnia nel 1986, si misura con il magma urlante in cui Fëdor Dostoevskij ha concepito le Memorie del sottosuolo, racconto in due parti scritto nel 1864 che dichiarava l’urgenza di contrastare il positivismo dal margine estremo della profonda abiezione umana. Siamo prima di tutto in uno spazio ibrido, dedicato al rapporto tra arte e neuroscienze, che risponde al nome di Numero Cromatico, uno spazio di creatività giovane che si ritrova in sala con un entusiasmo per ciò che vedrà imprevisto, positivamente sorprendente. A dispetto di chi sragiona sulla plumbea insensibilità della gioventù contemporanea. Sulla scena è, solo, Paolo Oricco, attore storico della compagnia che con prova magistrale incarna un personaggio di cui si ignora il nome, ma nel cui monologo si rintraccia una forza dirompente capace di scardinare le sovrastrutture di un’esistenza preordinata, compiuta. Cosa c’è di compiuto in una vita che compiuta non è? Oricco è in primo piano, sullo sfondo è invece un’opera pittorica che Dal Cin ha realizzato in omaggio all’affresco del Trionfo della Morte, conservato nel Palazzo Abatellis di Palermo da metà del Quattrocento e ad oggi di autore ignoto; l’opera ricava dall’originale l’intenzione di rappresentare l’umanità stravolta dalla morte, ma allo stesso tempo Dal Cin ne attualizza le figure, come a voler dire che la morte non conosce tempo, ma si tende su ogni epoca con identica indifferenza. La regia di Isidori è vitale e crudele, impone il corpo di Oricco e lo rende allo stesso tempo fragile e inviolabile: fragile nell’impalpabilità della parola, inviolabile nella solidità con cui occupa lo spazio, con cui dunque di quella fragilità si fa carico; nella parola scava fino a renderla puro suono, ne lima i contorni a delimitare il vuoto, la risonanza di quel suono oltre il fonema, oltre il senso. (Simone Nebbia)
Visto a Numero Cromatico. Crediti: una messa in scena di Marco Isidori dal romanzo di Fëdor Dostoevskij; interprete: Paolo Oricco; scenario “Trionfo della Morte” di Daniela Dal Cin; adattamento drammaturgico e regia: Marco Isidori; produzione: Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa 2021
SEAWALL (di Fabrizio Lombardo)
Seawall è una storia. Inizia in uno spazio che non c’è, lì presente, ma prende vita dalle parole di un attore che la narra al pubblico. Ma poi, che ci sia il pubblico è tutto un po’ da vedere. Perché si tratta di una di quelle storie private, raccontate più come un discorso a sé stessi piuttosto che davvero a qualcuno. La scena, come si dice, è spoglia, ma spoglia è pure un po’ la storia, perché si avvia lungo un canale in apparenza banale, mette in fila avvenimenti privi di uno spessore drammaturgico, finché poi avviene qualcosa che cambia tutto, che rimescola emozioni impreviste, disattese. Seawall è un testo scritto da Simon Stephens – rappresentato in tutto il mondo dopo il debutto al Bush Theatre di Londra nel 2008 – che Fabrizio Lombardo ha portato sul palco dello Spazio Diamante, ricavando un’interpretazione che resta sul confine tra il racconto della vita com’è e il dubbio esistenziale sulla vita come a volte non è, mantenendo insieme la dolcezza e lo smarrimento di un segreto dirompente che urla e cui nessuna rivelazione concede ristoro. Ma Seawall è prima di tutto un argine al mare, una struttura eretta per proteggere le aree costiere dall’erosione del mare. Sarà mai possibile? Si può fermare, l’erosione del mare? Il protagonista della storia è Alex, narra in prima persona della sua relazione felice con Helen e del rapporto discendente, come ne fosse figlio, con il padre di lei, Arthur, un uomo nobile a cui si sente legato. Nella villa di quest’ultimo la famiglia – che vive si presume in Inghilterra – passa le vacanze d’estate, in Francia, dove la piccola Lucy sperimenta le occasioni offerte dal mare. Una vita tranquilla, quella di Alex e dei suoi, ma nel suo tono confidente via via appare ciò che rivelerà la frattura sconvolgente, l’evento che romperà l’idillio e darà inizio alla tragedia. Il mare, protagonista silente ma non meno violento, non rispetta i confini della costa, la sua erosione mangia la spiaggia e anche la vita, senza che alcun argine possa porvi rimedio. (Simone Nebbia)
Visto allo Spazio Diamante. Crediti: testo di Simon Stephens; di e con Fabrizio Lombardo; produzione Alchemico tre.
#PRATO
ODISSEA MINORE (Nicola Di Chio, Miriam Selima Fieno)
Cos’è una rotta. Il tentativo di ordinare il caos dei punti cardinali, compiere una scelta definita di una tra le infinite direzioni. Ma una rotta inversa compie un viaggio d’altri, già compiuto, a cercare le tracce di altri viaggi con motivazioni molteplici e diverse. È questa l’intenzione di Nicola Di Chio e Miriam Selima Fieno per questo Odissea Minore, al debutto al Teatro Fabbricone di Prato: indagare i segnali lasciati lungo il cammino dai migranti della rotta balcanica, attraverso una ricerca a ritroso che possa indagare, al contempo, anche i residui della resistenza incisa nei nostri occhi d’occidente dalle immagini riportate, dalle notizie artificiali che poco conservano dell’esperienza diretta. C’è una mappa politica d’Europa alle loro spalle, là dove uno schermo proietta le immagini documentarie del viaggio, mentre uno schermo più piccolo riproduce immagini create dai modellini sul tavolo a centro scena, in presa diretta. Il racconto vocale esplicita le immagini in video, ne costituisce apparato retorico perché se ne colga ogni aspetto; la recitazione è piegata alla resa delle immagini, costituendo dunque spesso un commento in bilico tra il coinvolgimento e il distacco. C’è in questo spettacolo un lavoro preparatorio di enorme portata: due artisti decidono di farsi carico, non tanto da artisti ma da esseri umani, di una storia che vanno poi a vivere sul campo, quello che è un progetto diventa infine vita; ma c’è anche il suo effetto opposto: il carattere documentario – non aiutato dall’impianto musicale di Pino Pecorelli che ha funzione prettamente didascalica – non permette di identificare delle scelte drammaturgiche ben definite, un obiettivo concreto oltre la presentazione del materiale, dunque infine un elemento poetico che lo metta in discussione; le storie migranti restano sullo sfondo – e questa è dichiarata come una scelta – appaiono appena nascoste in questa evocazione della storia rimossa, attraverso immagini di edifici demoliti, luoghi simbolo dove un campo profughi è stato riqualificato come complesso residenziale. Ma, sorge una domanda, cosa sarebbe dovuto diventare? C’è bisogno di una archeologia del rimosso o che quel rimosso proprio non esista? Solo in coda allo spettacolo, ad aprire un ulteriore spunto di riflessione in ciò che chiamiamo oggi teatro documentario, emerge dalla loro voce il dubbio che l’esperienza, essa sola, non basti a dirsi teatro. Quel dubbio scivola via in poco più che un accenno, ma proprio quel dubbio è, profondamente, il teatro. (Simone Nebbia)
Visto al Teatro Fabbricone. Crediti: ideazione Nicola Di Chio, Christian Elia, Miriam Selima Fieno; regia Fieno Di Chio; con Nicola Di Chio, Miriam Selima Fieno; con le lettere di Abdo Al Naseef Alnoeme; drammaturgia Christian Elia, Miriam Selima Fieno; regia documentaria, riprese e video; editing Cecilia Fasciani; musiche originali Pino Pecorelli; scenografia virtuale e disegno luci Maria Elena Fusacchia; produzione Teatro Metastasio di Prato
#GENOVA
STABAT MATER (di Liv Ferracchiati)
Presentato per la prima volta alla Biennale Teatro 2017, Stabat Mater è il secondo capitolo della Trilogia sull’identità della compagnia The Baby Walk, che torna in una forma rinnovata. L’opera vede in scena lo stesso autore, Liv Ferracchiati, nei panni di Andrea, uno scrittore incapace di crescere e assumersi le sue responsabilità, soffocato dal rapporto ombelicale con la madre (Francesca Gatto).
Il protagonista è un uomo nel corpo di una donna, con i conseguenti disagi dovuti al trovarsi intrappolato in un’identità di genere che non gli appartiene. Disagi e insicurezze che non solo si ripercuotono sul rapporto con sé stesso, ma anche sulle relazioni esterne che intrattiene, in particolare quella con la fidanzata (Livia Rossi). Sulla scena, sviluppata su più piani tramite un sistema di impalcature, incombe soffocante la figura della madre, una evocazione che “sta”, come Maria ai piedi della croce, e la cui immagine è proiettata, tramite una videocamera, sullo schermo bianco sospeso sopra la scenografia. Da quella prospettiva, osserva tutto, occhio onnipresente e ammorbante sulla vita del figlio, eppure incapace di comprenderlo. Intanto, mentre il rapporto con la fidanzata si deteriora per l’incapacità dell’uomo di prendere posizione e agire, il protagonista si riscopre attratto dalla sua psicologa (Chiara Leoncini), una donna già sposata e con un figlio. Le entrate e le uscite si sovrappongono in un meccanismo ben oliato, alternando sbalzi temporali tra una scena e l’altra. Un collage di memorie ruota intorno a quello che è il fulcro della vicenda: il rapporto con la figura materna e il processo di autodeterminazione della propria identità. Seguiamo il protagonista nei momenti altalenanti che compongono questo percorso, fino alla battuta finale: “Mamma, vuoi sentirtelo dire?”, in merito al suo coming out come persona transgender. La messinscena termina così, con una domanda di cui non sapremo mai la risposta, ma che si spera porti a una risoluzione positiva, verso la recisione di quel cordone che stringe e soffoca. (Letizia Chiarlone)
Visto alla Sala Mercato Produzione Teatro Nazionale di Genova, Centro Teatrale MaMiMò, Marche Teatro, Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale Regia Liv Ferracchiati Interpreti Liv Ferracchiati, Francesca Gatto, Chiara Leoncini, Livia Rossi Scene Giuseppe Stellato Costumi Laura Dondi Luci Emiliano Austeri Suono Spallarossa Aiuto regia Piera Mungiguerra
L’EMPIREO (di L. Kirkwood, regia S. Sinigaglia)
È una mattina del marzo 1759, in Inghilterra, quando la levatrice Elizabeth Luke, intenta a lavare i panni, viene distolta dalla sua mansione per recarsi in tribunale, insieme ad altre undici matrone, a giudicare un caso di estrema importanza: Sally Poppy è stata accusata dell’omicidio di una ragazzina, ma, dichiarando di essere incinta, sembrerebbe nella posizione di scampare alla forca, diversamente dal suo compagno. Il consiglio di matrone sarà nella posizione di decidere se Sally stia raccontando la verità o meno. È sulla base di queste premesse che ha inizio L’Empireo (The Welkin) di Lucy Kirkwood, su traduzione di Monica Capuani e Francesco Bianchi, per la regia di Serena Sinigaglia. Le donne sono già tutte presenti in scena dall’inizio dello spettacolo, disposte in corrispondenza di sedie color pece, sotto un cono di luce fredda che tanto ricorda la stanza dell’interrogatorio. Le azioni sono evocate, ed è lasciata prettamente all’immaginazione dello spettatore la possibilità di colmare quanto manca sulla scena essenziale, dove sono i fatti a parlare nella loro densità. Assume inizialmente le forme di una lettura teatrale corale dove le donne, fogli alla mano, leggono le proprie battute, salvo poi abbandonare gradualmente i copioni. L’effettivo stato di gravidanza di Sally viene comprovato, ma le donne raggiungono un accordo solo quando è confermato da un dottore. L’autorità della levatrice, il suo sapere pratico e innato, la sua stessa parola, viene così messa in discussione dalla scienza: la conoscenza del corpo femminile e dei meccanismi che lo animano viene sottratta dall’area di competenza delle stesse portatrici, che vengono così spodestate dal loro ruolo di donne e madri. Sally sembrerebbe salva dalla forca, ma la ragazza perde il bambino. E così, mentre guarda atterrita il mare di gente al di sotto delle aule del tribunale che invoca la sua morte, viene risparmiata da Elizabeth che, dolcemente, come una madre che culla un bambino per farlo addormentare, stringe un cappio intorno al suo collo. È nella pietà di una madre che si trova compassione e, a volte, una possibilità di salvezza. (Letizia Chiarlone)
Visto al Teatro Gustavo Modena Produzione Teatro Nazionale di Genova, Teatro Carcano, Teatro Stabile di Bolzano, LAC – Lugano Arte Cultura, Teatro Bellini di Napoli Traduzione Monica Capuani e Francesco Bianchi Dramaturg Monica Capuani RegiaSerena Sinigaglia Interpreti Giulia Agosta, Alvise Camozzi, Matilde Facheris, Viola Marietti, Francesca Muscatello, Marika Pensa, Valeria Perdonò, Maria Pilar Pérez Aspa, Arianna Scommegna, Chiara Stoppa, Anahì Traversi, Arianna Verzeletti, Virginia Zini, Sandra Zoccolan Consulenza allo spazio scenico aria Spazzi Costumi Martina Ciccarelli Disegno luci Christian LaFace Sound design Sandra Zoccolan
#MILANO
LEIBNIZ. UNO SPETTACOLO BAROCCO (di Irene Serini)
«Usar in ogni cosa una certa sprezzatura, che nasconda l’arte e dimostri ciò, che si fa e dice, venir fatto senza fatica e quasi senza pensarvi»: questa era la “regola universalissima” a cui Baldassarre di Castiglione riportava “tutte le cose umane”, e in particolare quelle nelle corti italiane all’alba del Barocco: in questa età di infingimento, il suo Cortegiano diventò un manuale di noncuranza per maschere sociali. Viene in mente appena entrati al Teatro della Cooperativa per assistere a LEIBNIZ. Uno spettacolo barocco, quando le rimembranze accademiche del filosofo secentesco – la monade, il migliore dei mondi possibili – si stemperano nel palco rialzato di parrocchiale memoria, sopra cui Serini, Paris e Balestrieri abbozzano movenze da quadriglia in cascanti costumi rosa carne. E all’ombra della sprezzatura si sviluppa anche la prima parte di LEIBNIZ, suddivisa in quadri che illuminano con arguzia parossistica la smania della civiltà occidentale di misurare e controllare la realtà, insieme a strutturali contraddizioni di cui Gottfried Wilhelm Leibniz rappresenta la sintesi, con il suo frustrato tentativo di ridurre il molteplice all’uno. Gradualmente lo spettacolo si raggruma attorno alla sua figura ed è come se perdesse quell’impudenza da giamburrasca che il sorriso svagato di Serini e lo sguardo aristocratico di Paris gli avevano trasmesso. Le parole che indagano il tormento del pensatore, le consolazioni di Sofia del Palatinato, sua interlocutrice, le esaltazioni liriche declamate a lume di cellulare sembrano emergere da un saggio di psicologia o da un libro di frammenti lirici: suggestive, ma letterarie, irrigidiscono la scena e il contegno delle interpreti. L’apparizione di Balestrieri nelle vesti di Filosofia o il guizzo di Hey dottore dei Prozac+ sono come due mani di bianco su un graffito: non stridono né dissimulano, al massimo confondono. Al netto del suo progressivo appesantimento, la prima produzione con le anime di Z.I.A. al completo dimostra coraggio e suggerisce spunti laddove difficilmente si va a cercare. (Matteo Valentini)
Visto al teatro della Coperativa ideazione Eleonora Paris e Irene Serini regia Irene Serini drammaturgia Eleonora Paris con Alessandro Balestrieri, Eleonora Paris, Irene Serini direzione tecnica Alessandro Balestrieri video e suono Andrea Centonza assistenza alla regia Francesca Repetti sguardo esterno Virginia Landi consulenza filosofica Raffaella Colombo produzione Teatro della Caduta e Z.I.A. – Zona Indipendente Artistica con il sostegno di IfPrana e Qui e Ora residenze teatrali
PERLE SPARSE (Vashish Soobah)
Ci sono spettacoli che non si guardano soltanto, ma che si devono attraversare perché richiedono di abitare uno spazio altro, sospeso, in cui i frammenti della memoria riattivano una narrazione collettiva e si insinuano sottopelle. Perle sparse di Vashish Soobah è un racconto dell’attraversamento, un rituale di ricomposizione affettiva. In scena, un sistema di segni ripercorre le geografie e le acque oceaniche, intrecciando le isole della memoria con quelle della migrazione. Qui, c’è una mappa silenziosa che si compone gradualmente, fatta di fili tesi, tappeti stesi al suolo, video proiettati – che sono frame di terra acqua e radici - appunti visivi di un archivio personale. Ci sono oggetti che assumono un valore simbolico preciso: i sarees appesi al soffitto sono presenze liturgiche legate alla figura materna, tessuti sospesi in una fragranza di incenso che avvolge ogni cosa segnando una cesura con il mondo fuori. Il lavoro, presentato alla Triennale di Milano per il festival FOG e sostenuto da FONDO, network per la creatività emergente promosso dal Santarcangelo Festival insieme ad altri partner culturali, nasce da un’urgenza profondamente autobiografica: Soobah, nato a Catania nel 1994 da genitori mauriziani, parte da sé per riflettere sull’identità diasporica, sulla trasmissione intergenerazionale, sull’eredità coloniale che attraversa i corpi e le biografie. Ma il filo conduttore è quello della memoria, che si fa gesto, ricerca di un archivio orale e visivo, legame parentale: «Lavoro spesso con mia madre - racconta Soobah - perché è la figura di mezzo che mi trasmette le radici». È questa complicità familiare, che costituisce a tutti gli effetti l’asse portante dello spettacolo, che si muove tra i canti séga trasportati in Italia come bagaglio invisibile e l’immagine nitida di un campo di canna da zucchero, simbolo stratificato di colonialismo e resistenza. C’è una delicatezza tutta intima, una cura artigianale, seppur ancora embrionale, nel modo in cui questi frammenti si compongono, in un retro del palco che diventa il luogo ideale per accogliere e riscoprire storie marginali. «Finisco così per riscoprire un po’ come vivevano i miei genitori quando avevano la mia età, come si adattavano in un paese che non era il loro, mentre ora hanno interiorizzato il linguaggio di qui. Perché il cambiamento avviene anche su di loro, non solo su di me». (Andrea Gardenghi)
Visto alla Triennale di Milano. Crediti: di Vashish Soobah, supporto drammaturgico Muna Mussie. Progetto sostenuto da: FONDO Network per la creatività emergente sviluppato da Santarcangelo Festival con AMAT Associazione Marchigiana Attività Teatrali, Centrale Fies, Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, Fondazione Fabbrica Europa per le arti contemporanee, Fondazione I Teatri – Reggio Emilia, Fuorimargine / Centro di produzione della danza in Sardegna, L’arboreto – Teatro Dimora di Mondaino / Centro di Residenza Emilia-Romagna, Lavanderia a Vapore / Fondazione Piemonte dal Vivo, OperaEstate Festival Veneto / CSC Centro per la Scena Contemporanea, Ravenna Teatro, SCARTI Centro di Produzione Teatrale d’Innovazione della Liguria, Teatro Pubblico Campano, Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, Teatro Stabile dell’Umbria, Triennale Milano Teatro
LA FURIA DELLE SIRENETTE (regia Maria Vittoria Bellingeri)
Barbara e Lydia Giordano ci accolgono in piedi al nostro arrivo nella Sala Bausch del Teatro Elfo Puccini: sotto una coppia di slanciate luci al LED che le circoscrivono, si muovono a ritmo lento, producendo misteriosi e ovattati mugolii modulati assieme a suoni elettronici a bassa intensità. Gli abissi del mare non sono esposti attraverso maestosi oggetti di scena, ma suggeriti per via sonora e gestuale, mentre la soffusa luce bianca dei LED ci restituisce un ambiente allo stesso tempo rassicurante e sospeso. A popolarlo, infatti, non ci sono mostri leviatanici, ma due buffe sirene, Olga e Olivia, sorelle protagoniste del testo di Thomas Quillardet, La furia delle sirenette, tradotto da Maria Vittoria Bellingeri, autrice anche della regia, dei costumi e delle scene. La storia inizia con una delle due, Olga, che convince l’altra a lasciare la loro casa natia e avventurarsi per il mondo, senza sapere dove andare e quando, eventualmente, tornare. Il cammino delle due prosegue in maniera piuttosto piana tra abbacinanti scoperte, nostalgie di casa e incontri con inquietanti personaggi – tutti inscenati da Graziano Siressi, capace di essere ora guardingo come una patella, ora dinoccolato come un’anguilla. Nonostante la brillantezza degli interpreti, tuttavia, il testo appare un poco ingenuo, con personaggi monolitici nelle loro volontà, pulsioni e paure, non intenzionato a confrontarsi con le origini radicali della “furia” e, quindi, con un pubblico effettivamente uscito dall’età infantile. A questo fa da contraltare la scena che, invece, emoziona per intero, soprattutto quando si abbandona a se stessa, diventando una camera delle meraviglie di suoni, di corpi e di luci slegata da ogni supporto testuale. La storia sorprende nel finale quando, di fronte a un’insolubile differenza di orizzonti, non avviene una riconciliazione disneyana, ma una separazione lucida e pacata, in cui le sorelle scelgono di seguire ognuna la propria strada. Ci dicono, come canterebbe Dimartino, che sarebbe bello non lasciarsi mai, ma abbandonarsi ogni tanto è utile. (Matteo Valentini)
Visto al Teatro Elfo Puccini di Thomas Quillardet regia, scene, costumi, traduzione Maria Vittoria Bellingeri con Barbara Giordano, Lydia Giordano, Graziano Sirressi composizione sonora originale di FILOQ disegno del suono e direzione di scena Emanuele Pontecorvo luci Maria Vittoria Bellingeri collaborazione al light design Marco Giusti assistente alla regia Margherita Fabbriregia, scene, costumi Maria Vittoria Bellingeri produzione Rosamiranda e Nutrimenti Terrestri con il sostegno di Progetti Carpe Diem (Sardegna), Di Terre e di Acque – Luoghi da custodire, Arti e spettacolo (Aquila, Abruz- zo), Sementerie artistiche (Crevalcore, Bo) foto di Serena Serrani
#GENOVA
ISLANDS (di Carolyn Carlson Company)
Ritorna a Genova la Carolyn Carlson Company con un programma di tre assoli che indagano l’animo umano istintuale, la dimensione rituale e la memoria. In The seventh Man, Riccardo Meneghini attraversa lo stadio della nudità infantile, del trionfo dell’istinto e poi, riluttante come un adolescente ribelle, indossa una camicia rossa, lasciandola aperta sul davanti. Il suo corpo luccica, madido di un sudore che penetra fin dentro il tessuto, la sua fronte è imperlata e gocce cadono copiose infrangendosi sul telo bianco sopra cui danza. Distende al suolo tre camicie, sopra cui cammina ripetutamente, esprimendo forse uno sprezzo per quelle catene sociali che vogliono rivestire di strati il suo corpo nudo e vivo. Le età della vita scorrono di fronte agli occhi degli spettatori come istanze autonome, quasi esistenze a parte, separate l’una dall’altra. A deal with instinct viene presentato in prima nazionale e vede come suo interprete unico e principale Yutaka Nakata. Il controllo del movimento si scontra con il crescendo della tensione musicale, in un eterno contrasto tra l’esercizio dell’equilibrio della mente, placida spiaggia, e il maremoto dell’istinto, pronto a infrangersi sul lido e a trascinare via con sé gli ultimi rimasugli di autocontrollo. Room 7, interpretato da Tero Saarinen, affronta il tema della memoria che, come lo strascico del suo costume, ci si trascina inevitabilmente dietro. Tero gioca con i fantasmi delle persone che abitano quella stanza e che fanno tutte parte di un frammento di ricordo, fino al distacco definitivo. Lo strascico cala sul tavolo e sulle sedie, e Tero prende posto in disparte, sotto una lampadina appesa a un filo, rivendicando la possibilità di lasciarsi il passato alle spalle e sancire, così, un nuovo inizio. Grazie alle musiche evocative e alla cura dell’apparato illuminotecnico, prende vita una dimensione altra in cui ci è permesso sbirciare, spiando quelle pulsioni e quei meccanismi segreti che ribollono sotto la superficie. Carolyn Carlson denuda l’animo umano e ci piazza di fronte a uno specchio. Siamo noi a scegliere di guardare nel riflesso. (Letizia Chiarlone)
Visto al Teatro della Tosse. Visto al Teatro della Tosse. Crediti completi
EDIPO. UNA FIABA DI MAGIA (di Chiara Guidi)
“Io chi sono?” è la domanda che svetta su un cartello tenuto in alto, ben visibile agli occhi del pubblico di piccoli spettatori a cui è rivolta, e forse un po’ anche a me, l’adulta intrusa ad uno spettacolo per bambini. Una messinscena che di infantile, però, ha ben poco: il tema della ricerca dell’identità da parte del soldato zoppo si intreccia con quello della sfida verso l’ignoto per ottenere la risposta. Infatti, quello che poi si scoprirà essere Edipo, giunge al cospetto della misteriosa Sfinge per porle la sua domanda. La creatura ineffabile è semplicemente una voce dietro un telo candido spesso e gonfio, che si agita come Edipo lo fruga con le mani, nel tentativo di risalire alla fonte. Risolvendo l’enigma della Sfinge, Edipo riuscirà finalmente a penetrare oltre la coltre, trovando al di là un giardino arido. Alcuni bizzarri personaggi, con indosso costumi grotteschi, fanno la loro apparizione: il giovane Tubero, con il suo dorso coriaceo, desideroso di crescere, tormenta il Bulbo con una pioggia di domande. Si chiede quando giungerà la Primavera, e perché questa sia così connessa allo svelarsi della Verità. Si consulta con gli abitanti di questo paesaggio arido: i rami secchi, il ragno, il rapace Creonte, la restia talpa Tiresia e, infine, Madre Natura, che svetta in posa materna, statua erosa dal tempo, al centro del giardino. Il luogo in questione è stato privato della sua vitalità dal compiersi di un atto terribile: un uomo di nome Edipo vi ha ucciso il re. Edipo inizialmente nega, poi finisce per accettare la Verità e assumersi le sue colpe. Gli abitanti del giardino insorgono, ma Madre Natura invoca il perdono, non solo da parte di questi ultimi ma dello stesso Edipo nei confronti del suo misfatto. Sulle note di un sottofondo musicale persistente e dissonante che contribuisce a creare un’atmosfera surreale, Chiara Guidi, in dialogo con Vito Matera, presenta al pubblico una fiaba delicata, privata degli aspetti più truci della vicenda sofoclea, eppure in grado di pizzicare le corde nascoste del cuore. (Letizia Chiarlone)
Visto al Teatro della Tosse ideazione Chiara Guidi in dialogo con Vito Matera con Francesco Dell’Accio, Francesca Di Serio, Maria Bacci Pasello, Vito Matera, Daniele Fedeli e con le voci di Eva Castellucci, Anna Laura Penna, Gianni Plazzi, Sergio Scarlatella, Pier Paolo Zimmermann musica Francesco Guerri, Scott Gibbons cura Irene Rossini scena, luci, costumi Vito Matera produzione Societas coproduzione Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale
#Roma
SECONDO LEI (di Caterina Guzzanti)
Sul palco della sala Petrassi c’è una pedana con uno sfondo bianco opaco: il palchetto servirà, attraverso una botola, a far cadere la protagonista in una sorta di piano inferiore, quello dell’inconscio; la tenda opaca avrà il compito di fare da schermo per qualche gioco d’ombre. Una giovane donna, vestita di rosso è seduta, appoggiata alla pedana: spiega come prima fosse una donna viva. «Ho la sindrome del cane pastore», così parla della sua tendenza ad organizzare le serate con gli amici. Poi arriva lui: «ci siamo innamorati spostando sedie e unendo tavoli», un’immagine che poi diventerà anche una canzone alla Myss Keta. Chi fosse venuto a teatro per ritrovare le maschere comiche, quelle politiche più graffianti con le quali Caterina Guzzanti ha rinnovato (insieme ai suoi fratelli la comicità televisiva dalla fine dei ‘90) ha forse sbagliato epoca. E aggiungiamo, per fortuna, perché altrimenti non avremmo avuto la macchina teatrale di precisione andata in scena all’Auditorium. Un lavoro che non si appesantisce di inutili orpelli, sia dal punto di vista scenico che drammaturgico: la scrittura della stessa attrice (un debutto registico e drammaturgico) è infatti un efficace meccanismo che fa riflettere su un argomento tabù come l’impotenza maschile, ma è anche ammantata di una poetica leggerezza, «io la notte vengo esclusa dal respiro del mondo», afferma la donna quando ormai la crisi è conclamata. Federico Vigorito è una spalla perfetta non solo per innescare le trovate comiche di Guzzanti ma anche per impersonare la maschera di un uomo tragicamente immobile. I due non riescono a fare sesso, lui si intesta tutto il problema ma non si impegna per risolverlo, non ha il coraggio di chiedere un aiuto esterno e così la relazione si trascina nei mesi, addirittura negli anni senza riuscire mai a cominciare davvero. Eppure i due si amano, anzi proprio per questo lei cerca di non dare troppo fastidio; «io ho bisogno che tu abbia bisogno di me» afferma lui palesando così la figura fragile di un’uomo che non è in grado di vivere con una donna libera e autonoma. Ma il sesso forse è solo la parte per il tutto, ci sono paure che pietrificano e impediscono che la vita possa sbocciare. (Andrea Pocosgnich)
Visto all'Auditorium Parco della Musica Scritto e diretto da Caterina Guzzanti, con Caterina Guzzanti e Federico Vigorito. Prossima data: 19 giugno 2025 Campania Teatro Festival
NON È UNO SPORT ACQUATICO (di e con Daniele Parisi)
L’estate è fatta per fare cose e raccontarle, oppure non fare niente e aspettare che i fatti accadono. In questa intercapedine del tempo tra smania e apatia, in cui ci si divide tra chi può e chi non può farsi le vacanze, Daniele Parisi colloca il suo condominio di Non è uno sport acquatico, monologo da lui diretto, interpretato e presentato al debutto a Fortezza Est. Nella sonnolenza di un pomeriggio d’estate, l’avvocato Fideli sale sul cornicione del palazzo per suicidarsi. Il fatto è il motore d’innesco che aziona un bestiario di voci, dialetti e posture che Parisi incorpora e colora con cadenze dialettali, gestualità caratterizzanti, mimiche camaleontiche e vocalizzi in loop. Parisi è il condominio: vestito con pantaloni e camicia, servendosi di microfono e pedale campionatore, è Antonio, il portiere, ma anche l’artista Pinetti, il napoletano Fusco; è Calogero Intorchia - diremmo la nemesi siciliana di Antonio – è pure l’erborista Tassi, l’ottuagenaria signora Pieri, e la famiglia Giuliotti, compresi i figli che vorrebbero giocare in cortile a “Estorsione”, “Tangenti”, “Rapimento”. I condomini sono appellati per cognome, a ribadire una distanza di classe, il portiere invece, è solo (un) Antonio. Da quello regressivo di Ballard (High Rise e/o Condominium, 1975), alla guerriglia di quello fantozziano (Fantozzi subisce ancora, 1983), a quello dei drammi irreversibili di Nick Hornby (Non buttiamoci giù, in inglese A Long Way Down, 2005), il condominio è da sempre una sineddoche di mondo e nel suo Parisi, con virtuosismo autoriale e finezza attoriale, fa precipitare tutta l’umana commedia delle riluttanze e vanità, tanto meravigliose quanto grette e meschine. Anche se verrà rimossa presto, il portiere Antonio si congeda nel finale raccontando che sul mattonato ristrutturato e bianco del cortile di questo palazzo come tanti rimarrà l’alone di una macchia indelebile, di quelle che stanno lì a ricordare certe cadute che non andrebbero mai dimenticate, un po’ come quella, umoristica, nel salotto de Il Fantasma di Canterville di Wilde che proprio non se ne andava via… (Lucia Medri)
Visto a Fortezza Est: di e con Daniele Parisi, con il sostegno di Fortezza Est
BLUSH (di C. Josephine, regia M. Cotugno )
«Mi piacerebbe tirargli fuori i bulbi oculari uno per uno, fino a farlo trentamila volte, schiacciandoli sotto il mio peso…». Sono le prime parole pronunciate dal personaggio DONNA UNO in Blush dell’inglese Charlie Josephine, autore non binario cui riferirsi con lui/loro, nello spettacolo con regia di Marcello Cotugno che al Teatro Biblioteca Quarticciolo ha diretto in scena Arianna Cremona e Claudio Righini, assegnando loro i ruoli di DONNA UNO, DONNA DUE E DONNA TRE, e le parti di UOMO UNO e UOMO DUE. Il testo, tradotto da Marta Finocchiaro, e prodotto dal Teatro La Contrada, verte sugli abusi a mezzo immagini sessuali postate sul web. La rabbia della battuta citata appartiene a un personaggio femminile la cui sorella diciottenne ha subito 30.000 visualizzazioni di suoi ritratti nudi ad opera del suo ex fidanzato, con tentativo di suicidio della ragazza vittima. L’indole più proletaria della DONNA DUE è messa alla prova da selfie pornografici maschili che malgrado tutto creano un’ignorante intimità, senonché l’uomo poi sparisce e lei verrà così ghostata: la rivalsa consisterà nel leggere in un parco pubblico una lettera ad alta voce. DONNA TRE è un essere fragile, e le sue foto intime scatenano un ricatto virale, al punto che su un autobus le parrà d’essere riconosciuta da un passeggero: ma nella sua condizione lei troverà un modo per fare pace con sé stessa, accettando la vergogna diffusa e le conseguenze. UOMO UNO è maturo, è un capofamiglia, ma ha inclinazioni per ragazzine postadolescenziali, andrà incontro a un corto circuito visuale quando avrà di fronte il corrispettivo del manifesto di Hello Kitty conservato in casa da sua figlia. Il carrierista UOMO DUE ha incarichi di conferenze a New York, ci prova con una che si ribella, generando un caos bestiale: su Twitter. I due interpreti lasciano qua e là attoniti, tanto veloce è la loro bravura. E come sempre Marcello Cotugno, alter ego di Neil LaBute, ha guidato un imperdibile puzzle scomodo, con pochissime vie d’uscita. (Rodolfo di Giammarco)
Visto al Teatro Biblioteca Quarticciolo traduzione di Marta Finocchiaro regia, disegno luci e colonna sonora di Marcello Cotugno con Arianna Cremona e Claudio Righini scene di Luigi Ferrigno musiche Rival Consoles, Frank Zappa, CHVRCHES, Graham Lambkin, The Books, Crass, Thomas Ross Fitzsimons, Scala & KolacnyBrothers produzione La Contrada
#NAPOLI
TEKKEN DRAMA (di e con Francesca Becchetti, regia di Alice Conti)
Il mese scorso ha ceduto una mensola. Mi sono chiesto quand’ha iniziato a rompersi davvero. Il perno che si piega, la calce che si sgretola senza farsi vedere. Il fatto mi torna in mente guardando Eveline (Francesca Becchetti) non se dice d’essersi lasciata col «bastardo», che non è qui il punto, ma quando racconta il fastidio che prova per la fine d’un rapporto offensivo quanto un insulto. Eveline soffre per lo schifo perduto, com’è possibile? O, per dirlo altrimenti, quando ha interiorizzato la mano sul culo, le cosce chiuse, il bisogno di coprirsi, la disparità di valore, l’uso subìto della parola «puttana»? Quand’è cominciato? Quando la mensola ha iniziato a cadere? Con la scomparsa del padre? Quando ha notato la mamma fissa, sempre lì? Nei giorni di Mtv? O quando ha considerato più figo il fratello? Le corse fino al muro, Lara Croft, Geri Halliwell, le mosse di wrestling, l’idea che stare coi maschi sarebbe stato più facile. L’idea di somigliare alla madre, l’attesa d’una telefonata. E ora? Sta davanti a un pannello di legno ferito (la cicatrice da cui viene la luce) con le voci nella testa che mischiano spunti pop che fanno ridere il pubblico, frasi misogine da convegno, citazioni femministe e le facili rassicurazioni di un’amica mentre lei avverte una voragine invece, che riguarda anche me (io quando sono diventato l’uomo che sono?), e di cui vuol capire l’origine. Questo mi pare Tekken Drama, tra soluzioni consuete oramai (testo in frammenti, frontalità, microfono in pugno) e un lavoro pluriennale di ricerca (“Sister”, lab triennale per sole adolescenti su affettività e sessualità; “Le disgraziate”, corso di Anomalia Teatro per donne e persone trans) da cui viene il bisogno di parlarne. Un appunto: perché sia anche un atto politico, come sento uscendo da Sala Assoli, dove si svolge il Napoli Queer Festival, occorre una platea che non sia già d’accordo. Dobbiamo porre specchio al Re direbbe Shakespeare, perché avvenga il conflitto. Che altrimenti resteremo ad annuire tra noi. (Alessandro Toppi)
Visto a Sala Assoli. Di e con Francesca Becchetti. Regia di Alice Conti. Scenografia Prisma. Luci Ilaria Bertozzi. Costumi di Simona Randazzo. Produzione Anomalia Teatro, con il sostegno di Montagne Racconta.
THE BARNARD LOOP (di DispensaBarzotti)
The Barnard Loop è il sogno sognato da un altro. Inizia prima che ci s’accomodi in sala, nega ciò che sta compiendo (dormire) e per reiterazione comica, rilanci immaginari e smentita delle attese, distorce il plausibile (un uomo che ha difficoltà a chiudere gli occhi) rendendolo assurdo quanto un incubo. Comincia col sorso di camomilla, la sveglia puntata, la posizione da dare alle mani, le ossa incriccate, il lenzuolo steso o arrotolato a una gamba, il cuscino sulla faccia, il ronzio d’una zanzara, la luce da spegnere, lo squillo al telefono, i tuoni e i fulmini, il letto che cigola – oddio, ho sentito uno squittio simile a quello dei topi – e termina con la scena d’un crimine e un tuffo in valigia dopo aver mostrato libri che bruciano, frame di Frankenstein junior e cupecake divorati in un pugno. Visione intensa ed effimera, che dura quanto dura lo spettacolo, per chi crede che un uomo stia sia in piedi che nel letto, che una moka serva litri di caffè o che una pianta prepari la colazione sa di magia (gli «ooohhh» del pubblico e le bambine e i bambini che al termine vorrebbero smontare il giocattolo per sapere com’è che funziona); chi ha la fantasia atrofizzata, per dirla con Benjamin, è curioso invece dei numeri che seguono ai numeri e applaude gli interpreti (Jacomo Maria Bianchini e Rocco Manfredi) – tra mimo, clownerie e acrobatica: «bravi, no?» mi chiede una signora all’uscita – mentr’io ho amato i residui, i difetti: il lampadario che cala prima d’un millesimo svelando che verrà colpito tra un attimo, la botola del materasso intravista due volte, il buio tardivo che mostra l’attore che s’affretta a prendere posto; il terriccio caduto dalla pianta, le piume volate dal cuscino, un fiammifero scappato alla scatola e che resta per tutto lo spettacolo ai bordi del letto. Sono come il trucco slabbrato che Ripellino nota ai lati della bocca d’un pagliaccio romano prima di una capriola, e mi ricordano che il teatro, questa cosa fatta dagli uomini per gli uomini, infine non conosce la perfezione. Per fortuna. (Alessandro Toppi)
Visto al Teatro Area Nord. Ideazione e scrittura di Rocco Manfredi e Alessandra Ventrella, regia di Alessandra Ventrella, con Jacopo Maria Bianchini e Rocco Manfredi, luci di Alessandra Ventrella, sostegno logistico Cie Les Karnavires, produzione DispensaBarzotti
#Roma
ANONIMASEQUESTRI (di Leonardo Tomasi)
C’è un regista sardo laureando al DAMS, poi due attori trentenni in cerca di ruolo e un ostaggio incappucciato. C’è una telecamera che riprende live ma in lieve differita, c’è un tavolo di lavoro, due birrette e due tipici berritas. C’è anche una nonna, che compare in delle foto segnaletiche e in un video messaggio. È tutto nello spettacolo anonimasequestri, in cui a essere sequestrato è il pubblico da un gruppo, poco organizzato, di banditi che come riscatto chiedono la loro stessa identità. Vincitore del Premio Scenario 2023, il lavoro è una drammaturgia maleducata (e meno male!) che ibrida il linguaggio scenico con incursioni cinematografiche, battute dai toni “pulp” à la Quentin Tarantino, di cui riconosciamo l’influenza stilistica sin dall’inizio e poi dichiarata in un divertente mash up teatrale in dialogo con Mr. Blonde de Le Iene. Il brano Stuck in The Middle with You, che nel film fa da memorabile colonna sonora, diventa qui sul palco emblematico della condizione di questi trentenni, stuck/bloccati alla ricerca di un’identità che sia il più possibile lontana dall’«antica terra brulla di Sardegna», dai nuraghe, dai culargiones, dalle maschere dei Mamuthones e Issahoderes, e pure dall’Anonima Sequestri di Graziano Mesina. Anche se a volte la scrittura si compiace in dei passaggi ridondanti, che la fanno attorcigliare sul già detto creando una sorta di litania, il lavoro fa emergere il grottesco di questa ricerca/sequestro/riscatto creando - grazie proprio ai riferimenti cinematografici, giornalistici e televisivi delle serie poliziottesche - una sovrapposizione di piani del racconto e di senso in cui la strenua rivendicazione politica decade, messa in crisi da una sequenza ritmata, incessante, di gag comiche. Tra tutte, l’espressione “tipicamente sarda”, un po’ superba, anche menefreghista, del tecnico luci Alessandro è un perfetto contraltare mimico, e sinceramente identitario, che si contrappone alle velleità confuse del regista e dei due attori. (Lucia Medri)
Visto al Centrale Preneste Teatro per la rassegna YOU. The YOUng City – I grandi racconti Under 35: con Federico Giaime Nonnis, Daniele Podda, Leonardo Tomasi e un ostaggio, dramaturg e assistente alla regia Sonia Soro. Il lavoro è stato sviluppato in residenza presso Teatro Due Mondi, è una produzione Teatro di Sardegna e Teatro Metastasio di Prato e Vincitore Premio Scenario 2023. Foto Impresa sociale Nuovi Scenari (Agostino D'Antonio)
VANITAS (di G. Giannini, F. Novembrini, R. Racis)
Giovanfrancesco Giannini, Fabio Novembrini e Roberta Racis firmano Vanitas, che definiremmo un’“installazione figurativa”, la cui scrittura coreografica è assolutizzata in una successione di pose lentissime, nette, a tratti pornografiche - per l’esibizione sfrontata di bocca, lingua e fondoschiena – che tendono all’immobilismo, per bloccarne la bellezza giovanile in un’eterna immanenza. Per questo è attraente l’inserimento, quasi fosse un quarto interprete, di una mini videocamera che come uno specchio passa di mano in mano imprimendo la gestualità filmata su di un dispositivo che rende quella stessa immagine riproducibile tecnicamente. Bellezza e Piacere, Disinganno e Tempo, sono gli altri protagonisti, assenti in scena ma la cui essenza è proiettata sullo sfondo nei quadri di nature morte e nei telegrafici estratti da Il trionfo del tempo e del disinganno, libretto del cardinale Benedetto Pamphilj, poi musicato nel primo oratorio di Händel. Le pose scelte, la nudità, e i costumi – una sorta di specchio riflettente che copre il corpo seminudo di Racis, una gorgiera a circoscrivere il volto di Novembrini e una tuta e sneakers a svelare la figura di Giannini – completano, profanandola però, la sacralità dei quadri Santa Maria Maddalena di Mattia Preti e Vanitas, Putto con teschio, specchio e civetta del Guercino. Il lavoro si fruisce con lo stesso atteggiamento con cui si visiterebbe una mostra, e in alcuni momenti non nascondiamo un vago senso di noia, ciononostante Vanitas crea una conturbante e voyeuristica fascinazione, stimolando la sensorialità: inebriante il quadro scenico con l’altare di fiori recisi che investono di profumo le prime file. Progressivo è invece il disegno luci che illumina in tagli obliqui, orizzontali e laterali l’ultima scena, a indicare lo scorrere del tempo in un’indefinita infinitezza, tanto da lasciare il pubblico indeciso su quando iniziare a applaudire. Non avere certezza della fine dello spettacolo, ma viverla, è un tranello formale e contenutistico curioso, funzionale a scardinare con ironia la seriosità del progetto. (Lucia Medri)
Visto al Teatro Biblioteca Quarticciolo per la stagione danza di Orbita Spellbound: un progetto di Giovanfrancesco Giannini, Fabio Novembrini, Roberta Racis, direzione tecnica e light design Valeria Foti, progetto sonoro Samuele Cestola, foto e video Luca Del Pia, produzione Körper-Centro Nazionale di Produzione della Danza, coproduzione Santarcangelo Festival, Théâtre L’Aire Libre, St Jacques de Lande, Le Joli Collectif con il sostegno di Primavera dei Teatri Castrovillari, Centro di Rilevante Interesse per la Danza Virgilio Sieni, Fattoria Vittadini, Istituto Italiano di Cultura di Parigi nell’ambito di R.O.M -Residencies On the Move di Théâtre l’Aire Libre -le Joli collectif in collaborazione con La Balsamine (Belgio), Santarcangelo Festival (Italia), Le Grütli (Svizzera), Théâtre Prospero e Teatro Periscopio (Canada) rete finanziata dall’Unione Europea
#BOLOGNA
MARIO E MARIA (di Natalia Vallebona e Faustino Blanchut)
L’intuizione che avevamo da piccoli che un nome potesse influenzare la personalità pare confermata da alcune ricerche scientifiche. Avere un nome comune favorirebbe l’adattività psicologica e sociale, aumenterebbe persino le possibilità di essere assunti. Mario e Maria partono dunque avvantagiat* nel gioco dell’esistenza, che in fondo è tutta una grandiosa questione di adattamento. Come in Italia, anche in Belgio nascono molte Marie: 1,05 al giorno, secondo una ricerca dell’Istituto di statistica intercettata dai Poetic Punkers, collettivo internazionale nato a Bruxelles nel 2014 e diretto da Natalia Vallebona e Faustino Blanchut – chissà se il gruppo conosceva la commedia protofemminista omonima di Lopez Sabatino, drammaturgo e critico teatrale italiano, del 1916. Mario (Blanchut) è un autore, un regista, un coreografo, un mini-dittatore della scena e della vita domestica. II suo autoritarismo fatto di romantici diktat produce una sequenza di indicazioni sceniche rivolte a un altro Mario (Florian Vuille) e a due Marie (Julia Färber Data, Marianna Moccia), che allo schioccare delle dita animano la scena con una gestualità circense sospesa tra danza e dramma. Muoiono, sputano, si baciano. Corrono, risorgono, dilagano in platea battezzandoci Mari e Marie. Si regalano e ci regalano rose finte, senza odore – a rose is a rose is a rose: l’evidenza simbolica dell’amore che cancella l’amore scimmiottandolo. Mario è pieno di spunti, ma lontano da ogni forma di verità: il suo autoritarismo, che ricorda il sadismo à la Rezza-Mastrella, è obbedienza cieca alle convenzioni del dire e del fare (teatro). È possente nella gestualità da domatore, ma incapace di consequenzialità. Quando infine pare rivolgerci parole franche, chiedendoci se da piccoli avessimo anche noi un giardino e un albero del cuore su cui arrampicare, ci irride smascherando la vezzosità borghese del possedere l’albero e il giardino. La sclerosi di ogni possibile significato, magnificamente veicolata dai due Mario e dalle due Marie in un ipnotico crescendo di idiomi e linguaggi performativi, sposa causticamente commedia e tragedia, regalandoci abbondanti risate e una profonda amarezza nel riflesso della nostra incapacità congenita a gestire il potere. Un lavoro magistralmente prepolitico. (Andrea Zangari)
Visto all’Arena del Sole – Sala Thierry Salmon, scrittura testo Natalia Vallebona e Faustino Blanchut, coreografia e regia Natalia Vallebon, drammaturgia Faustino Blanchut, con Faustino Blanchut, Julia Färber Data, Marianna Moccia, Florian Vuille, drammaturgia sonora Patrick Belmont, disegno luci Christophe Depr, scenografia e costumi Natalia Vallebona, fotografia e video Bartolomeo Lapunzina, produzione Poetic Punkers ASBL, coproduzione Théâtre Les Riches-Claires, Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, con il sostegno di La Maison des cultures de Saint-Gilles, ADLIB’S Attic, Centre Culturel de Chénéé, nell’ambito di CARNE focus di drammaturgia fisica
#PALERMO
TERRA MATTA (regia di Vincenzo Pirrotta)
Terra Matta è il titolo dell'autobiografia di Vincenzo Rabito, bracciante originario di Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa. Dal 1968 al 1975, questi ha battuto a macchina la storia della propria esistenza, avvalendosi di un proprio linguaggio originale: un groviglio di parole e glifi per mezzo dei quali l'autore, non alfabetizzato, ha descritto la propria «maletratata e molto travagliata e molto desprezata» vita. Vincenzo Pirrotta la porta in scena in un omonimo spettacolo, prodotto dal Biondo di Palermo e dallo Stabile di Catania. Nelle intenzioni l'obiettivo era quello di valorizzare gli aspetti più grotteschi del "romanzo", sciorinando una teoria di personaggi farseschi e richiamandosi al teatro dadaista. Ora, Vincenzo Pirrotta è senz'altro un interprete di significative capacità attoriali, sia nell'eloquio che nel gesto: ritmo ed espressione conservano intatta la lezione di Cuticchio. Ma questo non è stato sufficiente a garantire l'efficacia del suo Terra Matta, dove l'esperienza linguistica di Rabito si risolve nel susseguirsi di episodi in cui prevalgono la caricatura e, talvolta, i facili sentimentalismi. Certamente Pirrotta riesce a rendere teatrale un linguaggio davvero impronunciabile, tormentato da scelte grammaticali non convenzionali anche dal punto di vista grafico; ma mel macchiettismo non sempre convincente dei protagonisti, l'asprezza agreste di Rabito si perde in un sorriso troppo ammiccante e sornione. La farsa ha trovato espressione in una comicità di situazione non sempre adeguata alla cruda asperità del testo; la fedeltà ad esso non ha saputo reggere a eccessi didascalici, nonostante le soluzioni sceniche volessero forse scongiurare proprio questo rischio. Dove ci aspettavamo la rottura, abbiamo trovato un racconto più lineare e rassicurante del dovuto.
Visto al Teatro Biondo, Crediti: Dall’omonima autobiografia di Vincenzo Rabito (Einaudi editore) adattamento teatrale, scene e regia di Vincenzo Pirrotta musiche originali Luca Mauceri costumi Francesca Tunno luci Antonio Sposito con Vincenzo Pirrotta, Lucia Portale, Alessandro Romano, Marcello Montalto e con Luca Mauceri (percussioni, elettronica, chitarra classica), Mario Spolidoro (organetto, chalumeau, chitarra), Osvaldo Costabile (violino, violoncello) aiuto regia Nancy Lombardo direttrice di scena Valentina Enea coordinatore dei servizi tecnici Giuseppe Baiamonte fonico Mauro Fontana macchinista Alberto Mangiapane capo sarta Erina Agnello produzione Teatro Biondo Palermo / Teatro Stabile di Catania. Foto di Rosellina Garbo.
MOLLY BLOOM. ANATOMIA DI UNA (ANTI) EROINA (di Serena Ganci e Daniela Macaluso)
«E sì dissi sì voglio sì». La Molly Bloom di Daniela Macaluso ha una voce di velluto ruvido, rotonda, ma con vaghi accenni di spigoli. Una voce che è corpo, o forse un corpo talmente presente da essere dotato di una voce propria. In Molly Bloom. Anatomia di una (anti) eroina, la protagonista è un grumo inestricabile di carne e spirito, così come l'autore dublinese l'ha offerta al lettore. Ma qui non abbiamo parole scritte. Il flusso di coscienza si insinua in Macaluso, o forse è lei a imporsi su di esso, in un legame carnale indissolubile. Macaluso non è nuda, in scena; ma è come se lo fosse: impone con assoluto coraggio lo spessore della propria persona, plasmandosi una dimensione palpabile, fisicamente compresa tra la sua Molly e il pubblico. Davvero, a una delle donne più "corporee" di sempre, viene fornito un corpo; coraggio, si diceva. Spesso questa parola è usata a sproposito. Ma qui davvero sentiamo di doverla scomodare. È coraggioso il modo in cui Macaluso offre al pubblico una forza che è anzitutto esposizione della fragilità; è coraggioso il suo ritratto di una donna che si vive nel suo vivere il sesso, ma nell'incertezza sbigottita di cosa questo davvero significhi. D'altronde, non si cerca senso, né soluzioni: Molly descrive incontri ai quali partecipa con adesione e distacco, afferrando di questi quanto le viene consentito dall'incontro epidermico tra i corpi. Tutto le scorre addosso: relazioni, matrimonio, maternità, sempre in quell'unico atto che è carne e parola; parola enfatizzata da un'eco sintetica, quella di Serena Ganci, i cui interventi smorzano l'assoluta solitudine della protagonista in sonorità rarefatte. Ne accompagnano la bella misura dei gesti, che scivolano l'uno sull'altro in un flusso di corpo e coscienza. Sfida importante, quella di avanzare un femminile privo dei facili schematismi a cui spesso oggi si ricorre, sostituendovi piuttosto un'elegia malinconica e dura, fatta di membra, ferite e voce. Se la sfida era questa, è stata pienamente vinta.
Visto a Spazio Franco. Crediti: Liberamente ispirato all’Ulisse di Joyce, Di e con Serena Ganci e Daniela Macaluso, Musiche originali Serena Ganci, Luci Gabriele Gugliara, Consulenza costumi Mariangela Di Domenico, Produzione Babel e Sardegna Te