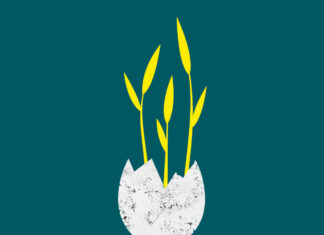Durante il focus dedicato dal Teatro della Toscana alla storica formazione, abbiamo ripercorso con Andrea Renzi alcuni momenti della storia di Teatri Uniti. Intervista

Nel 1987 tre compagnie che avevano contraddistinto lo scenario teatrale nazionale degli anni Settanta – Falso Movimento di Mario Martone, Teatro dei Mutamenti di Antonio Neiwiller e Teatro Studio di Caserta, guidato da Toni Servillo – si uniscono in un laboratorio permanente di produzione: nasce così Teatri Uniti, la storica formazione alla quale il Teatro della Toscana ha dedicato nel mese di aprile un focus con spettacoli e proiezioni. A margine di questa rassegna – che ha visto alternarsi sui palcoscenici del Teatro della Pergola e del Teatro Niccolini, tra gli altri, Enrico Ianniello e Licia Maglietta, Tony Laudadio e Salvatore Cantalupo – abbiamo incontrato Andrea Renzi. Regista, attore teatrale e cinematografico, tra gli interpreti della Trilogia della villeggiatura firmata da Servillo così come de L’uomo in più diretto da Paolo Sorrentino, Renzi ha ripercorso con noi alcuni momenti della storia di Teatri Uniti.
Vorrei iniziare questa conversazione da Fuochi a mare per Vladimir Majakovskij, spettacolo, da Lei diretto e interpretato, che ha portato in scena in questi giorni al Saloncino del Teatro della Pergola e che tuttavia debuttò nella sua forma originale nel 1992. Cosa significa rimettere in scena oggi questa creazione?

Fuochi a mare per Majakovskij fu presentato a Ferrara nel 1992 come reading per una società di poesia diretta da Renato Carpentieri, e soltanto l’anno successivo è diventato uno spettacolo vero e proprio. Per me questa creazione costituisce un nucleo primario: prima ancora di questa lettura utilizzai infatti, nell’estate del 1986, una parte de La nuvola in calzoni per presentarmi al seminario tenuto da Jerzy Grotowskij a Pontedera. Avevo 23 anni, e a 22, stessa età alla quale Majakovskij ha scritto La nuvola in calzoni, ero incappato in questo poemetto e mi ero immedesimato nella forza prorompente del suo autore: ne scelsi una parte e la presentai in quell’occasione soprattutto perché mi consentiva di unire il lavoro sulla parola, che stavo iniziando ad affrontare in quel momento, al lavoro che avevo svolto durante gli anni di Falso Movimento, e che fondava la propria pratica in maniera più incisiva sul corpo e sulla gestualità. Ogni replica di questo spettacolo implica il riconsiderare il mio lavoro sul linguaggio dell’attore, e ritrovare in esso elementi di interesse: il lavoro sul corpo e sulle slogature – non soltanto poco naturalistico, ma infiammato da un’idea di futurismo e di cubismo, di distorsione di alcune parti del corpo e del volto – è una cosa che mi nutre. In questo periodo l’attore, schiacciato da questioni di sopravvivenza creativa, nutre poco gli elementi di ricerca del proprio linguaggio: ma questo lavoro mi è prezioso perché continua a dare linfa a questo aspetto.
Lo spettacolo è anche un punto di osservazione particolare su come viene percepito Majakovskij oggi, e su ciò che Majakovskij, volente o nolente, rappresenta: le questioni dell’ideologia, dell’ex Unione Sovietica… Le persone che hanno la mia età o qualche anno di più lo inquadrano ancora come “Il poeta della Rivoluzione”. Eppure si tratta di un aspetto fortemente costruito a tavolino da Stalin: in A piena voce, l’ultimo poema che Majakovskij ha scritto, riconosce già la Rivoluzione come un regime, ne ha già sentito i morsi. Per un periodo decisi di non mettere più in scena lo spettacolo, perché sembrava che stessi portando avanti un messaggio di veterocomunismo: un modo di osservare la poetica di questo grandissimo scrittore profondamente miope. Ho ripreso lo spettacolo due anni fa, per tre settimane, all’Argot, un piccolo teatro di Roma, ed è stato qui che ho avuto la sensazione che il pubblico ricevesse un paio di ceffoni molto salutari da parte di Majakovskij. La sua è una poesia che, senza rinunciare alla ricerca linguistica, dice a chi la ascolta «Io ho trasformato le cose, io ho trasformato la realtà. Si può fare. Fallo!». L’utopia contenuta nel suo tentativo di trasformare la realtà, gli slanci, la tenerezza, la rabbia, tutti questi aspetti tenuti insieme dal suo linguaggio poetico e dalla sua persona, possono ancora arrivare al pubblico.
Qual è il progetto artistico di Teatri Uniti adesso, e in quali modi si stanno sviluppando una sua filiazione e una sua eredità?

Sono molto contento di questa panoramica su Teatri Uniti a Firenze, perché credo che sia un bene poter mettere a fuoco l’attività di una factory – per usare il termine di Warhol – la cui idea è stata quella di far convivere persone e creatività diverse. E credo che sia importante perché mi sembra invece che questo periodo sia dominato da un individualismo fortissimo. È chiaro che le spinte individuali sono importanti, e che le ambizioni hanno sempre nutrito tutti i territori artistici, in particolare probabilmente quello dello spettacolo, ma il teatro e il cinema, con la loro natura di lavori di gruppo, impongono che si abbia la consapevolezza di come un’officina di artigianato scenico possa moltiplicare la forza creativa dei gruppi.
Rispetto alla questione della filiazione, essa è sempre avvenuta in maniera molto naturale: è sempre nata da collaborazioni artigianali. In Il desiderio preso per la coda, da Picasso, Mario Martone invitò a lavorare come attore Antonio Neiwiller; in Ritorno ad Alphaville ha chiamato Toni Servillo. La collaborazione è nata attraverso una conoscenza: non un incontro a tavolino determinato da esigenze di politica culturale, ma un incontro attraverso il teatro. Questa cosa è poi accaduta di nuovo: per esempio, io ho lavorato molto con Tony Laudadio ed Enrico Ianniello negli anni passati, abbiamo dato vita a una sorta di studio – nel senso stanislavskijano – all’interno dell’attività di Teatri Uniti. Credo che la cosa migliore di questo sistema di filiazione e allargamento sia quest’idea di laboratorio, di comunicazione attraverso il linguaggio del teatro, di conoscenza sul campo. Le persone più giovani guardano a noi come una realtà in qualche modo positiva, da imitare, però mi sembra che la situazione per chi sta cominciando oggi sia molto diversa: questo forte individualismo, per il quale sembra prevalere il modello del talent show, è per me un errore strategico. Perdere l’idea del lavoro di équipe significherebbe perdere l’eredità del teatro degli anni ’60 e ’70, poi passata attraverso i gruppi successivi che hanno lavorato negli anni ’80. Ci sono modi diversi di coniugare quest’idea di lavoro di équipe, sempre presente anche in esperienze teatrali distanti dalla mia ma alle quali guardo con grande rispetto. Insomma, l’importante è non ballare da soli. Ecco, questa è un’eredità che mi piacerebbe consegnare, in qualche modo.
Qual è la sua posizione rispetto alla situazione teatrale locale, quindi di Napoli e della Campania, e a quella nazionale?

Credo che ci sia una questione più vasta, una questione culturale. Io sono sicuro che come attore, a volte regista, come persona che fa teatro o anche cinema mi avvantaggerei di un mutato clima culturale. È evidente, è stato detto in tutte le salse: c’è stato un abbassamento del livello culturale, e chi opera nella cultura deve rispondere a questo fatto storico. Giorni fa ho incontrato gli studenti del Liceo Classico Genovesi – una scuola vivace, attiva, del centro storico napoletano – e raccontavo ai ragazzi di quando ho visto in prima serata a tredici, quattordici anni, tutto il teatro di Dario Fo, su Rai 2, insieme a mia mamma. Lei non voleva che facessi l’attore, e ancora era di là da venire questa cosa, però si guardava Dario Fo in famiglia, perché Rai 2 lo trasmetteva in prima serata. Le mie scelte sono state completamente diverse, non posso dire che Fo sia stato un punto di riferimento per quello che ho fatto io, ma il fatto di poterlo vedere, di rimanerne colpito a quell’età, di accedere alle sue opere così facilmente… Lo so che è un po’ utopistico, ma cambiare il clima culturale varrebbe più di una riforma teatrale.
Teatri Uniti ha, o in passato si è identificato, con uno spazio fisico?
No: noi in realtà non abbiamo mai avuto un teatro, tranne per un periodo a Santa Maria Capua Vetere, dove con la compagnia di Enrico Ianniello e Tony Laudadio, Onorevole Teatro Casertano, e facendo seguito a un progetto legato dell’ETI sulle aree disagiate, risiedemmo in questo teatro abbandonato, bellissimo, il Teatro Garibaldi. Dopo una ristrutturazione molto semplice, ricorrendo a tavole di compensato per non fare entrare il freddo dalle finestre rotte, riaprimmo questo teatro, e lì siamo stati tre, quattro anni. Utilizzavamo quel teatro per le prove, per i debutti, lì abbiamo provato Tartufo di Toni Servillo, spettacoli importanti che poi hanno girato in Italia e all’estero. Quello è stato l’unico momento in cui abbiamo avuto una sede, un luogo teatrale. C’è sempre stato al nostro interno un acceso dibattito sull’avere o il non avere un teatro, ma certamente il non averlo avuto è qualcosa che ci ha permesso anche di mantenerci più leggeri, nel senso migliore del termine. Può anche schiacciare una compagnia, il dover occuparsi di programmazione, di questioni burocratiche.
L’ultima domanda: quali sono i suoi progetti futuri?
Adesso abbiamo un progetto di teatro, che spero si realizzi, con il Napoli Teatro Festival: un lavoro sul servo, diretto da Pierpaolo Sepe, insieme a un compagno di strada, un grande amico come Roberto De Francesco. Stiamo facendo un po’ di scongiuri, ma dovrebbe essere la nostra prossima creazione.
Alessandro Iachino
Leggi anche Simone Nebbia sul focus dedicato alla compagnia lo scorso anno dal Teatro Vascello con la recensione dello spettacolo I giocatori di Enrico Ianniello